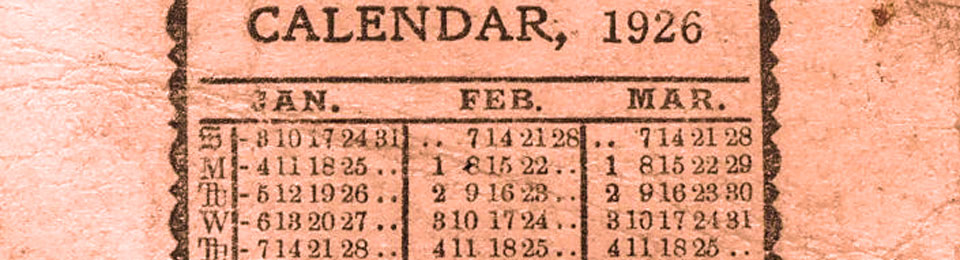
Antonio Canovi
Les mémoires des enfants, le memorie dei figli, è il titolo della giornata bilingue di studi organizzata a Lyon lo scorso 21 maggio dalla École normale supérieure, con il concorso del locale Istituto Italiano di cultura.
Lo scopo era quello di rileggere il decennio degli anni ’70 (ma dal punto di vista francese la referenza principe rimane il maggio ’68) in una prospettiva comparata fra le tre esperienze di Italia, Francia, Germania. E proprio l’Italia ha costituito il principale banco di prova con il quale confrontarsi, ieri per la persistenza di un’area di militanza eversiva, oggi per una dinamica editoriale che non trova pari negli altri paesi, soprattutto sul versante della narrazione memorialistica e autobiografica.
È stato così domandato agli studiosi invitati di riflettere a partire da un approccio che affonda esplicitamente – come recita il sottotitolo in italiano: “eredità rivelate nella narrazione presente degli anni ’70” – in una prospettiva di storia della memoria.
Maurizia Morini, che della giornata è stata la prima ispiratrice, ha introdotto i lavori ponendo l’accento su di una precisa circostanza: a scrivere di anni ’70 sono oggi “perlopiù figlie e figli di protagonisti degli anni settanta, quasi tutti vittime del terrorismo”. Saremmo cioè di fronte al “tentativo di riannodare i fili con il genitore che non c’è più, per raccoglierne l’eredità e trasmetterla”. Su questo piano inclinato – dove “inevitabilmente privato e pubblico s’incontrano”, mentre “le vicende personali s’intrecciano alle analisi storiche” – Giovanni De Luna è intervenuto formulando un’indicazione programmatica molto netta: “più storia, meno memoria”.
La memoria cui si riferisce tanto criticamente De Luna è quella “ufficiale”, in quanto frutto “straripante ed elefantiaco” – per citare le sue parole – del combinato disposto tra un’incessante attività legislativa (il florilegio delle giornate del ricordo) e la grancassa delle agenzie mediatiche. Ma ciò che risulta inaccettabile allo storico torinese – autore per i tipi della Feltrinelli di un recente volume in argomento, intitolato “Le ragioni di un decennio” – è l’instaurarsi di una relazione inversamente proporzionale tra affollamento memoriale e qualità della ricerca storica. Peggio, saremmo di fronte all’uso stereotipato della storia, reiteratamente e proditoriamente interpellata a puntellare gli assiomi via via formulati all’interno del recinto politico. Se tale deriva presenta ormai il carattere di un fenomeno globalmente diffuso, in Italia veste le sembianze di una virulenza affatto speciale, a generare e a contrapporre tra loro il tale piuttosto del talaltro giorno del ricordo. Allo storico consterebbe dunque il diritto-dovere di una riflessione condotta sul piano “civile” della meditazione critica, che sappia confrontarsi con le contingenze evenemenziali senza farsene strumento di parte.
Sulla contrapposizione stereotipata tra storia e memoria è ritornato Luca Pes, ma in qualche modo rovesciando i termini della questione. L’afasia narrativa che circonda quegli anni sarebbe cioè propria dei “protagonisti” – e tra questi, degli storici che ne furono coevi – mentre oggi ci troviamo immersi in un fenomeno espansivo di narrazione filiale. Non solo, si tratta di un numero cospicuo di titoli, ma alcuni tra questi hanno registrato un notevole successo. Prova ne è il fatto che libri come quelli di Mario Calabresi, che ha svolto un po’ la funzione di “capostipite” (Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo, Mondadori, 2007) e di Benedetta Tobagi (Come mi batte forte il cuore. Storia di mio padre, Einaudi, 2009) si trovano capillarmente non solo nelle librerie ma nelle biblioteche pubbliche. Sono libri, sottolinea Pes, nei quali vi sono in realtà elementi solidi di ricerca storica, e su entrambi i versanti della storia della memoria (le interviste a protagonisti e familiari) e della storia indiziaria (la visione delle carte dei processi). Basti ricordare, tra i titoli che hanno trovato una certa fortuna editoriale, quelli scritti da Sabina Rossa con il giornalista Giovanni Fasanella (Guido Rossa, mio padre, Milano, Rizzoli, 2006) e da Umberto Ambrosoli (Qualunque cosa succeda. Giorgio Ambrosoli oggi nelle parole del figlio, Milano, Sironi, 2009).
Alla congenita incapacità a “narrare” storiograficamente quegli anni, si è così venuto affiancando un vero e proprio genere letterario “memorialistico” che – si faccia attenzione – trascende di fatto nel campo storico. Sotto due aspetti che sono complementari, se non proprio consequenziali: l’instaurarsi, per riprendere una categoria utilizzata nel corso del seminario, di un paradigma “vittimario”; l’inscriversi della narrazione di memoria in un verosimile “lavoro del lutto”.
Se nel 1982 l’intervista di Licia Rognini Pinelli con Piero Scaramucci usciva come libro di controinformazione (Una storia quasi soltanto mia, Mondadori), nel 2009 è stata riproposta per i tipi della Feltrinelli con un titolo (Una storia soltanto mia: il racconto della vedova Pinelli: dalla nascita di un amore nella Milano degli anni Cinquanta alla tragedia di una morte che ha segnato la storia d’Italia nel 1969) che stabilisce esplicitamente una correlazione tra la vicenda privata e la storia nazionale. Il valore della denuncia rimane intatto e persino si acuisce, ma sembra ora ascriversi – con la perdita dell’avverbio – al genere della “vittima” che, sola e innocente, domanda un risarcimento di fronte alla Storia.
Trattandosi di Pinelli, un tale esito assume un valore simbolico che costringe ad interrogarsi sul corto circuito nel quale è rimasta presa la società italiana, tra verità e giustizia, tra memoria e storia. Come ebbe a commentare la vedova, di fronte all’archiviazione della morte del marito per “malore attivo”: “uno Stato che non ha il coraggio di riconoscere la verità è uno Stato che ha perduto, uno Stato che non esiste”. Così, 30 anni fa, Licia Pinelli fece il suo duplice gesto di protesta. L’uno solenne, con i resti del marito traslati dal Musocco all’angolo del cimitero comunale di Carrara dedicato agli anarchici, perché là tra i compagni di lotta il ricordo “sarebbe rimasto sempre”. Ne seguì un secondo, la parola del lutto finalmente ritrovata dopo “aver dormito” per una decina di anni, immaginandosi una “rispondenza” di sentimenti con il solo pubblico nel quale possa riconoscersi: “Le donne sono quelle che subiscono sempre quel che capita a figli, mariti, amanti, oltre che a loro stesse. Si possono mettere nei miei panni, capire”. Trascorso il tratto di un’intera, nuova generazione, non arrivando quel risarcimento cui pure Licia all’inizio aveva creduto – la possibilità di riaprire un dibattimento pubblico sulle circostanze di quella caduta mortale – quella storia è diventata “soltanto mia”. Vero che c’è stato, fermamente voluto dal presidente della repubblica Giorgio Napolitano, l’incontro congiunto con la vedova Calabresi. Ma il sentimento d’ingiustizia rimane: Giuseppe entrò di sua spontanea volontà in Questura e vi rimase sotto fermo in condizioni di illegalità (tre giorni, senza l’assistenza di un avvocato), per uscirne in coma. I famigliari poterono vederlo solo a morte avvenuta. Nonostante le circostanze ambientali, di non libertà personale nei movimenti, la sola responsabilità accertata per quella morte è stata ascritta alla vittima medesima. Quella di Pinelli, insomma, rimane un’eredità “velata”.
Ma se là si tratta di una moglie, o nel caso di Valerio Verbano entra in scena il racconto di una madre (Carla Verbano e Massimo Capponi, Sia folgorante la fine. In un giorno di febbraio degli anni di piombo. Valerio muore assassinato a casa sua. La madre cerca ancora la verità, Rizzoli, 2010), è la figura del figlio e della figlia “in cerca” del padre a contrassegnare la stagione editoriale dell’ultimo lustro. La risoluzione di ogni conflitto a carattere pubblico nei termini di storia della famiglia risponde, notoriamente, ad un riflesso familistico nazionale. Eppure, come ha acutamente osservato Pes, c’è in questo lavoro del lutto un risvolto metaforico che attende di essere interpretato e impugnato come una leva politica nell’Italia del tempo presente. Se i figli e le figlie cercano di riappropriarsi dei padri nella loro interezza, allora, potremo farlo anche noi, trovando un esito alla contrapposizione stereotipata tra terrorismo e antiterrorismo.
La condizione necessaria – è stato l’oggetto della relazione di Antonio Canovi – è che gli storici trovino i modi e affinino gli strumenti per assumere come proprie fonti queste “narrazioni di famiglia”. E un buon esempio analitico lo ha fornito Ilaria Vezzani, rileggendo in forma comparata i libri di Benedetta Tobagi e Sabina Rossa.
Sul medesimo registro – di un piano narrativo che incrocia memorie familiari, costruzione della memoria collettiva, discorso pubblico – hanno proseguito i due interventi dedicati al caso tedesco. Non certo a caso, entrambe le studiose – Katrin Raeshe e Anne Lagny – hanno rivolto la propria attenzione alla figura “scandalosa” di Ulrike Meinhof, nella restituzione controversa che ne fornisce la figlia Bettina Röhl.
Un cambio sostanziale di piano c’è stato con gli interventi – Julie Pagis, Xavier Vigna – dedicati all’esperienza della Francia. Qui l’eredità messa a nudo riguarda sostanzialmente figli e figlie i cui padri non sono stati perduti biologicamente ma che, tuttavia, mantengono un rapporto fortemente problematico sotto il profilo della trasmissione di memoria. L’approccio francese, in estrema sintesi, presta maggiore attenzione al contesto socio-culturale nel quale questa trasmissione si svolge: dove la categoria fondativa di riconoscimento (e di mancato riconoscimento, seguendo le parole di Virginie Linhart: “I sessantottini ci hanno lasciato il deserto in eredità… Noi figli non abbiamo niente in comune”) fuoriesce dall’ambiente familiare per rispondere al criterio sociologico della generazione.
Le conclusioni, in forma di un elenco di proposizioni aperte – dal rapporto necessariamente mai pacificato tra storia e memoria, agli usi retorici di quest’ultima, ma anche alla conferma che quello italiano, con la ripresa del ’77, continua a rappresentare il “caso” eclatante nell’esperienza dei movimenti di contestazione giovanile in Europa – sono state tratte da Jean-Claude Zancarini et Boris Gobille.


