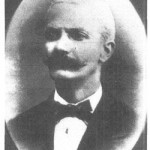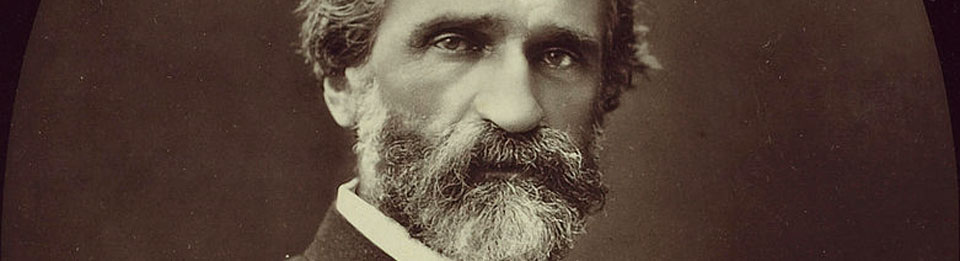
La sera dell’11 Febbraio 1849 si rappresentava in questo teatro, gremito (proprio come oggi) di pubblico, l’opera di Giuseppe Verdi “I due Foscari”; ma gli straordinari avvenimenti politici di quell’anno a ben altro volgevano le menti ed i cuori, in cui serpeggiava un fremito mal celato di aspettazione viva: quand’ecco giungere a un tratto la notizia che due giorni innanzi era stata proclamata in Roma, dall’Assemblea Constituente, la Repubblica Romana. Fu uno scoppio d’entusiasmo, un gridare di evviva, uno sventolare di fazzoletti; e i cantanti, interrotta la rappresentazione, mescolarono i loro applausi e le loro lacrime di gioia a quelle del pubblico festante; ed il baritono Mauro Zacchi, nel costume di doge veneto, lesse il decreto della proclamazione, tra il sùbito silenzio ansioso degli spettatori; ed Augusto Bertoni, poeta e patriota ardente, che morte violenta dovea rapire di lì a tre anni, appiccato all’inferriata della sua cella, dalle carceri papali di s. Michele in Roma (( Augusto Bertoni, esule per le persecuzioni poliziesche a Genova fino dal ‘51, fu attratto nello Stato Pontificio, col pretesto di tentarvi un moto, da un Antonio Catenacci, spia papale, ed arrestato a Civitavecchia. Fu trovato appiccato all’inferriata della prigione, nelle carceri di S. Michele in Roma, il 28 Ottobre 1853, e pare si suicidasse per timore d’esser costretto, dai supplicî della tortura, a compromettenti rivelazioni. )), Augusto Bertoni, dico, da un palco di proscenio, inspirandosi al doge Foscari, improvvisò una poesia patriottica:
Mostra, o Leon di Marco,
La tua tremenda possa,
E all’Aquila rapace
Strappa la polpa e l’ossa.
Finito lo spettacolo, tutti si rovesciarono sulla piazza, dove già era stato piantato l’albero della libertà, ed al suono della Carmagnola ed al canto del Ça ira fu fatto il gran falò degli stemmi papali abbattuti.
Ma la Repubblica Romana, della quale fu degno rappresentante, prima a Ravenna e poi a Forlì, quel preside Francesco Laderchi, tempra adamantina d’uomo e di patriota, alla cui memoria Faenza vuole oggi tributare omaggio di gratitudine, la Repubblica Romana era condannata fatalmente a cadere: ché non solo i suoi onorandi reggitori agitavansi tra le mille crescenti difficoltà delle intemperanze settarie e degli eccessi, fatale conseguenza delle violenze reazionarie dei trent’anni precedenti; sì anche ebbero a sostenere la titanica lotta contro l’Austria, la Spagna, i Borboni di Napoli, la fratricida repubblica di Luigi Napoleone: onde il pugno di eroi, non protetto da intrighi diplomatici, non efficacemente sostenuto nel resto della Penisola da una generale guerra di popolo, fu, come ognun sa, facilmente schiacciato.
Mentre Roma era stretta nella cerchia di ferro del memorando assedio, il maresciallo austriaco conte di Wimpffen minacciava da Ferrara, entrava in Bologna, marciava su la Romagna, respingendo le scarse guardie civiche repubblicane; Francesco Laderchi, rimasto solo al suo posto in Forlì, lanciava i 18 maggio un ultimo appello doloroso, prima di ritirarsi a Roma; e i patrioti fremevano e piangevano al cadere delle simboliche aquile repubblicane e degli alberi della libertà, e spezzavano le sciabole, smontavano i fucili, seppellivano le armi in campagna piuttosto che consegnarle! La mattina del 19, brillando il chiaro sole sull’orizzonte, incominciava il passaggio da porta Imolese a porta delle Chiavi, di 8000 Tedeschi, diretti a Forlì; ed al fianco del maresciallo Wimpffen cavalcava, in uniforme di maggiore austriaco, quell’anima scellerata del rinnegato Virginio Alpi, che alle molte sue vittime liberali dovea aggiungere fra poco il patriota faentino Antonio Liverani, da lui brutalmente fatto moschettare, senza processo, in un (sic) scura notte, sulla via da Foligno a Perugia (( Veggasi a proposito di questo truce assassinio il racconto che ne fa, sulla base di documenti che destano un vero raccapriccio, Alfredo Comandini, Cospirazioni di Romagna e di Bologna nelle Memorie di Federico Comandini etc., Bologna, Zanichelli, 1899, pp. 50-53. )).
Ed il Wimpffen, e l’Alpi, e il pesante rotolar dei cannoni su’ l ciottolato, e le schiere dure e impettite degli Austriaci si ebbero le frenetiche acclamazioni della moltitudine papalina, annidata ferocemente nel borgo d’Urbecco.
Tali le condizioni di Faenza, della Romagna, di quasi tutta Italia, nella primavera del 1849: insufficiente la rivoluzione di popolo; i tirannelli italiani restaurati e protetti dalle potenze conservatrici; la diplomazia sospettosa, nemica, insidiatrice; l’aquila dell’Austria spiccante di nuovo il volo e dispiegante gli artigli sulla Penisola; i rinnegati, i traditori, le spie trionfanti da presso allo straniero invasore e punitore; la plebe, ignorante e superstiziosa, plaudente a’ rinnovellati padroni, come il cane che lambe la mano a chi lo percuote. Era finita; sogni tramontati, speranze deluse, singhiozzi mal repressi nel petto! “Poveri noi, esclamava Federico Comandini, per ora non vi è più nulla da fare; torneremo a cospirare!” (( Cfr. A. Comandini, Cospirazioni di Romagna e di Bologna nelle Memorie di Federico Comandini etc., Bologna, Zanichelli, 1899, p. 210. )).
II.
Dieci anni dopo, la scena è cambiata. Nell’aprile del 1859 l’Italia è nel fervore dei canti di guerra; una serena fiducia, una smania di agire, di scuotere il giogo, di proclamarsi nazione libera e una in cospetto della vecchia Europa attonita, pervadono da un capo all’altro la Penisola.
Come e perché la portentosa mutazione è avvenuta?
In un felice angolo predestinato d’Italia, il figlio di Carlo Alberto ha conservato gelosamente, come in rifugio sicuro, lo Statuto Costituzionale e il Tricolore; il genio di Camillo Benso di Cavour ha fatto del decennio dal ‘49 al ‘59 il periodo classico della rivoluzione italiana; la favilla della libertà non si è spenta nel cuore del popolo, ma ha covato sotto la cenere per divampare in incendio appena spirasse un alito di vento propizio.
Le due teorie politiche che si erano finora contrastato il campo, la federazione monarchica del Gioberti e l’unità repubblicana del Mazzini, eran tramontate: ma l’idea giobertiana avea pur trascinato decisamente la casa di Savoia sulla via della rivoluzione; e l’idea mazziniana ave pur rivelato la virtù e l’anima del popolo italiano a Milano, a Brescia, a Bologna, a Roma, a Venezia. Per questo, mentre il mazzinianesimo puro raccoglievasi nell’intransigenza di pochi, lo spirito dell’austero Genovese pervadeva ugualmente l’Italia, premendo per l’unità, nel tempo istesso che il Gioberti, abbandonata la chimera federale e papale del Papato, lanciava co’ l nuovo libro del Rinnovamento Civile l’idea della rigenerazione da ottenersi con l’annessione al Piemonte; e per questo, anche, gli spiriti si orientano verso la realtà pratica, e nell’opinione dei più grandeggia e sormonta la teoria dell’unitarismo costituzionale con Vittorio Emanuele II, re galantuomo. L’accordo, insomma, della tradizione con la rivoluzione è la formula risolutrice del grave e complesso problema, la ineluttabile legge storica che condurrà su’ l Campidoglio la nuova Italia, realizzando il sogno dei precursori, degli apostoli, dei martiri.
E gli eventi precipitano. Mentre le cospirazioni pazientemente tessono la nuova trama, ma fallisce nel ’53 l’ultimo serio tentativo dei repubblicani a Milano, il Cavour pensa ed attua una stupenda opera di diplomazia, di prudenza, di propaganda, persuadendo, istigando, avvolgendo come in una fitta rete il suo re coraggioso e cavalleresco, il popolo d’Italia, il novello imperatore Napoleone III, le corti e i governi d’Europa, senza mettere il piede in fallo una sola volta; e ciò che l’Europa non avea mai seriamente creduto, che gl’Italiani, ciò è, fossero atti ad organizzarsi in nazione, diviene nel memorabile decennio a poco a poco persuasione ferma e sincera, sì che quasi si compone dinanzi agli occhi del mondo la visione di un’Italia nuova, quale nessuno avea mai immaginata, non più divisa dalle fazioni secolari, non più in preda alla convulsa vicenda di luce e di tenebre, di sùbite audacie e di spossamenti improvvisi, di ribellioni magnifiche e di umiliazioni fatali, sì bene ordinata e ferma nella coscienza di sé e del suo radioso avvenire.
Ma il geniale uomo di Stato non può dissimularsi che bisogna camminare con circospezione per gl’intricati sentieri della diplomazia. A lui non sfugge che l’imperatore de’ Francesi, il despota del 2 dicembre, è una mente utopistica in cui si confondono vaghi ideali di democrazia cesarea con impetuose ambizioni di avventuriero, sogni di missione napoleonica per l’indipendenza delle nazioni con ataviche smanie di dominio, balenanti ricordi del grande impero del primo Bonaparte; né anche sfugge all’acuto ministro di re Vittorio che Napoleone III ha per l’Italia ripreso l’animo e i disegni del suo grande zio, ossia vuol cacciare dalla Penisola gli Austriaci, sì, per istabilirvi una specie di protettorato francese, ma dare all’Italia l’unità e Roma capitale mai, perché uno Stato unito e forte al confine della Francia sarebbe un pericolo perenne, e perché egli non può disgustare i clericali francesi che gli puntellano il trono. Ed il Cavour sa anche che il sire napoleonico si troverà presto o tardi compresso e soffocato tra gli opposti elementi dei quali si affanna a mantenere l’equilibrio, e ciò è la democrazia e il dispotismo, i plebisciti e l’impero, le tradizioni carbonare e le necessità politiche createsi co’l criminale colpo di Stato, ossia il giogo clericale, l’egemonia affaristica, la politica d’espansione.
Ed allora il diplomatico astuto, che vuol ottenere a poco per volta quello che le condizioni reali possono concedere, pensa che bisogna senza indugio sfruttar l’ambizione napoleonica del voler sostituire in Italia l’influenza francese al dominio austriaco, senza perdere però di vista l’unità italiana, da raggiungersi gradatamente e lasciandosi magari addietro, per la strada, quell’imperatore inesperto appena accenni a fermarsi.
Ed ecco il governo piemontese cattivarsi l’animo di Napoleone III e le simpatie di Francia e Inghilterra con l’alleanza del 1855 e con la guerra di Crimea; ecco il Cavour porre arditamente nel congresso di Parigi, dal febbraio all’aprile del ‘56, la questione italiana, trascinando seco il plenipotenziario inglese Claredon che, in un colloquio con il Bonaparte, sostiene l’aiuto al Piemonte; eccolo, nel luglio del ‘58, con il convegno di Plombières strappare al dubitante Napoleone l’impegno d’onore dell’alleanza, non importa se a prezzo di un disegno di riordinamento dell’Italia che realizzi le ambizioni del Cesare francese e che sia destinato a calmare le agitazioni clericali con la conferma del dominio temporale dei papi in Roma; non importa se a prezzo del sacrificio di una innocente giovinetta sabauda, promessa in isposa a Gerolamo Bonaparte, cugino dell’imperatore, per sanare il vizio di origine borghese dei parvenus napoleonidi, innestando sul loro tronco troppo recente il più tenero e fresco virgulto della legittimità, colto di sul ceppo antico d’una dinastia autentica che risale a secoli di tradizione gloriosa!
Tutto cede all’imperiosa necessità del momento; tutto impallidisce e scolora dinanzi alla realtà di un primo gran passo decisivo su la via scabrosa della redenzione, quale la cacciata dell’Austria; e del resto il popolo è pronto a spingersi anche più innanzi, e con probabilità di buon successo, quando sia sostenuto da una Potenza vittoriosa e legalmente riconosciuta. Quasi in ogni angolo più remoto delle regioni italiche ove si soffre e si spera, e madri, le spose, le fanciulle preparano coccarde e bandiere tricolori, per distribuirle ai ribelli e sventolarle alla luce del sole non appena giunga “il trionfante suon de la prima italica vittoria” (( Carducci, Piemonte, strofa 16ma. )); Daniele Manin, Giuseppe La Farina, Giorgio Pallavicino hanno fondato nel ‘57 la grande Società Nazionale per propugnare e svolgere il nuovo programma giobertiano dell’unità da ottenersi con la progressiva annessione al Piemonte; ed il piccolo Piemonte è asilo di migliaia di esuli, i quali dalle sparse membra della patria comune vi portano quel grido di dolore che risuonerà nel gran cuore di re Vittorio come nel cuore d’Italia, e che egli, il 10 gennaio del 1859, lancierà arditamente, squillo di guerra e di gloria, contro l’Austria minacciosa. E neanche un prima, il 19 decembre del 1858, lassù allo Zerbino, su gli spalti di Genova, nella casa ospitale del patriota bergamasco Gabriele Camozzi, Giuseppe Garibaldi ha dato al poeta Mercantini l’incarico di comporgli un inno che i suoi volontari debbano cantare muovendo alla carica e ritornando dalla vittoria; ed il 31 di quel mese stesso l’inno è composto, è anche messo in musica dal capobanda della brigata Savoia, Alessio Olivieri, sì che in quella stessa casa dello Zerbino lo cantano, accompagnati al pianoforte dalla signora Mercantini, e lo provano marciando a due a due, a spire per la gran sala, uomini come il Camozzi, il Fiastri, il Migliavacca, Nino Bixio, il Chiassi, il Gorini, Pilade e Narciso Bronzetti, e tanti e tanti altri, uomini maturi e giovani imberbi, nobili e popolani, poveri e ricchi (( Cfr. A Gabriele Camozzi, il 1 novembre 1896, inaugurandosi la lapide apposta dal municipio di Sabbia sulla casa in Dalmine, ove egli morì. Bergamo, tip. Bolis, 1896. )):
Si scopron le tombe, si levano i morti,
I martiri nostri son tutti risorti;
Le spade nel pugno, gli allori alle chiome,
La fiamma ed il nome d’Italia sul cuor.
E la guerra, a preparar la quale Camillo Cavour avea lavorato dieci anni, logorandosi fino a morirne poco dipoi, la fatidica guerra liberatrice scoppia impetuosa e magnifica come una tempesta di maggio. Gli echi di Montebello, Varese, Palestro, Magenta, Melegnano, corrono rapidamente la Penisola: Vittorio Emanuele II e Napoleone III, illuminati dall’aureola della vittoria; Francesi ed Italiani, affratellati nell’ideale delle loro comuni moderne origini rivoluzionarie, entrano trionfatori in Milano; ed allora il fuoco lungamente compresso sbotta e si propaga in aperta ribellione nell’Italia centrale. Questa volta l’Austria, vinta ed umiliata, non potrà farsi strumento di repressione, non soverchierà co’l numero delle sue baionette e de’ suoi cannoni, non punirà co’l bastone e con le fucilazioni, come già avea fatto nel 1820-21, nel ‘31, nel ‘48-’49; questa volta lo spettro di cotesto uccellaccio grifagno, pronto sempre a sostenere i tiranni, le ingiustizie, le infamie, non sovrasta, incubo terribile, agl’innocenti oppressi. E prima la Toscana, la Toscana mite ed arguta, licenzia il 27 aprile il suo Canapone, Leopoldo II di Lorena, ed offre la dittatura a Vittorio Emanuele, che vi nomina regio commissario Carlo Boncompagni di Mombello; poi Parma e Piacenza obbligano il 9 giugno la duchessa Maria Luigia di Borbone a ritrarsi in Mantova, proclamando esse pure la dittatura del re del Piemonte, il quale vi nomina commissario il conte Pallieri, cui succede Luigi Carlo Farini; indi Modena, Reggio e Carrara costringono alla fuga il duca Francesco V, e prima Luigi Zini, poi Luigi Carlo Farini vi hanno l’ufficio di commissari; infine Bologna, Ferrara, le Romagne, Ancona, cacciano i legati pontifici, costituiscono una giunta di governo, ottengono da re Vittorio un commissario nella persona di Massimo Taparelli d’Azeglio. Ma gli sgherri del papa sfogano la loro rabbia bestiale nella Marca e nell’Umbria, e con le stragi orribili di Perugia, vescovo compiacente quel conte Pecci che fu poi papa Leone XIII, aggiungono un’altra pagina d’infamia alle molte che la Storia, inesorabile e vindice, tramanda all’orrore dei posteri.
III.
Come, in particolar modo, andarono le cose in Romagna ed a Faenza? (( Le notizie che seguono sono state raccolte da memorie di contemporanei, o da testimoni oculari ancor viventi; cfr. anche il mio cap. IV del Sommario della Storia Civile di Faenza, in A. Messeri, A. Calzi, Faenza nella storia e nell’arte, Faenza, Dal Pozzo, 1909, pp. 350-362. )). Per bene intendere lo stato d’animo dei Romagnoli, e la preparazione e l’importanza della piccola rivoluzione faentina dei giorni 12-13 giugno 1859, bisogna rifarsi da qualche anno addietro, dal ferreo regime militare austriaco, ciò è, che fino dal ‘50 sostenne con lo stato d’assedio, con gli esilii, con la tortura, con la galera, co’l patibolo, il governo de’ preti. Pur nell’imperversare di cotale reazione, si eran riprese le cospirazioni, costituendosi quel Partito Nazionale Italiano i cui lavori erano diretti da un comitato sedente in Londra, e pubblicamente annunziatosi con un proclama dell’8 settembre 1850, firmato dal Mazzini, dal Saffi, dal Saliceti, dal Montecchi e dall’Agostini. Un’adunanza di rappresentanti di quel partito in Romagna fu tenuta nell’istesso anno all’Orestina, villa detta anche Inquisitora, ch’era del conte Valerio Cattoli, a circa tre chilometri da Faenza, e v’intervenne anche il cesenate Gaspare Finali, oggi superstite glorioso; ma la polizia seppe poi di tal riunione, e ne seguirono arresti, carcerazioni, precetti.
Faenza, a ogni modo, qual punto centrale di comunicazione tra Bologna e il Metauro, fu una delle prime città dove si costituisse un comitato locale, che corrispondeva con gli altri per mezzo di lettere in cifra convenzionale, e del quale i componenti furono il dott. Ercole Conti, l’avv. Luigi Succi, detto il Gobbo di Lugo, Girolamo Strocchi, Gaetano Carboni, Gaetano Brussi, Luigi Gallanti, Vittorio Bosi, il cesenate Federico Comandini, che in questa città era venuto a lavorare da orefice. Sotto la direzione di costoro, adunque, si rannodaron le fila della cospirazione patriottica, alla quale (essendo esuli i più compromessi della Repubblica Romana, e ciò è Ludovico Caldesi a Genova e poi in Isvizzera, Raffaele Pasi in Piemonte e poi a Genova, Vincenzo e Leonida Caldesi in Francia e poi a Londra, Giacomo Bertoni a Nizza) parteciparono qui a Faenza attivamente, preparando armi e munizioni pur sotto il vigile occhio della polizia, Francesco Laderchi (che dopo breve esilio in Toscana avea potuto tornare in patria, pecora segnata, ma non molestato apertamente), Giuseppe Minardi, il conte Giovanni Tampieri, Giovanni Baccagnani, Vincenzo Ubaldini, il conte Benvenuto Pasolini Dall’Onda (che poi emigrò a Genova), Enrico Novelli, il conte Vincenzo Cattoli, Antonio Boschi, Filippo Pezzi, Sante Babini, Augusto Bertoni, il poeta, e tanti altri. E quanto più feroce la repressione, più indomita era la resistenza; il Novelli e il Pezzi furono arrestati, Augusto Bertoni fuggì in tempo a Genova; ma intanto fino dal 27 aprile del ‘51, per protestare contro il governo, i liberali avevano smesso di fumare, e nessuno, eccetto i papalini e i soldati tedeschi che li sostenevano, fu più visto con il sigaro in bocca; e l’8 luglio, poi, un colpo di pistola uccideva il tenente dei gendarmi Niccola Moschini, onde i poliziotti battevano e ferivano, per rappresaglia, quanti incontrassero per via. Un assiduo lavoro veniva intanto audacemente fatto tra gli Ungheresi della guarnigione austriaca, provenienti dalla milizia nazionale della domata rivoluzione ungherese, e stretti d simpatie segrete per noi; ed arditissimo nel mantenere rapporti con essi fu Gaetano Brussi, che nel maggio del ‘49 aveva combattuto in difesa di Bologna, e che, arrestato a Faenza nel ‘52, sfuggì meravigliosamente ai gendarmi, riparò in casa di Carlo Caldesi, e poté poi emigrare in Liguria, donde mantenne relazioni con il comitato di Romagna e con gli emissarî del Mazzini.
Ma i propositi di rivoluzione in Romagna e in Bologna sfumarono alla notizia dolorosa dell’insuccesso del 6 Febbraio 1853 in Milano; e un editto dell’I. R. governo civile e militare di Bologna incolpava di alto tradimento, per aver preso parte alla congiura, tredici profughi, intimando loro di presentarsi entro 90 giorni: tra essi il faentino su ricordato Gaetano Brussi (soprannominato Bruto dai suoi compagni), reo di essere il capo degli affigliati appartenenti alla scolaresca. Qui a Faenza cotali notizie produssero sbigottimento commisto di propositi di vendetta. Gli odii e i rancori tradizionali si rinfocolarono tra il borgo e la città; arresti, condanne di galera o di morte piombavano a caso per opera del Tribunale della Sacra Consulta o dell’I. R. Tribunale Statario austriaco; a centinaia, poi, contavansi le catture dette di precauzione, ordinate dal governatore Antonio Giri da Osimo, che per questo fu il 27 giugno ferito, fuor della porta Imolese, da un colpo di pistola. Lo stesso delegato di Ravenna, Stefano Rossi, recatosi a Faenza per tali avvenimenti, veniva fatto segno ad un attentato, da cui non andò immune un suo servo; eppure il rapace e violento monsignore, non bastandogli le prigioni zeppe, domandava al cardinale Antonelli, segretario di Stato, ed al commissario delle Legazioni in Bologna, mons. Gaspare Grassellini, la deportazione in massa della “setta demagogica”.
E per il raddoppiare furioso de’ rigori e delle persecuzioni, la commissione municipale provvisoria, nominata dal Rossi (in luogo della magistratura dimessasi per l’assassinio del gonfaloniere conte Giuseppe Tampieri) e composta del conte Antonio Gessi, Dionigi Morri e Tommaso Rinaldini, nobilmente rifiutava l’ufficio; onde arrivava il1 2 luglio l’avvocato Luigi Maraviglia, a sostenere il doppio ufficio di governatore e di gonfaloniere, e quasi contemporaneamente l’I. R. governo civile e militare di Bologna mandava, come uomo attissimo ad inasprire il rigore dello stato d’assedio a Faenza, il maggiore Luigi Piret, nuovo comandante della “piazza”: il quale impose subito la sospensione di tutti i divertimenti, la chiusura della botteghe alle nove di sera, l’obbligo, per tale ora, di ritirarsi ognuno in casa. Lo zelo austro-papale fu così feroce, che ne derivò persino un conflitto d’autorità fra il delegato apostolico Rossi e il maggiore Piret, i quali gareggiavano nelle persecuzioni: onde merita plauso il contegno dei cittadini Antonio Gessi, Domenico Zauli-Naldi, avv. Giuseppe Pasini, Carlo Spadini, Giuseppe Minardi, Cesare Tassinari, che ricusarono l’invito a formare una nuova commissione municipale provvisoria, tanto che lo stesso governatore Giri, guarito della ferita, assumeva temporaneamente la direzione del Comune.
Una delle vittime della rincrudita reazione a Faenza fu Federico Comandini, arrestato la notte del 18 luglio 1853, e subito inviato a Bologna, ove eroicamente subì la tortura del bastone senza lasciarsi strappare rivelazione alcuna, ed ove il 27 luglio, temendo non riuscisse la violenza di nuove minacciate battiture a vincere la sua forte fibra, tentò il suicidio segandosi le vene per non compromettere i compagni di fede! All’indomani della cattura del Comandini fu in Faenza un vero spavento: volle la polizia arrestare Gaetano Carboni e l’orologiaio Silvestro Bolognini, ma invano, poiché il Bolognini da parecchi giorni avea esulato a Genova, ove pure emigrò il Carboni, dopo essere stato qualche mese nascosto in casa de’ parenti suoi Bucci; e su tutti costoro l’I. R. governo di Bologna, rappresentato allora dal tenente generale conte Nobili, cercava, con infame menzogna, di far ricadere la responsabilità morale dei delitti di sangue che da anni, quasi per atavica triste eredità di violenze, funestavano questa città; ma a dimostrare anche meglio che fra le cospirazioni politiche onde erano arrestati e ricercati il Comandini ed i suoi amici, ed i truci delitti, dovuti a spirito settario od a vendette private, non eravi nesso alcuno, sta il fatto che l’anno 1854 fu a Faenza anche peggiore del ‘53. Il diario (( Conservasi ms. nella biblioteca comunale di Faenza. )) di un curioso tipo di prete faentino, don Domenico Fossa, nel quale, dal ‘49 in poi, insieme con le notizie del tempo bello e brutto, è una ridda macabra di morti e feriti per archibugiate, coltellate, pistolettate, continua dal 1854 a registrare attentati, ferimenti, omicidî, arresti, e narra anzi di una specie di dimostrazione militare fatta da pattuglie tedesche, il 23 gennaio, in tutti i punti della città, per intimorire i cittadini. Ahimè! Il rigore dello stato d’assedio non era riuscito a svellere la mala pianta del delitto di sangue aùin Faenza, ché anzi ve l’avea coltivata; eppure governo, Tedeschi, polizia seguitavano ciechi nel sistema brutale della repressione!
Mentre così luttuosi tempi volgevano, instruivasi in Bologna il processo degli arrestati bolognesi e romagnoli del ‘53, e con sentenza del 12 gennaio 1855, letta agl’imputati dal Consiglio di Guerra dopo una sacrilega preghiera tedesca dinanzi ad un Cristo, erano condannate alla forca 25 persone, tra cui Federico Comandini e il faentino Enrico Salvatori, domiciliato a Bologna, ed altri alla galera per vent’anni, altri alla fortezza per dodici anni, altri alla carcere per tre e due anni; inoltre erano dichiarati rei di alto tradimento i tredici contumaci, tra cui Aurelio Saffi, Francesco Pigozzi, Adeodato Franceschi e Gaetano Brussi, e contr’essi il 14 marzo era comminata la pena, variante da quindici anni di galera con i ferri pesanti ai venti anni di fortezza, pure con i ferri: nella quale ultima sentenza mancano i nomi dei profughi Adeodato Franceshi e Gaetano Brussi, morto il primo già l’anno innanzi a Genova, ammalato il secondo sì gravemente da essere creduto prossimo a spirare. Il Brussi vive, invece, tuttora in Roma, venerabile superstite di una generazione di eroi; ed io credo interpretare, o cittadini, l’animo vostro mandando a Lui, in questo giorno che celebra la pasqua di liberazione a Faenza, il riconoscente saluto della città natale, e l’augurio affettuoso di lunga serena vecchiezza! Le gravi pene furono poi commutate, e Federico Comandini si ebbe sei anni di detenzione in fortezza con i ferri, Enrico Salvatori otto anni di lavori forzati.
Da Bologna alcuni de’ miseri prigionieri furon condotti a Civita Castellana; ed a Faenza avvenne il pietoso incontro di essi con i parenti, con gli amici, con i compagni di speranze e di sogni. Tra i più affettuosi consolatori del Comandini era Matteo Liverani, che fu poi anch’egli arrestato il 25 aprile, e coinvolto nel nuovo processo istruito per le rivelazioni di Giuseppe Signorini di Forlì, le quali avevano già dato luogo alla cattura del conte Pietro Pasolini – Zanelli a Cesena, di Pio Paracciani, Ciro Cirri, Mentore Mazza a Forlì, e di altri, tutti condannati di lì a poco per alto tradimento. Matteo Liverani si ebbe la pena della forca, commutata in otto anni. Il 23 aprile, poi, i prigionieri di Civita Castellana furon trasferiti nel forte di Paliano, a 476 metri su ‘l livello del mare, nel circondario di Frosinone; e quivi, com’è noto, inaspriti dalle sevizie, tentarono il 14 marzo del 1857 un’ardita ribellione e una fuga, che finì con una terribile zuffa, durata quattr’ore, tra prigionieri e soldati. Il nuovo processo, cui il tragico fatto diè luogo, si risolse con la condanna a morte del Comandini, di Francesco Marzari di Castel Bolognese, del romano Enrico Roselli, di Antonio Bedeschi da Lugo, e con altre condanne alla galera perpetua, a rincrudimento di pena; ma quattro esecuzioni capitali, proprio nel momento che gli sguardi di tutta Europa eran su l’Italia, sarebbero state grave errore; e Pio IX commutò tali pene con la galera a vita, e la galera a vita degli altri fu ridotta per alcuni a venti anni, per altri a sedici, per altri a dodici.
Ma il fatto di Paliano, dovuto all’orribile vita de’ carcerati politici, tenuti in fetide fosse, nutriti con scarso e nauseante cibo, tormentati con ferri e battiture, veniva denunciato all’Europa dal conte di Cavour, con la circolare del 1° aprile del ‘57; ed allora il cardinale Antonelli, per disarmare quel pertinace ministro di Vittorio Emanuele, che nel Congresso di Parigi avea tuonato contro il mal governo papale, e che ora rincarava la dose, indusse Pio IX ad un viaggio in Romagna, non per offrire concessioni ed amnistie, sì per avere un’accoglienza tale che dimostrasse all’Europa calunniosi e infondati i lamenti della diplomazia piemontese. Così avvenne che il 4 maggio il papa partì per le Legazioni, tra la guardia de’ fucili e delle baionette, e nel pomeriggio del 5 giugno giunse a Faenza, ricevuto solennemente dal Vescovo e dal clero, dalla magistratura comunale, dalle “autorità” politiche, entrando a porta delle Chiavi nel borgo d’Urbecco, e da porta Ponte nella città: e di questa gli furono offerte le chiavi dorate, sur un cuscino di velluto. Il corteo sfarzoso sostò su la gradinata della cattedrale, donde Pio IX benedisse il popolo, entrando poi nella chiesa, e da quella passando direttamente nel vescovado. Una grande illuminazione e l’accensione di fuochi artificiali su la piazza attestarono, la sera, la gioia ufficiale; il dì dopo il pontefice si recò a visitare l’appodiato di Fognano e rientrò in città verso le una del pomeriggio; da una finestra del vescovado, addobbata a guisa di pergamo, di nuovo diè la benedizione; finalmente per il corso di porta Imolese se ne partì, dirigendosi ad Imola. E durante il viaggio distribuì qualche migliaio di scudi a santuari, chiese e conventi, e fece grazia a qualche malfattore volgare, senza che un moto del cuore lo inducesse a pietà per tante infelici vittime politiche languenti nelle prigioni, accolto dovunque, come qui a Faenza, più dalla morbosa curiosità che non dall’entusiasmo del popolo. Dov’era il Pio IX del ‘48 benedicente all’Italia? dov’era la Faenza ribelle dei Pasi e dei Caldesi? Il papa era ridivenuto quello che deve essere un papa; ma il leone faentino, oh il sonnacchioso leone non tarderà, non dubitate, ad aprir gli occhi di bragia, a rabbuffar la criniera, a levar alto il ruggito della ribellione finale.
IV.
L’apparente torpore in Romagna covava i germi del prossimo riscatto. Già Garibaldi aveva aderito al nuovo programma giobertiano, dell’Italia una con Vittorio Emanuele; perfino il Mazzini, se pur non poteva dissimulare e far tacere la sua invincibile avversione per l’alleanza con la Francia imperiale del despota del 2 decembre, aveva riconosciuto, però, senza per nulla rinunciare a’ suoi principî, che scendendo dalla teoria all’azione non bisognava ostinarsi ad imporre al popolo le dottrine repubblicane, ed avea manifestata una tal quale simpatia per il re del Piemonte; (( Cfr. Iessie White Mario, Della vita di Giuseppe Mazzini, Milano, Sonzogno 1886, pp. 351 ss. )) onde nella stessa Romagna, pur tradizionalmente repubblicana, Camillo Casarini, in un’adunanza tempestosa alla Pineta di Ravenna, riuscì a strappar l’adesione de’ cospiratori alla Società Nazionale fondata dal Manin, dal La Farina, e dal Pallavicino.
Così avvenne che, nell’imminenza della guerra del ‘59, partivano in gran numero i volontari, reclutati dai comitati che, secondo le due teorie politiche nazionali, dividevansi allora in La Fariniani e Mazziniani; e questi ultimi erano, come i La Fariniani, attivissimi, essendo giunta da Londra la parola d’ordine che, se la guerra avesse avuto carattere nazionale, tutti dovevano concorrervi. (( Questa parola d’ordine parrebbe contrastare con la famosa dichiarazione del 28 febbraio 1859, firmata dal Mazzini, Saffi, Crispi, Campanella, Quadrio, Mario, Rosolino Pilo e tanti altri repubblicani (Scritti di Giuseppe Mazzini, X, 238), con la quale essi affermavano “che se la guerra si iniziasse diretta o padroneggiata da Luigi Napoleone Bonaparte, si asterrebbero, deplorando, dal parteciparvi”; ma d’altro canto le decisioni del Comitato di Londra favorevoli agli arruolamenti ci sono chiaramente attestate dalle Memorie di d. Giovanni Verità, delle quali una parte ha pubblicata l’avv. Giuseppe Brussi (L’inizio della riscossa, conferenza per il 20 Settembre, Faenza, Tip. Sociale, p. 10). )) Faenza diè così in pochi giorni qualche centinaio di giovani, al cui arruolamento avevano cooperato i patrioti Luigi Brussi, fratello di Gaetano, Marco Balelli, Niccola Brunetti, Benvenuto Pasolini (venuto nascostamente da Genova), Girolamo Strocchi, Achille Laderchi: i quali diressero i partenti in Toscana, o per la via di Marradi, ed allora dovean far capo ad Angelo Fabbroni, o per quella di Modigliana, ed allora a tutto pensava l’infaticabile don Giovanni Verità. Dalla Toscana, per accordi già conchiusi dal Verità con i patrioti fiorentini Giuseppe Dolfi, Ferdinando Bartolommei, Bettino Ricasoli (un fornaio, un marchese, un barone, glorioso terzetto simboleggiante l’accordo tra patriziato e popolo per la comune libertà), i volontari della prima spedizione furon mandati in Piemonte, o per lo sbocco di Livorno, o per quello di Sarzana; quelli delle altre spedizioni (tra cui Stefano Montanari, il fiero ribelle di Aspromonte, che la morte rapiva alcuni mesi or sono, ed alla memoria del quale invio un reverente saluto) rimasero in Toscana a formare la divisione Mezzacapo.
Del resto erano così maturi i tempi che il governo e la polizia, impotenti ormai a raffrenare gli entusiasmi, avevano necessariamente rallentata la repressione: gli arruolamenti si facevano quasi in pubblico; i volontari partivano accompagnati dal popolo plaudente e dalle musiche; e quando il governo tentò un atto di reazione, il popolo gli diè un ammonimento veramente solenne. Era l’11 aprile; e la prima spedizione de’ volontari faentini (Aristide Brighenti, Giovanni Lama, Vincenzo Toni, Giuseppe Galeati, Marino Figna, il Pettinati, il Bianchini, Paolo Montanari, che fu ferito in battaglia, e tanti altri, tra cui quelli che gloriosamente caddero, e che ricorderemo più innanzi) era uscita da porta Montanara, quando le migliaia di persone che l’avevano accompagnata trovarono nel ritorno la porta stessa chiusa e guardata dagli Svizzeri con la baionetta in canna. Alle proteste dei capi seguì l’arresto del conte Achille Laderchi, figlio di Francesco; ed allora si vide un fatto grandioso: quelle migliaia di persone corsero ad armarsi, invasero minacciose la piazza, né posarono fino a che il Laderchi non fu rilasciato libero, tra le acclamazioni del popolo e le grida incessanti di “Viva l’Italia, abbasso il Papa!”.
I fati incalzavano. Faenza, sgombra ormai dai Tedeschi, era però occupata da tre compagnie di pontifici acquartierati in s. Francesco; ma avea libera comunicazione con Modigliana, la quale, per la partenza del granduca da Firenze, si offriva qual porto di sicurezza e qual permanente esempio a scuotere il giogo. E quando da Modigliana giunse la notizia di Magenta, e si ebbe sentore che a Bologna preparavasi la cacciata dei pontifici, i comitati faentini deliberarono di agire.
Già fino dall’11 giugno la magistratura comunale, presieduta dal gonfaloniere conte Francesco Zauli Naldi, aveva spedito un corriere a Bologna per sapere che cosa avesse deciso quel municipio, essendo Faenza pronta ad insorgere; e la mattina del giorno 12 si era sparsa la lieta novella che gli Austriaci avevano incominciato ad abbandonare quella città. Alla sera, centinaia di fucili erano stati raccolti nel Caffè Europa, e centinaia di giovani erano pronti a servirsene; quand’ecco arrivare sur un birroccino lanciato a gran corsa (e il cavallo, fermandosi dinanzi all’Albergo della Corona, stramazzò al suolo morto su l’ colpo) un messo recante la notizia che a Bologna sventolava ovunque il tricolore, e si era constituito un governo provvisorio. Erano le 11 di notte: e mentre la magistratura si adunava in palazzo, una folla immensa agitavasi tumultuando in piazza. Il comando delle milizie papali, intimorito, ritirò il picchetto del corpo di guardia, posto a piè della Torre dell’Orologio, che allora era circondata d’una cancellata; e Tancredi Liverani, figlio di Romolo, e anch’egli scenografo geniale, che fu poi ufficiale garibaldino a Mentana, salì su quella cancellata e vi issò, tra le acclamazioni frenetiche, la bandiera nazionale; e frattanto la magistratura, con solenne atto, “considerando essere avvenuta una insurrezione popolare per la quale era cessata l’azione della autorità governativa civile e militare” (( Arch. Com. di Faenza, Atti della Magistratura, Tit. X, 1859. )) nominava una Giunta Provvisoria di Governo composta dei cittadini: Girolamo Strocchi, figlio dell’illustre Dionigi, e uno de’ reduci del glorioso battaglione faentino del ‘48; dottor Giuseppe Galamini, antico cospiratore e vice presidente, nel ‘49, del circolo popolare “Dio e l’Italia”; dott. Marco Balelli, patriota insigne, che dopo il ‘59 cooperò alla preparazione del movimento che mirava a Venezia ed a Roma. Durante la notte furon poi disarmati, e sostituiti con improvvisate milizie d’insorti, gli altri “picchetti di guardia” ne’ diversi punti della città.
La mattina del giorno 13, sparsasi in un baleno la notizia di tutto ciò, e pubblicatosi il manifesto della Giunta Provvisoria di Governo, la città parve destarsi illuminata da un raggio di gioia, tra lo sventolare delle bandiere tricolori, di cui a poco a poco furon pieni i balconi, ed il fregiarsi delle coccarde: alle ore 9 Tancredi Liverani, udito il parere di Federico Pompignoli, attivo organizzatore popolare, e staccata la bandiera dalla cancellata della Torre, si pose alla testa di una colonna di “dimostranti”, insieme con Giuseppe Liverani fu Pietro, il venerando patriota ancor vivente, che prese poi parte alla campagna dell’Agro romano, e fu ferito e prigioniero a Mentana, e rimase a lungo nelle carceri di Civitavecchia; e tutti e due guidarono quella colonna alla caserma di s. Francesco, dove a grandi grida i soldati furono invitati a fraternizzare co’l popolo. Ma poi che l’invito fu inutile, i due Liverani consigliarono il popolo di dar di piglio alle armi; e già la moltitudine sfollava per correre ad armarsi, quando un sergente (dicono fosse affigliato ad uno dei comitati), affacciatosi ad una finestra, fece grandi segni perché la folla non si allontanasse. Allora ricominciò l’assalto alla porta, e già i popolani, con l’aiuto di travi a guisa di ariete, stavano per isfondarla: ma d’ un tratto essa si aperse, e furon visti nel corridoio e nel cortile soldati e ufficiali in attitudine remissiva e sgomenta, mentre altri soldati uscivano su’l piazzale gridando: Viva l’Italia! Gli ufficiali, che pure avevano la spada sguainata, chiesero salva la vita; data immediatamente garanzia di ciò, fu firmata una resa regolare su queste basi: le milizie, le armi, le munizioni rimanevano al Governo Provvisorio; i soldati che volessero continuare il loro servizio restavano al soldo del nuovo regime, fregiandosi della coccarda tricolore; gli ufficiali conservavano la loro spada e venivano accompagnati a Forlì, dove tuttora perdurava il dominio pontificio. Le tre compagnie papaline divennero per tal modo, in massima parte, liberali, e furono poste sotto il comando del patriota faentino Domenico Bosi.
Questi, giovine ardentissimo e coraggioso e leale, dovea di lì a pochi giorni essere vittima di un agguato nefando. Un caporale ex-papalini disertore si era ricoverato, co’l favore dei clericali del borgo d’Urbecco, in una casa colonica fuor della porta delle Chiavi; il Bosi con un plotone dei suoi soldati circondò la casa, e si avanzò solo (era una notte tutta illuminata del chiarore lunare) verso la porta; ma il brigante traditore dal vano di una finestra gli sparò contro, a brevissima distanza, una fucilata, lasciandolo morto su’l colpo, e si mise in salvo scavalcando il muro dall’altra parte.
Frattanto gli stemmi papali erano stati abbattuti, il governatore congedato, e la Giunta Provvisoria avea assunta la direzione politica della città. A coadiuvare la Giunta di Governo fu dapprima mantenuta in carica l’antica magistratura; poi fu eletta, il 31 luglio, una commissione municipale provvisoria, composta di Gaetano Carboni, del dott. Federico Bosi, dell’avv. Giovanni Toschi.
Così senz’altro sacrificio di vite, tranne quella del povero Bosi, il governo pontificio a Faenza era caduto, e per sempre.
Ma là su i campi lombardi si versava largamente, a quei giorni, anche il sangue de’ Faentini; ed io prego il popolo di Faenza ad ascoltare con mesto raccoglimento in quest’ora solenne i nomi de’ suoi concittadini che, morti con le armi in pugno, attingono oggi il valico di cinquant’anni di gloria; io invito voi, o giovani, ad imprimervi bene questi nomi nel cuore: Federico Castaldi, Francesco Gaddoni, Angelo Sangiorgi, Orlando Castellani, Settimio Merendi, Sante Melandri.
Né è da dimenticare un altro valoroso il quale, sebbene non caduto su’l campo, pure combatté sì intrepidamente da esser promosso per merito di guerra: intendo dire di Giovanni Brunetti, che arruolatosi volontario fino dal 1856 ne’ cavalleggieri di Monferrato, combatté a Montebello tra i cavalleggieri di Novara, ed era ormai l’ultimo superstite di tale reggimento. Semplice, intemerato modesto, tornò in patria co’l grado di sottotenente; senza nulla chiedere, nulla sperare, visse quasi nella miseria fino a qualche mese fa, quando morte pietosa lo sottrasse alle sofferenze e all’affetto dei buoni. Onore alla sua memoria! (( Del Brunetti pubblichiamo in Appendice due lettere scritte alla madre; l’una da Voghera il 12 novembre ‘58, l’altra da Montebello, proprio il giorno dopo la battaglia, il 21 maggio ‘59; nelle quali si rispecchiano, pure in forma rude e semplice, le febbrili ansie, le vaghe dicerie, e i santi entusiasmi di quegli epici giorni. )).
V.
Dopo Solferino e s. Martino, i preliminari di Villafranca, come fulmine a ciel sereno, piombarono nella costernazione il Cavour e quanti avevano aperto l’animo alle migliori speranze. Di questa brusca interruzione della guerra vi fu allora, e vi è anche oggidì, chi credette trovare la causa soltanto nell’atteggiamento della Prussia, che su lo scorcio dell’aprile 1859 avea ordinata la mobilitazione di tre corpi d’armata, e subito dopo Magenta ne mobilitava altri tre, proponendo una mediazione alle potenze belligeranti: che dimostra come certe predilezioni politiche impediscano la compiuta visione delle cose anche ad uomini integri, e come si faccia talvolta a fidanza con la credulità del pubblico.
Dichiara il Tivaroni (( St. critica del Risorgimento italiano, VIII, pp. 74-77. )), infatti, non essere storicamente provato che l’offerta della mediazione prussiana sarebbesi trasformata in alleanza prusso-austriaca, e non conoscersi alcuna traccia di tale alleanza, che sola avrebbe resa inevitabile la guerra. E ciò perché la condizione dell’aiuto prussiano all’Austria era sempre questa: che fosse lasciata alla Prussia la direzione suprema della Confederazione Germanica, il che l’Austria avea sempre rifiutato, tanto è vero che Francesco Giuseppe preferì subito un accordo con Napoleone III anzi che sottostare all’incomoda protezione prussiana. Ed è confermato dai documenti pubblicati dal Chiala che la mobilitazione prussiana avea carattere difensivo (( Lettere edite ed inedite del Conte di Cavour, Torino, Roux, I. )).
Un po’ differente è la verità tutta intera. Con il convegno di Plombières del ‘58 Napoleone III avea consentito che si formasse nell’alta Italia un forte Stato sabaudo, il quale sarebbe tutelato da Parigi più tosto che dominato da Vienna; aveva vagheggiato un regno dell’Italia centrale per il principe Gerolamo Bonaparte, un regno di Napoli per il figlio di Giovacchino Murat: il programma politico, tal quale, del primo Napoleone, di cui il nipote voleva farsi vendicatore, lacerando i trattati di Vienna del 1815.
E i quattro Stati dell’alta Italia, dell’Italia centrale, del dominio papale, del regno di Napoli, avrebbero dovuto raccogliersi in confederazione su’l tipo della germanica, di cui darebbesi la presidenza al papa per consolarlo della perdita di gran parte de’ suoi Stati. Così il sire francese, per attuare un vasto disegno che desse al suo impero la base che gli mancava, umiliando il legittimismo dell’Austria, e procacciando a sé stesso lo splendore di una grande azione sui destini d’Europa, era costretto a barcamenarsi tra gl’interessi del papa, di cui volea parer protettore agli occhi dei clericali di Francia, e gl’interessi italiani, che ugualmente volea parer promuovere, standogli a cuore di atteggiarsi a figlio della Rivoluzione.
L’accorto Cavour, mirando a ben più alto segno, si adoperò a volgere verso il fine dell’unità la ostentata benevolenza imperiale, con l’aiutar sotto mano il movimento insurrezionale dell’Italia di mezzo; ma quando Napoleone III si accorse che giuoco tra lui e il Cavour egli era stato vinto in scaltrezza, perché il grande ministro abilmente andava oltre i limiti fissati a Plombières; quando si sollevarono in Francia vivissime le proteste del partito clericale contro lo spodestamento del papa in Romagna; allora l’imperatore, già molto scosso dagli armamenti prussiani, premuto dal ministro Walewski, ostile all’Italia; spaventato dall’imperatrice Eugenia, che lo tempestava di lettere e di dispacci raffigurandogli la Prussia minacciosa, l’Europa ostile, l’opinione pubblica francese ognor più contraria; allora, dico, l’imperatore si fermò d’un tratto. Questo, nella sua cera luce, il segreto di Villafranca. (( Cfr. A. Messeri, Sulla questione romana dal ‘58 al ‘70, Lanciano, Carabba, 1899, pp. 16-38. ))
Invano, secondo il mio modesto parere, si sforza Alessandro Luzio (che è pur uno studioso di grandissimo valore) con i suoi articoli della Lettura e del Corriere della Sera (( Napoleone III e l’Italia nel ‘59, in Lettura del maggio 1909, e nel Corriere della Sera dell’8 maggio 1909. )) a dimostrare l’amore sincero e disinteressato di Napoleone III per la causa della libertà italiana; invano Alfredo Panzini, con il suo recentissimo libro su’l ‘59 (( Il 1859 – Da Plmbières a Villafranca, Milano, Treves, 1909. )), si affanna a supporre che l’imperatore de’ Francesi ebbe soltanto a Solferino la nitida previsione che assalire il quadrilatero volesse dire schiacciar le forze franco-italiane contro quella muraglia insormontabile, volesse dire Francesco Giuseppe a Milano, le retrovie tagliate, la rivoluzione a Parigi, due dinastie precipitate dai troni, l’Alsazia-Lorena invasa senza resistenza.
L’opinione del Panzini si fonda su l’ipotesi inverosimile che due eserciti vittoriosi potessero così facilmente trasformarsi d’un tratto in vinti, mentre tutta l’Italia era in fiamme, e su ‘l preconcetto che ad ogni modo dovessero quei due eserciti baloccarsi tra le insidie del quadrilatero, come avvenne nel ‘66, più tosto che evitare quello scoglio invadendo arditamente il Veneto, come quasi certamente avrebbe consigliato il sagace intuito di re Vittorio; e le sottili argomentazioni del Luzio s’infrangono inesorabilmente dinanzi all’evidenza dei fatti, la quale pone il beneficio del ‘59 tra altre due date: il 1849 e il 1867, la Repubblica Romana e Mentana. E così Napoleone III, dinanzi alla critica serena e imparziale, si dibatte nella tragica antitesi della sua politica di avventuriero, che vuole essere despota e liberatore (( Anche il col. Carlo Pagani nel suo Milano e la Lombardia nel 1859 (Milano, Cogliati, 1909, pp. 455-523), vede la cagione di Villafranca unicamente negli armamenti prussiani, e si appoggia sull’autorità del Sybel (Die Begründung des deut schen Reichs durch Wilhem I, vol. II, p. 38), il quale afferma che il 24 giugno il principe reggente di Prussia avrebbe inviata una circolare a Londra ed a Pietroburgo per annunziare l’intervento armato prussiano. Ma contro quella che può essere stata azione personale del principe, e minaccia per indurre Russia ed Inghilterra a divenir coefficienti di mediazione, stanno, a parer nostro, i documenti diplomatici, da cui risulta che il governo prussiano non era realmente deciso ad intervenire con le armi se l’Austria non gli avesse dato la direzione suprema federale della Germania. Tali documenti sono: la circolare 22 aprile dello Schleintz ai rappresentanti prussiani presso le Corti germaniche, su l’ultimatum austriaco al Piemonte (esser la Prussia fermamente decisa di non lasciarsi trascinare dall’Austria in una guerra); il dispaccio 22 giugno del conte Rechberg da Verona al barone Koller, ambasciatore austriaco in Berlino, biasimante il contegno della Prussia contrario agl’interessi dell’Austria in Italia; il dispaccio del 24 Giugno dal gabinetto di Berlino agli ambasciatori di Prussia in Londra e Pietroburgo (del medesimo giorno, dunque, in cui il principe reggente avrebbe annunziato l’intervento armato!) che diceva gli armamenti prussiani non significare “ni une nouvelle politique ni surtout l’intention d’ajouter une nouvelle complication”; infine il voto solenne del consiglio dei ministri in Berlino contrario alla domanda dell’Austria d’una alleanza offensiva e difensiva, rivolta il 7 luglio per mezzo del principe Windischgrätz. Tutto ciò senza contare che lo stesso Napoleone in una nota lettera al papa si vantò d’aver fatta la pace di Villafranca soprattutto per opporsi al dilagare della rivoluzione in Italia! )).
Dobbiamo dunque disconoscere quel che egli nel ‘59 fece per noi? No certo.
La guerra d’Italia era osteggiata dalla Francia bancaria e clericale, dal ministro Walewski, dall’imperatrice Eugenia, da un lato; dalla stessa democrazia francese, che nella sconfitta vedeva il disonore e nella vittoria il rafforzamento della tirannide napoleonica, dall’altro lato; eppure Luigi Napoleone fu sospinto e incalzato, quasi senza che ei se ne rendesse conto, dalle tradizioni cavalleresche e generose della sorella latina, dall’impulso del 1789 e del 1793, onde la filosofia enciclopedica aveva preso le mosse per correre con le bandiere vittoriose della Convenzione tutta l’Europa: egli credeva dominare e costringere la libertà entro i confini della sua ambizione, e il fato della libertà lo lanciava, invece, su i campi lombardi, a riprendere l’opera della Rivoluzione, prima di soffocarlo entro le sue spire a Sèdan.
Il trattato di Villafranca stabiliva la restaurazione in Toscana, nell’Emilia, nella Romagna; se non che, partiti da queste regioni i commissari regî, esse constituirono subito nuovi Governi Provvisorî i quali seppero resistere con energia, sempre sostenuti dal Cavour, ad ogni minaccia di ritorno dei principi spodestati. Luigi Carlo Farini, proclamato dittatore di Modena e di Parma; il ferreo barone Ricasoli, divenuto capo del governo di Toscana; Leonetto Cipriani, governatore generale delle Romagne, convocarono le quattro Assemblee Costituenti dell’Italia centrale, le quali si dichiararono recisamente contrarie al ritorno dei sovrani decaduti, e favorevoli all’annessione al Piemonte. Faenza, il 28 agosto, elesse a suoi deputati nell’Assemblea delle Romagne i cittadini Ludovico Caldesi, Federico Bosi, Achille Laderchi e Gaetano Brussi: e il 6 settembre cotale Assemblea, con 121 voti su 121 votanti, dichiarava: “i popoli delle Romagne, rivendicato il proprio diritto, non vogliono più governo temporale pontificio”; e il giorno 7, con 120 voti su 120 votanti: “i popoli delle Romagne vogliono l’annessione al regno di Sardegna, sotto Vittorio Emanuele, re costituzionale” (( Cfr. Tivaroni, VII, parte 4ª, cap. 3. )).
Il 26 settembre, poi, in esecuzione del decreto del Cipriani pubblicato il 30 luglio su l’ordinamento dei municipî, fu convocato in Faenza il collegio elettorale per la nomina del Consiglio comunale, e questo sia adunò solennemente l’11 ottobre. In cotale adunanza, che nei verbali del Comune (( Archivio Comunale di Faenza, Atti Consigliari, 1858-59. n. 94. )) s’inizia con la novella formula “Regnando S. M. Vittorio Emanuele II, re di Sardegna; governo delle Romagne”, fu eletta la nuova magistratura (gonfaloniere il conte Girolamo Tampieri); ma essendosi dimessa la maggior parte degli eletti, si precedette a nuove nomine nella successiva seduta del 20 ottobre, risultando scelto a gonfaloniere Gaetano Carboni: il quale, ricostituitasi l’anno di poi la magistratura a norma della legge Sarda, fu rieletto a capo del Comune, e perciò fu il primo Sindaco della città nel nuovo regime nazionale.
Napoleone III non seppe che fare: le restaurazioni per mezzo delle armi non poteva permetterle, ché, se riconoscevasi il principio dell’intervento, ecco ritornare il dominio austriaco in Italia; le decisioni di un congresso europeo, che egli avea pensato di convocare, gli facevan temere una diminuzione del proprio prestigio; instituzioni autonome, ma sotto la sovranità dei prìncipi spodestati, gli sarebber piaciute molto nelle provincie insorte, ma ad esse opponevasi la decisa incrollabile volontà dei popoli sollevati. Le quattro Costituenti dell’Italia centrale proclamavano intanto (6-7 nov. 1859) la reggenza del principe Eugenio di Carignano, qual precursore del re Vittorio; e qui in Romagna, anzi, al governatore Cipriani, troppo napoleonico, sostituivasi il 19 nov. Luigi Carlo Farini, che formò subito un sol governo dell’Emilia e delle Romagne, introducendovi lo statuto sardo, abolendo il Sant’Uffizio, il foro ecclesiastico, i diritti d’asilo, i Gesuiti.
Napoleone allora, mentre firmava la pace di Zurigo (10 nov.), telegrafava a Vittorio Emanuele affinché impedisse la reggenza del Carignano, per non compromettere le sorti del futuro congresso europeo: il che condusse alla nomina di Carlo Boncompagni, piemontese, a governatore delle provincie sollevate; ma non per questo fu scossa l’idea unitaria. L’imperatore dei Francesi aveva la previsione sicura che, se la potenza di Vittorio Emanuele avesse valicato gli Appennini, si sarebbe spinta verso il sud, iniziando un periodo più acuto della questione romana: onde cominciò a cedere per Modena, Parma, le Legazioni (annesse con regio decreto del 22 marzo 1860), e tentò ancora di impedire l’annessione della Toscana, ponendo innanzi due pretese: Nizza e Savoia alla Francia, regno separato in Toscana. Ma il Cavour, tornato dopo breve assenza al governo, tien duro energicamente, audacemente, agitando lo spauracchio di una più intensa rivoluzione; e l’imperatore cede anche per la Toscana, restringendosi a chiedere che il Piemonte si impegni, con un trattato segreto, a consegnar Nizza e Savoia. Scoppia allora la magnanima ira di Giuseppe Garibaldi, sdegnoso, nella semplicità dell’animo buono, di cotesti commerci diplomatici: certo si è, però, che da quel momento l’unione di tutta l’Italia centrale al Piemonte era un fatto compiuto.
Ma l’ardua meta non si sarebbe raggiunta se al genio del ministro non avesse corrisposto la coscienza del popolo. Pur sotto la trama esteriore dei fatti, dei quali gli attori principali appariscono Napoleone III, Vittorio Emanuele II, Camillo Benso di Cavour, palpita e freme, spirito propulsore di tutta la Rivoluzione Italiana, una grande anima, che dal 1831 in poi avea cospirato, preparato, sofferto, agitato, educato; l’anima, dico, di Giuseppe Mazzini. Che importa se la ribellione del ‘59 ebbe, per forza ineluttabile di cose, una forma esteriore monarchica? I germi da lui seminati nel popolo, quando le paure dei governi e dei pìncipi lo perseguitavano, fruttificarono ora l’Indipendenza e l’Unità, nel modo preciso che Egli aveva previsto e annunziato. “Là nella terra lombarda – scriveva il Mazzini nel ‘31 a Carlo Alberto – hanno a decidersi i fati d’Italia ed i vostri….. La salute per voi sta sulla punta della vostra spada….. L’Austria vi minaccia i dominî, minaccia l’Italia intera con gli eserciti accumulati….. La Francia vi minaccia con l’energia delle moltitudini, con la diffusione dei principii, con la necessità prepotente che, spingendola un dì o l’altro alla guerra, la caccerà nel bivio o di perire o di eccitare i popoli all’insurrezione ed appoggiarli con le armi. L’Italia vi minaccia col furore di libertà che la investe, col grido delle vittime infinite, con l’ira delle promesse tradite…. Sire, noi ci annoderemo intorno a Voi; noi vi profferiremo le nostre vite; noi condurremo sotto le vostre bandiere i piccoli Stati d’Italia….. Uniteci, o Sire, e vinceremo! (( A Carlo Alberto di Savoia – Se no, no, lettera di G. Mazzini (Scritti editi ed inediti: vol. I). ))”.
Or che cos’è il ‘59 (scriveva giustamente in questi giorni Tommaso Monicelli) (( Il profeta del ‘59, nel periodico “Il Viandante”, 6 Giugno 1909. )) se non questo che Giuseppe Mazzini andava profetando nel ‘31? I destini d’Italia decisi nella terra lombarda; l’aggressione dell’Austria; i Francesi venuti a sostener con le armi la libertà del popolo italiano; e il re che gitta la corona ai rischi delle battaglie; e tutti i piccoli Stati e tutti i partiti che si rannodano intorno a lui. Oh, noi possiamo ben trastullarci a discutere se il monumento a Napoleone III debba restare a Milano entro le quattro pareti di un cortile oppur debba uscire alla gloria del sole, quando non una parola si è ancor levata, in questo fervore di commemorazioni, a ricordare il profeta, il maestro, l’Esule antico, colui che innanzi a tutti, solo, spregiato, esiliato, dannato a morte, sacrificava i suoi ideali repubblicani sull’altare della Patria, e indicava ad un principe di Savoia la fatal via della Storia, prevedendo nell’alba brumosa del 1831 il meriggio sfolgorante del 1859!
VI.
Non sarà vana, io spero, questa piccola fiamma che il Ministro della P. I. volle oggi, o carissimi giovani, fosse ridestata ne’ vostri cuori.
Vi sono dei giorni, nella vita dei popoli, in cui si decidono le sorti di un lungo avvenire. L’Italia è forse in uno di questi giorni. Usciti appena fuor del pelago alla riva, noi ci mostrammo prostrati e vinti, di nuovo lacerati dalle fazioni, senza propositi fermi, senza visioni ideali; or dopo 50 anni di vita nazionale, si risollevano i cuori, e traggono dalla coscienza del passato nuova lena e nuove speranze per l’avvenire. Avevamo tanto sofferto, atteso, sperato, e dover poi confessare alle nuove generazioni, per bocca dei sapienti nuovissimi, che valeva meglio non farne di nulla! Avevamo tanto magnificata l’opera nostra, fatto tanti sacrificî sull’ara della patria, inneggiato tanto alla libertà, ed essere costretti a sentir sogghignare che la patria è una astrazione, e la libertà una menzogna!
Ma era questa l’Italia che parve già degna dell’aspettazione della Storia?
Ebbene, sappiatelo e ricordatelo: la Storia, che molto dimentica e molto perdona, non dimentica né perdona chi recida i nervi o scemi la fede di una nazione giovine come la nostra. Che cosa attende la patria da voi? Fermezza di propositi, energia d’animi, lavoro assiduo; ma specialmente, o giovani, essa attende la restaurazione dell’idealità. Al disopra di noi è qualche cosa che vince, vi è una forza misteriosa che trascina, che ci fa agire contro noi stessi e contro i nostri interessi: è quella forza medesima che spinse i nostri padri su i campi di battaglia; che fece loro serenamente soffrire l’esilio, la carcere, la tortura; che li fece essere eroi su’l patibolo.
Per la loro memoria, per la loro virtù, per i loro dolori, smettiamo il cinico adagio secondo il quale la vita politica non è il sentimento, non è la morale, non è la legge, ma è soltanto il tornaconto. E l’Italia, “assunta novella fra le genti”, sarà degna del suo passato.
Appendice, Lettere del volontario faentino Giovanni Brunetti alla madre in Faenza (( Da “La Romagna”, fascicolo n. 11-12, ottobre-novembre 1909. ))
I. Cavalleggeri di Novara
Voghera, 12 Novembre 1858.
Cara mamma, Essendo già da gran tempo privo di grate sue notizie, rompo io primo il silenzio, per darle notizie positive; siamo vicini alla guerra, il giorno 25 del corrente incomincieranno le ostilità (( È noto che la guerra scoppiò, invece, alcuni mesi dopo; ma è pur interessante il vedere in questo documento riprodotte le notizie e le dicerie che allora passavano per vere nella eccitata fantasia e nella generale commozione degli animi. )). È già gran tempo che qui si fanno armamenti, ma fin dal giorno 10 sono stati chiamati sotto le armi tutti i soldati di 5 levate, che erano a casa in congedo illimitato; questi sono 80 mila uomini che pel giorno 20 saranno sotto le armi, più 2 nuove leve di coscritti, che pel 25 devono pure essere pronti nei forti; a giorni si attende l’armata francese che deve unirsi a noi; fin da ieri abbiamo gli arruotini in quartiere che affilano le sciabole, ed aggiustano le punte alle lance; grande è l’ardor dei soldati, maggiore la speranza di vittoria. Abbiamo già a quest’ora nelle file del nostro esercito più di 20 mila Lombardi; tutti i giorni arrivano disertori tedeschi, ungheri, di tutte le qualità; il giorno 25 darà il giorno fatale per l’Austria, giorno in cui si dichiarerà la guerra. Le nostre truppe cominciano a riunirsi ai confini, e quanto prima partiremo noi pure per avvicinarci di più alle frontiere; il nostro Colonnello è passato Generale; quanto prima anzi vi saranno molte promozioni al grado di sotto ufficiale; il mio capitano mi ha detto le precise parole: siete giovane, è vero, ma però sperate; sicché fin qui le ho significato la somma delle cose; da un momento all’altro si potrebbe partire per le frontiere; sappia ed avverta Giuseppe che io ho necessità di denaro presto; tra il 20 e il 24 ho bisogno di averli, e procuri di mandarmene almeno per 2 o 3 mesi finché abbia modo di avvicinarmi a casa; sappia pure che ho consegnato il mio baule con entro tutto il mio equipaggio, cioè tunica, pantaloni, veste, keppis, stivali, camicie, ect. Ad un certo Vincenzo Magnotti, lombardo, caffettiere (Caffè dell’Unione) in piazza del Duomo qui in Voghera, dal quale potrà richiamarlo in caso che un qualche croato fosse destinato a levarmi dal mondo. Dica a mio fratello che non s’impaurisca sentendo che gli chiamo del denaro così alla brusca, perché è vero che sarà mio erede in caso di morte; ma io non conto di morire per morte famelica, ma di tutt’altra morte; lo dica che registri ciò che mi manda, e non tema di cosa alcuna; gli dica che ho ricevuto le lire 100, che ho pagato il mantello, e che presto, cioè si e no, forse ci rivedremo.
Addio, cara mamma, mi dia presto sue notizie, saluti e baci l’ottimo sig. Domenico, l’Orsola, Romeo, tutti insomma di casa, famiglia, amici, ect. Ella pure riceva un abbraccio ed un bacio, che potrebbe darsi che fosse anche l’ultimo, dal suo affezionatissimo figlio Giovanni, che la prega di non negargli la sua materna benedizione; addio, mamma; questa dovrebbe essere al certo la volta buona per la nostra misera Italia. Vincere o morire.
II. Battaglia di Montebello
Dirigga la lettera a Voghera
Montebello, 21 maggio 1859 prov. di Voghera
Cara mamma, Faenza
Abbiamo finalmente incontrato il nemico, e sebbene il quadruplo più forte di noi, l’abbiamo messo in fuga.
Ieri ad 1 ora dopo mezzogiorno siamo stati assaliti da una colonna di cavalleria nemica, che era l’avanguardia di un corpo d’armata assai numeroso; noi non eravamo che 2 soli squadroni, cioè 1° e 3°, ed uno squadrone di Reggimento cavalieri Monferrato; per più di 2 ore abbiamo sostenuti i loro attacchi, ma con grande nostra perdita, e così abbiamo dato tempo alle truppe Francesi stanziate in Voghera di venire in nostro soccorso; bella ma terribile giornata! La vittoria è stata per noi,ma contiamo immense perdite: il mio povero squadrone siamo stati quai tutti massacrati, abbiamo avuto 2 Ufficiali feriti, il sottotenente conte Scassi morto, e lo stesso mio Capitano gravemente ferito, nella testa e nella mano destra, dalle sciabolate degli Ullani Austriaci; di 99 nel mio squadrone che siamo montati a cavallo, siamo ritornati 46; io però non ho sofferto cosa alcuna, ma mi hanno ucciso il cavallo, ed ho perduto quanto vi avevo sopra, ed ancora per soprapiù avevo nascosto una moneta da 100 lire nella valigia in mezzo ad una camicia, ed ho tutto perduto. Dio però mi ha assistito, e mi ha fatto incontrare in mezzo alla pugna un cavallo, il cui padrone era stato ucciso; l’agguanpai (sic), gli saltai a cavallo, e ritornai all’attacco; e inseguimmo il nemico per ben 6 miglia. Abbiamo fatto più di 500 prigionieri, ed altrettanti sono i Tedeschi morti, che abbiamo seppellito noi, senza quelli che hanno ritirato loro, che si ha per certo sieno molti; dappertutto vittoria; la nostra avanguardia, cioè Garibaldi, è in Lombardia, e presto lo varcheremo anche noi, l’attacco sarà generale, e dopo il primo attacco in 2 giorni saremo a Milano. Ma io sono rimasto senza camicia, e con un sol paio di pantaloni, perché quelli che ho ritrovato nella valigia del cavallo che presi son troppo corti e le camicie sono grosse che sembrano 2 sacchi; basta, vi vorrà pazienza; ho ancora dei quattrini e comprerò ciò che mi occorre; ma anche questi finiranno, e pur troppo tutto finisce, ma io non finirò più; non mi hanno ucciso questa volta, temo di essere invulnerabile. Addio, cara mamma, tanti saluti a tutti, ed un bacio alle mie care sorelle; tanti saluti all’ottimo signor Domenico.
Viva l’Italia, viva la Francia, viva l’Indipendenza Italiana.
Suo aff.mo figlio Giovanni