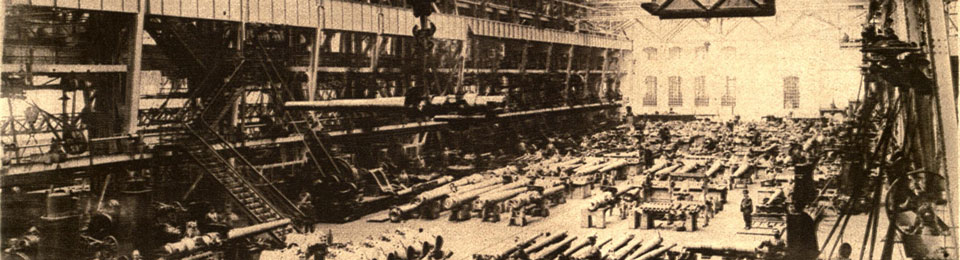
di Niccolò Caramel
Parole chiave: fremdarbeiter italiani, Germania hitleriana, scambi commerciali tra Italia fascista e Germania nazista, migrazione italiana, condizioni lavorative sotto il Nazismo, razzismo popolare.Abstract
In the period between 1937 and 1943 approximately 500,000 Italian workers left their homes and went, more or less voluntarily and driven by National Socialist propaganda, to Hitler’s Germany. Following the path outlined by Brunello Mantelli and Cesare Bermani, (the two Italian historians who, more than any other, have been involved in these studies), we will try to understand (from the reconstruction of the facts that occurred during that time and the political relationship between the Nazi and the Fascist authorities) what the Italian emigration in Germany has meant to the protagonists. Key words: Italians fremdarbeiter, Hitlerite Germany, Commercial exchanges between Fascist Italy and Nazi Germany, Italian Migration, Employment Conditions under Nazism, popular racism.Abstract english
1. Il contesto generale
Il flusso migratorio dei lavoratori italiani verso il Reich negli anni 1937-1943 trae origine dalle necessità legate allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e ai suoi preparativi, necessità che portarono la Germania ad abbisognare di forza lavoro per sopperire a svariate esigenze in ogni comparto produttivo: dall’agricoltura all’industria, dalle imprese edili alle miniere di carbone.
Fin dal 1937 la Germania era in piena ripresa economica ed era riuscita a superare, come ci mostra lo studio di Gustavo Corni (2009, pp. 140-156), la pesante crisi iniziata negli ultimi anni del secondo decennio del Novecento e che aveva causato un alto tasso di disoccupazione. Fu proprio la forte crisi sociale ed economica originata dalla disoccupazione e che vessò la popolazione tedesca nei primi anni del terzo decennio del Novecento uno dei fattori che contribuirono alla conquista del potere politico da parte del nazionalsocialismo e del suo leader, Hitler. Nel giro di pochissimi anni la situazione si era completamente capovolta e la nazione tedesca era riuscita a raggiungere, non con pochi sforzi, uno stato di piena occupazione.
Nello stesso periodo, segnala Nicola Gallerano (1974, 38-40), l’Italia affrontava il problema opposto: le regioni rurali del Triveneto e del Meridione, più delle altre, erano soggette a una condizione di preoccupante declino economico, aggravato dalla presenza in queste aree di una popolazione abbondante ma scarsamente occupata. Oltre a ciò, le migrazioni verso la Germania erano fondamentali allo stato italiano come paliativo per rimediare alla fallimentare politica economica attuata dal regime fascista durante gli anni Trenta, ma anche per “trarre gli indubbi benefici che le rimesse degli emigrati costituiscono per la bilancia dei pagamenti italiana” (Bermani 1998, 10). Durante i mesi estivi del 1942, la rivista del Partito comunista d’Italia Stato operaio evidenziava come tale flusso migratorio verso il Reich non fosse stato determinato solo “dalla necessità, da parte della Germania hitleriana, di disporre di centinaia di migliaia di lavoratori non tedeschi da impiegare nelle campagne e nelle officine del Reich in sostituzione dei lavoratori tedeschi chiamati alle armi” (Berti 1942, 135), ma anche l’alto tasso di disoccupazione in Italia e il bisogno di valuta tedesca erano tra le maggiori motivazioni che stavano alla base dello scambio lavoratori-materie prime: una condizione resa obbligatoria dalle disastrose condizioni in cui vessava l’agricoltura fascista e che obbligavano il popolo italiano a dure privazioni alimentari (ibidem).
All’interno di questo contesto, il rapporto tra l’impellente necessità di braccia che attanagliava il mercato del lavoro tedesco (Mason 1977) e la stagnazione produttiva di alcune zone d’Italia, unito alla dipendenza di Roma dalle materie prime della Germania, crearono un naturale rapporto di scambio braccia-merci tra i due paesi.
Le prime possibilità di uno scambio di lavoratori tra la nazione tedesca e quella italiana si ebbero col Protocollo segreto sui rapporti economici italo-tedeschi sottoscritto a Monaco il 14 maggio 1937 da Amedeo Giannini, sottosegretario presso il Ministero degli Esteri, e Otto Sarnow, alto funzionario del Ministero dell’Economia del Reich1. A partire dalle intese economiche sottoscritte col Protocollo segreto e con l’avvicinarsi dei venti di guerra, il Regno d’Italia lega la sua economia a quella tedesca e ne diviene sempre più dipendente per la fornitura di beni di produzione, di macchine utensili, di armamenti vari e di molte materie prime – soprattutto oli combustibili e carbone –, per diventare totalmente assoggettato al ben più forte alleato allo scoppio del conflitto.
La volontà da parte del governo italiano di sottostare alle disposizioni tedesche si deve ricercare anche all’interno del ruolo militare e politico ricoperto dall’Italia all’interno dell’Asse e alla scelta di entrare in guerra in seguito alle vittorie schiaccianti riportate dai tedeschi su più fronti. Le autorità romane, all’alba del 10 giugno 1940, si trovarono infatti costrette a richiedere all’alleato tedesco un aumento di rifornimenti per poter entrare nel conflitto mondiale. A guerra iniziata, le difficoltà economiche e politiche che il fascismo dovette affrontare furono incrementate, come emerge dall’analisi di un dettagliato elenco di “materiali indispensabili per consentire alle industrie di lavorare col ritmo attuale ridotto rispetto alle possibilità produttive”2 trasmesso a Mussolini nel dicembre 1940 dal generale Carlo Favagrossa, capo del sottosegretariato alle Fabbricazioni di Guerra, che metteva in luce le difficoltà sofferte dalla macchina industriale italiana.
È all’interno del contesto sopra descritto, abbozzato e frammentario, che si colloca la vicenda dei circa cinquecentomila lavoratori italiani che fra l’inizio del 1938 e la prima metà del 1943 emigrarono in Germania3. Secondo una fonte tedesca contemporanea4, la manodopera che il governo italiano mise a disposizione dei dirigenti di Berlino venne utilizzata e suddivisa come illustrato nella tabella 15.
Tabella 1.
|
DAF |
Agricoltura |
Industria |
Alberghi |
Imprese Edili |
Totale |
|
|
1938 |
6.024 |
31.071 |
— |
— |
— |
37.095 |
|
1939 |
10.084 |
36.327 |
— |
— |
— |
46.411 |
|
1940 |
— |
49.184 |
49.535 |
— |
— |
98.719 |
|
1941 1942 |
— — |
53.381 30.488 |
174.052 41.478 |
1.130 391 |
— 8.187 |
228.563 80.544 |
|
Totale |
16.108 |
200.451 |
265.065 |
1.521 |
8.187 |
491.332 |
Anche Renzo De Felice (1990, p. 576) propone alcune stime – ritenute attendibili dagli storici – riguardo i lavoratori italiani emigrati in Germania. Tali stime segnalano un aumento dell’emigrazione fino al 1941 e una diminuzione progressiva in seguito all’entrata in guerra dell’Italia. Nel dettaglio, le cifre presentate da De Felice evidenziano questo andamento: un forte incremento iniziale, da 100.000 lavoratori nell’inverno 1940-1941 a 230.000 nel corso del 1941, un successivo decremento che raggiunge il numero di 200.000 nel febbraio 1943, e infine una rapida discesa che si blocca, all’alba dell’8 settembre, sul numero di 117.548 fremdarbeiter italiani rimasti in Germania o per costrizione o per scelta volontaria.
Il flusso di lavoratori dall’Italia verso le varie regioni tedesche bisognose di manodopera – denominato “flusso volontario” (freiwillig) – mostra una realtà complessa, che i soli numeri non riescono a esplicare. Schematizzando tale vicenda agli estremi e prendendo le direttive così come vengono esposte da Brunello Mantelli (1992, pp. 33-62), si nota il passaggio, in seguito alle persistenti richieste dei dirigenti di Berlino, da un’emigrazione tradizionale, mossa da necessità economiche, ad una vera e propria gestione centralizzata da parte dell’alleanza nazi-fascista. Il fenomeno migratorio si tradusse così in un vero e proprio prelievo (Auskämmung) di lavoratori attuato dal governo italiano, in particolar modo nelle fabbriche, a partire dal 1941.
L’emigrazione di manodopera italiana in Germania, come affermano Gustavo Corni e Christof Dipper (2006, p. 147.), va esaminata sotto molteplici aspetti. Dal punto di vista economico e sociale, come abbiamo già accennato, si deve considerare l’alto tasso di disoccupazione che travagliava la penisola italiana e che si aggravava progressivamente. Le zone maggiormente colpite erano quelle del meridione, in particolare la provincia di Bari, e le aree rurali nord-orientali: la Bassa padana veneta ed emiliana, la Romagna, il medio e alto Veneto, la Lombardia orientale e il Friuli. Contrariamente a questa situazione, “il mercato del lavoro tedesco soffre, negli stessi anni, di un’acuta penuria di braccia, che rischia di boccare la politica di riarmo a cui la dirigenza nazionalsocialista aveva legato le sue sorti” (Corni, Dipper 2006, 147). L’interesse del Terzo Reich nei confronti dei lavoratori provenienti dall’Italia si deve quindi individuare nella carenza di manodopera che affliggeva la Germania nel periodo 1938-1945, interesse che si tradusse nella promozione di un impiego massiccio di forza lavoro straniera tale da permettere ai dirigenti nazionalsocialisti di riuscire a “mantenere un rapporto fra la quota di popolazione attiva mobilitata nelle forze armate e quella occupata nella attività produttive sostanzialmente identico a quello rilevabile presso tutte le altre potenze belligeranti” (Ivi, 153).
Oltre a ciò, tra il 1940 e il 1941 lo stato tedesco si trovò a dover affrontare alcune esigenze urgenti legate ai preparativi bellici per l’attacco all’Unione Sovietica (comunemente nota come “operazione Barbarossa”) e volse così lo sguardo verso l’alleato italiano (Hillgruber 1965). Il fabbisogno industriale per supportare l’attacco all’URSS e per intensificare la guerra marittima – stimato dal generale Thomas nel numero di 640.000 unità – richiese non solamente una politica di assunzione interna al paese, ma prevedeva un piano che permettesse “un grande aumento di lavoratori stranieri da portare in Germania” (Milward 1965, 52).
I rapporti tra Italia e Germania mutarono radicalmente in seguito al 10 giugno 1940, cioè quando il gruppo dirigente di Roma decise di entrare nel conflitto con l’obiettivo iniziale di condurre una “guerra parallela”. Solamente l’intervento delle armate tedesche riuscì ad arginare le prime inattese sconfitte in Grecia e in Africa settentrionale, sconfitte che naturalmente ridimensionarono le aspettative italiane. Bastarono pochi mesi ai dirigenti del nazionalsocialismo per comprendere l’inconsistente potenza bellica dell’alleato mediterraneo e, quindi, la sua poca utilità sul campo di battaglia – soprattutto se rapportata alle altissime richieste di materie prime, fra le quali si annovera principalmente il carbone. Di conseguenza, da Berlino viene presa la decisione di convertire i cittadini italiani da combattenti a lavoratori per la produzione industriale e per altre opere utili al fine bellico. Alle richieste tedesche di manodopera italiana la dirigenza romana non aveva la forza di opporsi ed iniziò così un “complicato meccanismo di estrazione di manodopera dalle fabbriche, gestito congiuntamente dal Ministero delle Corporazioni, da quello dell’Interno e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria (Cfli)” (Mantelli 2001, 345).
Di conseguenza, durante il periodo che intercorre tra il 1940 e il 1941 si può situare un momento cardine nei rapporti italo-tedeschi: le autorità di Berlino chiesero formalmente all’Italia di mettere a disposizione oltre 200.000 operai qualificati per l’industria del Reich ed espressero la volontà di discutere tale accordo durante le trattative, tenutesi a Roma nel febbraio 1941, sui rapporti economici fra le potenze dell’Asse. In seguito ad una iniziale intesa tra le due parti, siglata il 1° febbraio 1941 e che decretava l’invio di 54.000 lavoratori per l’industria estrattiva e per l’edilizia, e ad un concordato, stipulato il 10 febbraio e che prevedeva l’assunzione di 150.000 operai, si giunse alla firma, il 26 febbraio, di un vero e proprio accordo, comunemente noto come “Settimo protocollo segreto”6: con tale accordo le autorità romane accettavano di trasferire 204.000 operai in terra tedesca.
Complessivamente gli operai italiani in Germania nel settembre 1941 erano 216.834, tra questi 177.823 – cioè l’87,2% – operavano nell’industria; nonostante gli alti numeri, però, il governo nazionalsocialista ne avrebbe desiderati ancora. Una delle motivazioni principali dell’interesse tedesco verso i fremdarbeiter provenienti dall’alleato italiano era la possibilità di poterli impiegare nei lavori industriali più delicati, senza ricorrere al rischio di dannosi sabotaggi. Un altro incentivo che spinse all’assunzione, nel 1941, di migliaia di lavoratori italiani da impiegare nell’industria e nell’agricoltura, fu la possibilità di riequilibrare l’attivo nel clearing che Berlino aveva accumulato nel 1940 in seguito all’aumento delle esportazioni in Italia e che ammontava, secondo Raspin (1986, 431, tab. 32), al 27 dicembre 1940, a lire 708.564.000.
Le previsioni dei grandi gruppi industriali e dei dirigenti dello stato erano incentrate sulla convinzione – condivisa dai governi di Stati Uniti e Gran Bretagna – che l’offensiva orientale si sarebbe conclusa entro pochi mesi e che le truppe tedesche sarebbero riuscite ad innalzare la bandiera del Reich a Mosca, sancendo il crollo dell’URSS. In seguito all’ipotetica vittoria, la Germania avrebbe potuto sfruttare il territorio sovietico fino alla linea Arcangelo-Astrachan, riempiendo il magazzino del Reich sia delle materie prime necessarie all’industria, sia dei prodotti agricoli fondamentali per nutrire la popolazione. Parimenti, si sarebbe risolto definitivamente anche il persistente problema della scarsità di manodopera, ma non attraverso l’impiego di civili russi e di prigionieri di guerra, bensì mediante la smobilitazione di migliaia di soldati arruolati nell’esercito tedesco e la loro occupazione nell’industria.
In vista di ciò, l’arruolamento di 200.000 lavoratori italiani durante i primi mesi del 1941 era frutto di una necessità ritenuta temporanea dalle autorità tedesche, destinata a rimediare ad un bisogno che sarebbe stato risolto entro un breve periodo. Le autorità fasciste e, in primis, lo stesso Mussolini aderirono alla logica della guerra breve: questa idea fu, secondo De Felice, l’errore fondamentale commesso dai dirigenti romani. Tale errore, sempre secondo l’idea di De Felice, era aggravato dal mantenimento del modello economico della “guerra in preparazione” anche in seguito alla prospettiva di un conflitto di qualche settimana o di pochi mesi. In seguito all’attacco della Grecia e alle necessità di aumentare la potenza bellica per far fronte alle forze inglesi in Nordafrica, era divenuto evidente come non si potesse più ragionare “attenendosi ad una strategia di ridotto impegno militare” (De Felice 1990, 544), ma le autorità fasciste non presero delle decisioni che tenessero conto del mutare degli eventi. Si deve considerare anche questa mancata razionalizzazione per capire appieno le strategie di Mussolini e dei suoi alleati riguardo l’impiego di lavoratori nel mercato tedesco, ovverosia la richiesta avanzata da Roma nel febbraio 1941 che i contratti di lavoro stipulati fossero a tempo determinato, da un minimo di sei mesi ad un massimo di quindici (Dazzi 1942, 183): richiesta che venne accettata dalle autorità tedesche.
In Germania non giungevano lavoratori italiani solamente dalla madrepatria, ma anche dagli stati europei conquistati durante l’avanzata nazista. In Belgio, ad esempio, “gran parte della colonia italiana (…) [finì con l’] andare a lavorare in Germania” (Morelli 1987, 256) già nell’immediato post-occupazione tedesca (10-28 maggio 1940). La conquista del Belgio da parte dei nazionalsocialisti causò un’emigrazione di massa dei lavoratori: tale emigrazione fu principalmente una conseguenza dell’alto tasso di disoccupazione venutosi a creare nel paese e di certo, come sostiene Anne Morelli (1987), non venne bloccata da precetti morali:
questi uomini, abituati ad “affittare” le loro braccia di miniera in miniera, a laboratori, a fabbriche, sempre al migliore offerente, non trovavano nulla di “immorale” ad andare in Germania, tanto più che sapevano bene che anche le industrie belghe rifornivano lo schieramento nazista. (p. 261)
Per di più, nelle colonie italiane presenti in tutti i paesi europei invasi dalla Wehrmacht, in particolar modo Francia e Belgio, per molti antifascisti andare a lavorare in Germania era sicuramente più sicuro che ritornare in patria o rimanere in un paese occupato, dove le possibilità di essere catturati dalla polizia italiana, alleata della Gestapo, era certamente maggiore.
Per l’Italia, sotto il profilo economico, il periodo 1940-43 fu indurito dalla doppia necessità di far fronte, da una parte, oltre alle spese normali, a quelle derivanti dallo stato di guerra, e dall’altra dal tentativo di contenere l’inflazione, la circolazione e il disavanzo del bilancio. All’interno di questa complicata situazione economico-finanziaria, un aiuto, seppur modesto, venne dalle rimesse dei lavoratori emigrati in Germania e dal commercio estero che mantenne gli utili in attivo. Come si può capire dalle trattative tenutesi tra i due paesi fin dal periodo della “non belligeranza”, le necessità economiche sofferte dall’Italia vennero pesantemente sfruttate dai tedeschi (Giannini 1954, 462 sgg.). De Felice afferma a questo proposito che
l’accordo del 24 febbraio 1940 relativo alle relazioni economiche e in particolare agli aiuti in materie prime e manufatti che i due paesi potevano prestarsi […] era scaturito essenzialmente dalla concorrenza delle trattative che l’Italia aveva parallelamente in corso con l’Inghilterra per i rifornimenti di carbone e dal significato politico che tale concorrenza assumeva in quelle particolari circostanze per Berlino. (De Felice 1990, 568)
Senza la concorrenza anglosassone risulta molto improbabile che i dirigenti di Berlino avrebbero accettato di trasferire verso l’alleato italiano 12 milioni di tonnellate di carbone l’anno. Una controprova di ciò si può osservare in controluce nel fatto che, ricorrendo di volta in volta a scuse e giustificazioni di vario genere, mai giunsero dalla Germania i quantitativi di carbone concordati. In seguito, ma soprattutto a partire dallo scoppio della guerra, tali questioni si sarebbero non solamente protratte, ma perfino aggravate. In particolar modo col venir meno della concorrenza inglese, le autorità tedesche iniziarono a non rispettare le promesse prese e a guardarsi bene dal stipulare nuovi accordi, tanto che, con il complicarsi dello stato bellico in Africa settentrionale e in Grecia, le sollecitazioni italiane di materie prime, divenute col passare del tempo sempre più insistenti, trovarono scarsi riscontri da parte tedesca.
A complicare la già critica situazione degli scambi commerciali italo-tedeschi fu la presa di consapevolezza, da parte dei dirigenti di Berlino, del cambio radicale avvenuto nel quadro politico ed economico ipotizzato prima dell’“operazione Barbarossa”, consapevolezza che li spinse a mutare le direttive prese nei confronti dell’Italia e che obbligò i due paesi a riaprire nuovi negoziati. L’inesauribile resistenza mostrata dall’esercito sovietico, infatti, costrinse le truppe tedesche ad arrestarsi alla periferia di Mosca nell’inverno 1941-1942, impedendo così non solamente la loro smobilitazione, ma anche il rinforzo di quelle maggiormente colpite durante l’avanzata.
Il risvolto inaspettato che assunse la campagna di Russia creò non pochi problemi a Hitler dal punto di vista della mobilitazione del popolo tedesco nell’industria. Alla base dell’ideologia nazionalsocialista sul piano economico del Führer stava la convinzione che l’assenso del popolo alla sua politica risiedeva nell’attenuazione dei costi e delle privazioni provocate dal conflitto. Perciò, con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, l’arruolamento di manodopera straniera divenne un’esigenza, oltre che del pieno regime produttivo dell’industria e della macchina economica tedesca, anche della politica economica nazionalsocialista, la quale aveva come scopo quello di scaricare verso l’esterno i costi della guerra.
Col passare dei mesi lo stato di necessità determinato dal prolungarsi della guerra in Oriente costrinse Hitler a emanare, il 10 gennaio 1942, l’ordinanza “Armamento 1942” (Rüstung 42), “che segnò il passaggio a una vera e propria pianificazione nella produzione bellica” (Mommsen 2002, 136-37). Con tale ordinanza si richiedeva la disponibilità di ulteriori unità di lavoratori – prelevate prevalentemente dai territori conquistati dell’URSS. Venne inoltre nominato, il 21 marzo 1942, un Plenipotenziario generale adibito all’impiego di manodopera tedesca e straniera, ruolo fino a quel giorno ricoperto da diversi organi statali. Grazie al nuovo ruolo svolto dai bacini dell’Est come fonte per l’impiego di manodopera, sommati ai prigionieri di guerra, giunsero nella fucina di guerra tedesca fra l’aprile e il luglio 1942 più di un milione di lavoratori7.
La nuova situazione venutasi a creare modificò l’importanza dell’Italia agli occhi dei dirigenti nazionalsocialisti, ma l’importanza dei lavoratori italiani rimase fondamentale sotto molteplici aspetti: oltre alla già accennata possibilità di impiego degli italiani nei lavori più delicati, i datori di molte aziende non erano favorevoli all’idea di dover rinunciare alla manodopera ormai qualificata e inserita nella produzione per sostituirla con lavoratori inesperti provenienti dall’Est. Avvenne così una spaccatura tra le aziende: alcune accettarono le nuove condizioni dettate dal regime, mentre altre tentarono di convincere i dipendenti italiani a rinnovare il contratto, soprattutto per quanto concerne i lavoratori specializzati. La cartina di tornasole per dimostrare l’importanza dei lavoratori italiani appare nettamente all’inizio del 1943: in seguito alla grave crisi economico-finanziaria e politica che colpì l’Italia e che costrinse le autorità fasciste a richiamare in patria un ingente numero di lavoratori, i dirigenti delle imprese tedesche più influenti appoggiarono il governo berlinese nel tentativo di contrastare, e successivamente ritardare, l’attuazione di tale richiesta.
Sul fronte italiano, il primo a sostenere la sospensione di nuovi invii nel giugno-luglio 1941 e a spingere per il rimpatrio dei lavoratori, tra il dicembre 1942 e il febbraio 1943, fu lo stesso Mussolini. Nel 1943 non era fondamentale solamente recuperare la manodopera indispensabile per l’industria bellica italiana attraverso i rimpatri, ma, col mutare della situazione internazionale, non si voleva “lasciare in mano ai tedeschi un “pegno” sul quale essi avrebbero potuto imbastire un’operazione di riscatto o, peggio, fare le loro vendette in caso di ritiro dell’Italia dal conflitto” (De Felice 1990, 576).
Per comprendere appieno le motivazioni che spinsero le autorità italiane a richiedere il rimpatrio dei loro concittadini dev’essere considerato anche il già citato clearing italo-tedesco. Il grande afflusso di fremdarbeiter italiani del 1941 venne accolto positivamente dagli organi dirigenti della Reichsbank, in quanto avrebbe evitato l’accumulo, da parte della Germania, di un eccesso di credito causato dai rifornimenti militari a favore di Roma. Tra il luglio 1941 e il luglio 1943, dopo un iniziale pareggio dei conti, le rimesse dei lavoratori italiani superarono il valore delle importazioni di materie prime. Giorno dopo giorno “si accumulò, proprio per effetto delle rimesse degli emigrati, un consistente credito a favore dell’Italia, che la costrinse, per poter far giungere il denaro alle famiglie dei lavoratori in Germania, a sempre più pesanti anticipazioni di cassa» (Mantelli 2001, 350). I fondi monetari dello stato italiano non erano in grado di sostenere gli altri due o tre miliardi di lire necessari a coprire le rimesse “in presenza di un forte passivo tedesco (…) che la Germania non intende, per altro, ripianare con i mezzi indicati da Roma: aumento dell’esportazione verso l’Italia, cessione di pacchetti azionari, presa in carico di una parte del passivo commerciale italiano verso paesi terzi, cessione di oro e divise» (Ibidem). Di conseguenza, nel gennaio 1943 i dirigenti fascisti chiesero ufficialmente il rimpatrio di ogni emigrato che si trovasse ancora in terra tedesca, circa 180.000 persone.
I dirigenti tedeschi non accettarono le richieste provenienti da Roma, anzi richiesero che venissero inviati altri 249.000 lavoratori in Germania e che lo stato italiano versasse ulteriori 400 milioni di marchi per le rimesse. In caso contrario, aggiunsero le autorità tedesche, ci sarebbero state ritorsioni economiche di vario tipo, come la riduzione dei rifornimenti e l’aumento del prezzo del carbone.
La situazione si sbloccò solamente il 20 febbraio, in seguito all’intervento di Hitler. Mosso principalmente da motivazioni di tipo politico, il Führer, nonostante tre giorni prima avesse ricevuto una relazione da parte dell’Auswärtiges Amt dove si affermava con dovizia di dettagli l’importanza fondamentale di almeno 120.000 lavoratori provenienti dall’Italia, si trovò costretto ad accettare le pretese di Roma per non turbare i rapporti con Mussolini in un periodo di grande instabilità per i due capi di stato. Parimenti, anche le decisioni prese a Roma erano mosse da scopi politici, cioè erano correlate alla grave crisi interna al regime che diveniva col passare dei giorni sempre più grave (Bertolo, 1974).
Così, nonostante gran parte dei dirigenti tedeschi manifestassero una notevole resistenza e cercasse di far rimanere almeno gli operai più qualificati, il 5 aprile 1943 venne firmato, presso il Ministero del Lavoro di Berlino, un accordo per il rimpatrio dei lavoratori italiani. Difficoltose trattative tra i due governi stabilirono che l’esodo di ritorno non sarebbe avvenuto in modo totale e immediato, ma che sarebbe stato scaglionato: il numero venne fissato in 12.000 unità al mese, con l’inizio del rimpatrio fissato al maggio seguente. Le prime difficoltà si presentarono già il 26 aprile, poiché molte aziende si rifiutano di lasciar andare gli operai più specializzati: ciò determinò una prima riduzione del contingente mensile. Nei mesi seguenti si susseguirono altre discussioni, alle quali partecipò lo stesso Mussolini, che portarono alla stipulazione di nuovi accordi e furono concordate differenti cifre: il 25 giugno si raggiunse l’intesa per il numero di 8.000 lavoratori rimpatriati al mese, ma i 12 luglio la quantità era già scesa a 4.000.
Le fasi conclusive della trattativa avvennero in un periodo in cui gli eventi in Italia minarono pesantemente i rapporti tra i due governi e cambiarono gli accordi presi in precedenza: il colpo di Stato e la deposizione di Mussolini del 25 luglio 1943 convinsero le autorità tedesche a bloccare ogni rimpatrio e a rimanere insensibili ad ogni tentativo di mediazione da parte del governo Badoglio. Già il giorno seguente il Führer e i dirigenti nazionalsocialisti avevano previsto che la fuoriuscita italiana dalla guerra sarebbe stata imminente e di conseguenza constatarono la possibilità di attingere indisturbatamente dal serbatoio di manodopera dell’alleato mediterraneo, in modo particolare dai combattenti, i quali avrebbero presto abbandonato il fucile e sarebbero potuti essere stati impiegati nelle aziende in Germania. Inoltre, Sauckel avrebbe potuto reperire manodopera direttamente dal territorio italiano, l’unica zona nell’Europa sotto il dominio dei nazisti a non essere ancora stata sottoposta a prelievi di cittadini.
In seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943, i circa 100.000 italiani8 che non riuscirono ad abbandonare la Germania vennero trasformati in lavoratori schiavi, furono considerati da quel momento in avanti una razza inferiore e vennero trattati al pari dei prigionieri di guerra.
2. «In Germania si vive male»
L’afflusso migratorio venutosi a creare con le stipulazioni politico-economiche dell’Asse Roma-Berlino mostra un progressivo incremento di soprusi da parte delle autorità tedesche nei confronti dei lavoratori italiani. Gli accordi iniziali erano incentrati sull’assunzione, l’arruolamento, il collocamento e l’“impiego di lavoratori agricoli stagionali italiani” (Dazzi 1942, 9). A partire dal 1938, segnala Briani (1970, 121-122)
aveva inizio un movimento migratorio collettivo, in quanto l’espatrio avveniva in gruppi organizzati e non isolatamente; stagionale ed occasionale nello stesso tempo, perché si verificava ad epoche determinate per i lavoratori dell’agricoltura, senza rigida periodicità per le altre categorie; a tempo determinato, comunque, perché i lavoratori espatriavano con un contratto, la cui durata era preventivamente fissata (in genere semestrale); e infine volontario, ma dettagliatamente regolato.
Alla facoltà di scelta da parte dei gerarchi nazisti fra gli operai che davano la propria adesione all’espatrio, corrispondeva l’effettiva facoltà dei sindacati italiani di controllare sul posto le condizioni di lavoro e di fornire diretta opera assistenziale ai bisognosi (Ibidem). Almeno durante i primi anni, infatti, il flusso migratorio venne controllato da funzionari italiani mediante spedizioni in loco nei vari distretti tedeschi, spedizioni atte a esaminare il livello medio degli alloggi e ad assicurarsi che corrispondessero a determinati criteri stabiliti dalle autorità del partito fascista. Inoltre, i funzionari statali avevano il compito di controllare che i salari venissero riconosciuti dai datori di lavoro ancor prima di essere pattuiti.
Uno dei motivi principali che spinsero decine di migliaia di italiani a scegliere di emigrare è stata sicuramente, come abbiamo già in parte segnalato, la necessità di guadagnare e di fuggire dalla disoccupazione. Buona parte dei lavoratori recatisi in Germania negli anni 1938-39 provenivano quindi dalle zone maggiormente colpite dalla sottoccupazione, e i salari tedeschi, che ammontavano ad un importo dalle due alle cinque volte superiore rispetto a quelli italiani, rappresentavano per molti una opportunità, figlia, in quegli anni, di una necessità pressochè generale. Il fenomeno dell’emigrazione permetteva a molti “di risolvere situazioni difficili e incresciose, a molte famiglie di rimettersi in piedi, a molti operai di finalmente occuparsi, di sistemare e di far fronte alle difficoltà del momento”9. Fu così che dal Veneto si segnalò
un’affannosa richiesta di libretti di lavoro e di offerte per la Germania da parte di giovani, che non hanno mai lavorato in stabilimenti industriali, quali esercenti, benestanti sfaccendati e simili. Detti aspiranti accompagnano la richiesta con pressioni non disgiunte da promesse di compensi, pur di poter partire per la Germania, al fine, confessato senza ritegno, di sfuggire in tal guisa ad un eventuale richiamo alle armi.10
Oltre alla motivazione economica ve ne erano altre che spinsero molti italiani a lasciare il proprio paese, come la possibilità di sottrarsi al servizio militare, oppure, soprattutto nei più giovani, lo “spirito d’avventura” tipico della loro età. Anche la percezione, assai diffusa in Italia, di una Germania tecnologicamente all’avanguardia diede una spinta importante verso la mobilità internazionale e il desiderio di entrare in contatto con essa, in molti casi, era irrefrenabile.
Gli esempi di richieste e di volontà di espatrio da parte di ampie fette di società italiane sono molteplici e vengono tramandate da svariate fonti, ma quel che ci interessa rilevare in questa sede sono le condizioni di tipo lavorativo, abitativo e morale che trovarono gli emigrati italiani una volta arrivati sul luogo, condizioni che testimoniano una realtà complessa. In molti casi, la volontà di rimpatriare si instillò in ampie fasce della popolazione emigrata già nel periodo precedente l’8 settembre. In seguito a quella data, però, l’aggravarsi delle già preoccupanti condizioni di vita e di lavoro provocarono in molti casi la pianificazione e l’attuazione di rocambolesche fughe, le quali furono registrate in ogni regione della Germania (Bermani 1998, 151-175).
Ma andiamo con ordine. Gli accordi presi nel febbraio del 1941 riguardanti lo scambio tra forza-lavoro italiana e materie prime tedesche, avvennero in un periodo nel quale, come ricorda Cesare Bermani (1998), “già da tempo si era entrati in una fase di passaggio da una situazione di migrazione percepita come largamente conveniente a una situazione di cui si riconoscevano ormai anche i suoi notevolissimi svantaggi” (p. 82). Inoltre, Corni (2009) aggiunge che le notizie “inviate dai primi lavoratori che si erano recati magari volontariamente, con tante speranze, a lavorare in Germania (…), segnalarono che le condizioni di vita e di lavoro erano molto peggiori rispetto a quanto annunciato con i proclami e nella propaganda” (p. 150): come effetto immediato diminuì rapidamente il flusso dei lavoratori verso il Reich, tanto che i dirigenti di Berlino furono costretti ad attuare azioni coercitive per stabilizzare la circolazione di lavoratori italiani verso la Germania.
Fin dal 1940 circolarono in ampi strati della popolazione italiana alcune notizie: si trasmise a macchia d’olio l’informazione che, a fianco degli spostamenti volontari verso il Reich, si verificava molto spesso anche un reclutamento forzato. Tali notizie diffusero la sensazione che nella terra del Führer “non si trova[sse] più nulla e si vive[sse] male”11: il mito della Germania stava velocemente crollando.
A dar forza a tale affermazione intervengono le testimonianze di molti lavoratori che accusano un istantaneo aumento del “razzismo popolare” nei loro confronti a partire dal settembre 1939. Tale situazione sorgeva in concomitanza con lo scoppio del conflitto e con la decisione del governo italiano di non scendere immediatamente in guerra al fianco della Germania, decisione che fece ritornare a galla stereotipi antitaliani e vecchie ferite mai cicatrizzate relative alla prima guerra mondiale (Bermani 1998, 127-37). A questo proposito alcuni lavoratori di Rovereto rientrati in Italia nell’ottobre 1939 raccontano di essere stati “sempre trattati bene durante la loro permanenza, ma che dopo la fine di settembre notarono nel trattamento una certa freddezza e qualcuno più esaltato dei datori di lavoro non tralasciava loro di rimproverare l’atteggiamento del nostro Governo, che farà ancora, dicevano, come nel 1914, rimanendo prima neutrale e poi abbracciando la causa dei franco-inglesi”12.
Un ulteriore vigoroso mutamento dell’animus nazista verso gli italiani si riscontrò in seguito alle vicende militari in Grecia e in Africa settentrionale. Prima di questi eventi le condizioni dei lavoratori italiani in Germania erano state accettabili, in quanto gli italiani che lavoravano presso il Reich non erano solamente i cittadini del principale alleato di Hitler, ma erano, come abbiamo abbondantemente riscontrato, anche importanti elementi dell’economia tedesca. Nel primo periodo le clausole contrattuali vennero in grande misura rispettate, le condizioni abitative risultavano accettabili ed alcune “intemperanze” non avevano destato serie lamentele e tantomeno provocato gravi reazioni contro i fautori. A partire dal 1941, però, le condizioni peggiorarono rapidamente:
attorno ai lavoratori italiani si era creata in molti luoghi un’atmosfera di insofferenza e di disprezzo e le autorità tedesche, oltre a non rispettare più le clausole contrattuali (specie quelle relative alle ferie in Italia) e ad aggirarle con cambi artificiosi di categoria e conteggi non esatti di cottimi, avevano vietato alle donne di avere anche con loro, così come con gli altri stranieri, qualsiasi contatto (…) e avevano preso ad adottare duri provvedimenti nei confronti di chi commetteva atti di indisciplina e “reati” anche minimi, come schiamazzi e ritardi nel rientrare nei campi, a curare sempre meno la manutenzione e le condizioni di vita nei campi stessi (…) e a esercitare un’azione di intimidazione e di corruzione nei confronti dei rappresentanti sindacali italiani. (De Felice 1990, 578)
Gran parte dei lavoratori giunti nel Reich con regolari contratti si erano accorti, col passare dei mesi, “che le condizioni di vita e di lavoro e il trattamento loro riservato in Germania erano ben lontani dalle clausole stipulate” (Corni 2009, 143). Nonostante le autorità italiane avessero cercato di impedire che i lavoratori non mantenessero gli impegni lavorativi presi con le aziende tedesche, ben presto si generò, tra i lavoratori italiani, un clima di malcontento e di insofferenza. Questi sentimenti si tradussero in grandi proteste, incidenti e risse con i tedeschi, che la polizia tentava di reprimere con durezza. In Italia iniziò a girare voce che “le condizioni di vita degli operai in Germania, specialmente degli italiani, [erano] «da galera»”, e le donne rimaste iniziarono a chiedersi con apprensione se fosse vero “che gli operai italiani in Germania [erano] trattati «peggio dei prigionieri di guerra»”13. L’eco di questi eventi giunse velocemente in Italia14 e il 7 giugno 1941 Mussolini, come abbiamo ricordato in precedenza, dichiarò al Consiglio dei ministri di essere intenzionato a sospendere l’invio in Germania di altri lavoratori, sia per il trattamento riservato loro dai tedeschi, sia per la necessità di manodopera in cui vessava l’Italia in quel delicato periodo, ma anche perché, affermò, “non voglio che nasca e si radichi la leggenda che vi sono popoli eletti destinati a portare le armi e altri capaci soltanto di accudire al lavoro, una specie di sottopopoli e di schiavi” (Gorla 1959, 200).
Un aspetto che creò non pochi dispiaceri e malintesi tra i due governi, tanto da chiamare in causa gli stessi Hitler e Mussolini, fu la repressione esercitata dalla polizia tedesca, secondo le disposizioni in vigore in Germania, “di quegli italiani che si rendessero responsabili di infrazioni di carattere disciplinare, come rottura del contratto di lavoro e scarso rendimento nel lavoro” (Mantelli 2001, 348), attraverso l’internamento in speciali campi di rieducazione (Arbeitserziehungslager – Ael). La polizia e la magistratura tedesche procedevano con l’immediato arresto, processo e condanna dei lavoratori accusati di infrazioni o reati, senza segnalare in alcun modo il fatto ad alcun organo sindacale o consolare italiano. Le autorità fasciste, venute a conoscenza dell’esistenza dei campi di rieducazione e del fatto che gli organi nazionalsocialisti avessero deciso di tenerli all’oscuro e di non interpellarli per le decisioni sul trattamento da riservare ai cittadini italiani, non solamente presero la decisione formale di sospendere nuovi invii, ma lo stesso Mussolini ordinò a Ciano di segnalare ufficialmente la situazione ai dirigenti di Berlino e, se necessario, di farsi dare spiegazioni da Von Ribbentrop o da Hitler stesso. L’incontro fra i tre avvenne il 25 ottobre, ma Ciano, accompagnato da Alfieri, espresse nei giorni seguenti le lamentele di Mussolini anche a Von Mackensen, Luther, Weizsäcker, Himmler e Ley. Né queste richieste, né i telegrammi inviati da Mussolini e dai suoi collaboratori ottennero i risultati sperati (Alfieri 1948, 163-5). Solamente quando venne avanzata dalle autorità romane l’esplicita richiesta che i lavoratori “inadatti moralmente e tecnicamente alle condizioni richieste per il lavoro in Germania” fossero indicati espressamente ai dirigenti italiani, i quali avrebbero così provveduto a stabilire un’adeguata punizione secondo le leggi italiane, ma che doveva essere categoricamente esclusa la detenzione dei loro cittadini nei campi di “rieducazione”, dalle autorità tedesche giunsero i primi segnali di comprensione. Il Führer garantì a Ciano che non si sarebbero più ripetuti fatti di quel tipo, poiché egli stesso aveva ordinato che nessun italiano venisse d’ora in avanti inviato nei campi di “rieducazione” e che gli indisciplinati fossero rimpatriati, così da poter essere sottoposti alle norme del proprio paese. In seguito ad un’estenuante trattativa i due governi giunsero a un compromesso secondo il quale “l’operaio indisciplinato non sarebbe stato punito in Germania ma sarebbe stato consegnato dalla polizia tedesca a quella italiana ai valichi del Brennero o di Tarvisio. Di lì sarebbe stato tradotto, in stato di arresto, al capoluogo della propria provincia d’origine; la locale Questura avrebbe deciso se limitarsi ad ammonirlo od inviarlo al confino di polizia” (Mantelli 2001, 349).
Ad ogni modo, l’incontro del 25 ottobre tra Ciano, Von Ribbentrop e Hitler portò a risultati importanti ed ebbe come effetto principale quello di distendere le tensioni tra i due paesi. Da Berlino giunsero così nuove richieste di manodopera (125.000 lavoratori), richieste che vennero considerate eccessive dalle autorità romane, ma che decisero in parte di accontentare per non urtare l’armonia ritrovata con l’alleato tedesco: il 2 marzo 1942 venne sottoscritto un nuovo accordo secondo il quale l’Italia acconsentiva l’invio di 79.600 lavoratori15. Le testimonianze raccolte da Bermani (1998), però, mostrano come anche in seguito alle assicurazioni di Hitler e agli accordi del dicembre 1941 tra i due stati, secondo i quali le “infrazioni alla disciplina del lavoro divengono di competenza della polizia italiana, vari italiani che si giudica abbiano commesso reati estranei alla disciplina del lavoro finiscono in campo di punizione” (p. 130). I carteggi tra le autorità fasciste attestano come la situazione generale non solamente non fosse migliorata, ma, al contrario di quanto stabilito negli accordi tra i due paesi, la distensione ritrovata era solamente un’illusione provvisoria. L’ispettore del PNF Domenico Mittica, durante la missione in cui il segretario del Partito nazionale fascista Aldo Vidussoni si recò in visita al fronte orientale tedesco nel 1942, affermò che “in qualche settore i nostri operai sono trattati dai tedeschi alla stessa stregua dei prigionieri di guerra delle Nazioni nemiche, menomando così la nostra dignità e dando luogo a incidenti con questi ultimi”16. Un’altra testimonianza ci perviene dalla breve comunicaione inviata il 4 febbraio dello stesso anno da Vidussoni a Costanzo Ciano, con la quale gli conferisce che “circa i lavoratori italiani si rileva ch’essi non sono ben visti; non mancano incidenti tra operai italiani e tedeschi. In pareccchi campi vengono sottratti i viveri provenienti dall’Italia; qualche dirigente assottiglia le razioni e ne vende ai tedeschi la parte sottratta”17. La mancanza di cibo all’italiana, la percezione non gradevole di quello servito dai tedeschi e la scarsità delle porzioni sono alla base delle proteste del 22 agosto 1941 alla Heinkel di Rostock e delle manifestazioni, tenutesi sempre alla metà del “41, all’Arado-Flugzeugwerke di Brandeburgo Havel, che provocarono il rimpatrio volontario di molti lavoratori. Nel settembre 1940 il marchigiano Moscatelli afferma: “il vitto, sempre a base di patate, sarebbe scarsissimo. Non potendo fuggire, perché considerati “mobilitati” si cercherebbe di procurarsi qualche malattia e i casi di autolesionismo sarebbero molteplici. Prima della guerra gli operai e i contadini italiani erano ben trattati e avevano protezioni e largo vitto, oggi, invece, oltre al disprezzo generale, il vitto sarebbe scarsissimo e il rigore aumentato”18.
Il trattamento disumano riservato ai lavoratori italiani, unito alle abitazioni fatiscenti, ai trattamenti sanitari grossolani e deficitari, agli alimenti insoddisfacenti, all’aumento progressivo del costo della vita, all’abolizione di ogni tipo di libertà nella scelta e nel movimento e alla paura legata alle crescenti lesioni, soprusi e fucilazioni – accompagnati dai bombardamenti inglesi – determinò un profondo malessere e fece si che molti di loro, già dal settembre 1940, ma in particolar modo a partire dal 1942, cercassero di fuggire dalla Germania e decidessero “di non voler ritornare perché maltrattati”19. Nel dicembre dello stesso anno un contingente di lavoratori giunto a Roma raccontò che gli italiani in Germania erano “trattati peggio dei prigionieri”, ed anche che “in certi campi di concentramento ove stavano per innalzare delle baracche, gli operai italiani [sono] stati malmenati, percossi e qualcuno persino ucciso dai tedeschi”20. Col passare dei mesi la situazione sembra addirittura peggiorare, e non è certamente avulso affermare che il lavoro degli italiani in Germania sia da considerare di tipo schiavistico.
Un capitolo importante nella vicenda dei soprusi avenuti nel Reich nei confronti dei lavoratori italiani è quello relativo ai minatori. Anche in questo caso le condizioni si aggravarono col passare dei mesi e assunsero aspetti disdicevoli soprattutto a partire dal 1942. Durante un colloquio tenutosi il 28 gennaio di quell’anno a Palazzo Venezia fra Mussolini ed Hermann Göring21 si giunse ad un accordo di vero e proprio scambio diretto tra carbone tedesco e manodopera italiana22. Mantelli (1992) ha studiato ampiamente il tema del rapporto “manodopera italiana-carbone tedesco” e, comparando “fra loro i valori raggiunti mensilmente dalle rimesse dei lavoratori italiani in Germania con quelli raggiunti dalle spedizioni di carbone tedesco in Italia”, è giunto alla conclusione che “dal luglio 1941 al marzo 1943 compreso, le rimesse degli italiani superino abbondantemente in valore il carbone tedesco, più volte addirittura del doppio” (p. 65). La tesi avanzata da Mantelli (1992, pp. 287-340) per spiegare la differenza rilevata tra i dati concernenti lo scambio “braccia-carbone” messi a confronto è incentrata sulle fluttuazioni del clearing italo-germanico: secondo la sua teoria gli alti e bassi riscontrati i nel periodo preso in esame mettono in evidenza il mutare degli equilibri fra i due stati.
Lasciando in sospeso le specificità del clearing fra gli stati contraenti dell’alleanza nazifascista, notiamo che già il mese successivo ai già ricordati accordi del 26 febbraio 1941 – che prevedevano lo scambio tra 36.000 minatori in cambio di 12 milioni di tonnellate di carbone annue –, i tedeschi non solamente non rispettarono le direttive accordate, ma, addirittura, rincararono la dose riducendo “le forniture di carbone rispetto ai quantitativi stabiliti con l’accordo del 24 febbraio 1940” (De Felice 1990, 572). Con l’accordo del 26 febbraio 1941, Giannini e Favagrossa erano riusciti a convincere Clodius a far aggiungere 50.000 tonnellate mensili di carbone ai 12 milioni di tonnellate all’anno, un milione al mese, che la Germania si era assunta l’impegno di fornire all’Italia. Come abbiamo visto però, non solamente l’accordo non venne rispettato, ma, anzi, le derrate di carbone furono diminuite a causa delle difficoltà di approvvigionamento e di trasporto. Le gravissime condizioni cui versava la situazione italiana per colpa dei mancati invii delle corrette quantità di carbone determinarono la necessità di riaprire le trattative tra i due paesi già all’indomani del giorno in cui le autorità fasciste credettero di essere giunte ad un accordo stabile e di aver finalmente conquistato la sicurezza data da continui ed affidabili approvvigionamenti, tali da poter sostenere l’industria bellica del paese. A causa dell’assommarsi di questi e di altri disguidi, come risultato finale solamente 13.703 minatori, in rapporto ai 36.000 pattuiti, giunsero in Germania alla fine di maggio23. Una delle ragioni principali dell’insuccesso di tale operazione, come avvenne per la quasi totalità degli italiani impiegati in Germania, è descritta in un rapporto dettagliato inviato il 2 maggio 1942 dall’ambasciata presso il Quirinale all’AA. All’interno del rapporto si può leggere che, usando le parole di Mantelli (1992),
sulla base di quanto riferito dal responsabile tedesco delle commissioni di reclutamento ed in seguito a colloqui con i dirigenti italiani coinvolti (Landi, Cianetti, Lombrassa, il responsabile dell’ufficio collocamento della CFLI, Mancuso), il consigliere di legazione Plessen spiega che le difficoltà incontrate sono dovute a parecchie e convergenti cause, una delle quali sarebbe la condizione spesso sgradevole in cui i lavoratori italiani si trovano nel Reich ed il modo in cui vengono trattati e valutati. (p. 334)
Alla fine dell’agosto dello stesso anno, la Bergwerksverwaltung Kleinrosseln GmbH, un’azienda mineraria dipendente dalla HGW, lamenta in un rapporto che gli italiani protestano continuamente per il cibo, giudicato “cattivo ed insufficiente”24 e sono spaventati dai bombardamenti aerei inglesi. Il problema delle incurioni aeree degli Alleati mise in luce chiaramente il sentimento dei tedeschi nei confronti dei lavoratori italiani: essi erano considerati degli individui di cui la Germania aveva bisogno e che allo stesso tempo la maggioranza della popolazione disprezzava. Tale affermazione trova conferma nei ricordi di Mario Zunino, un impiegato presso la miniera di Saarbrücken, ormai completamente rasa al suolo dagli aerei nemici, il quale afferma di aver rimosso ogni notte, durante i primi giorni di settembre, “un cartello che era affisso al di fuori di fuori di un ricovero antiaereo esistente presso la (…) miniera; cartello che portava la seguente esatta scritta in tedesco: ‘È proibito l’ingresso al ricovero degli stranieri (italiani e russi)’”25.
Queste testimonianze evidenziano come il privilegio dato dallo status di alleati rimanesse in molti casi valido solo teoricamente e che, in taluni casi, ad un lavoro di tipo schiavistico si affiancasse un trattamento umano paragonabile a quello riservato ai prigionieri di guerra. Tuttavia, come segnala Corni (2009), “parlare in generale di condizioni difficili di sfruttamento, non consente di cogliere l’esistenza di situazioni talora molto diverse da fabbrica a fabbrica, da zona a zona” (p. 153). Molti industriali, prosegue Corni, si resero conto dell’insensatezza del trattamento schiavistico relegato ai lavoratori italiani. Anche considerato sotto l’aspetto pratico, alcuni datori si accorsero che l’efficienza lavorativa aveva una tendenza a calare o a crescere proporzionalmente al rispetto prestato al lavoratore e decisero così di far “prevalere, rispetto ai pregiudizi ideologici o rispetto alle norme che il regime emanava, un minimo di razionalità economica, concedendo ai lavoratori stranieri salari migliori, condizioni di vita migliori, abitazioni più decenti, vestiario, qualche momento di licenza per poter sfruttare al meglio la loro efficienza” (p. 154). Nelle campagne, dove lavorava un terzo dei circa 9 milioni di stranieri, le condizioni erano generalmente migliori. Nell’ambiente agricolo il rapporto tra la famiglia contadina e il lavoratore loro affidato era diretto: l’intimità tra le due parti era frutto del vivere quotidiano a stretto contatto, dell’aiuto reciproco: fattori che portarono in molti casi anche a rapporti sentimentali e/o sessuali tra lavoratori stranieri e contadine tedesche, come certificano molti rapporti della polizia e le testimonianze dei fremdarbeiter italiani tornati dall’esperienza in Germania (Corni 2009, 153-154; Bermani 1998, 122-126).
3. Dopo l’8 settembre 1943
Come abbiamo visto, le condizioni generali dei lavoratori italiani nel Reich peggiorarono col passare degli anni, in particolare a partire dallo scoppio della guerra. Tuttavia, ciò che sicuramente condizionò maggiormente la loro permanenza in Germania furono gli eventi dell’8 settembre 1943. Con la deposizione di Mussolini veniva meno ogni legame tra i due paesi ed il privilegio concesso ai lavoratori italiani in Germania cadde inesorabilmente. L’aggravarsi della loro condizione, non solamente lavorativa, fu dovuta alla perdita del privilegio legato allo status di alleati che costringeva, fino al giorno prima, i datori di lavoro tedeschi ad avere nei loro confronti un occhio di riguardo. Tale condizione era fatta precedentemente rispettare dalle reti consolari italiane presenti in quei territori. Col venir meno dell’alleanze italo-tedesca ai soldati e ai datori di lavoro tedeschi erano permesse ogni tipo di libertà nei confronti dei fremdarbeiter italiani.
In seguito all’8 settembre, come sostiene Corni, gli italiani nel Reich dovettero subire, assieme ai pregiudizi ideologici ed etnici (Herbert 1985, 49-53) – molto importanti per le scelte, le valutazioni e gli impieghi di manodopera attuati dai tedeschi – anche pregiudizi di tipo politico. I civili, ma soprattutto i militari italiani catturati,
furono collocati in una categoria giuridica, diciamo così, del tutto peculiare: furono catalogati non come prigionieri di guerra ma come internati militari, e ciò legittimò le autorità nazionalsocialiste a trattare gli italiani nel peggiore dei modi. Improvvisamente, sia i lavoratori civili italiani che i prigionieri di guerra catturati successivamente all’armistizio dell’8 settembre ’43 vennero collocati al livello più basso della gerarchia razziale, ed il trattamento nei loro confronti fu intriso di violenza e di pregiudizio. (Corni 2009, 147)
Non solo, per mantenere il controllo sulle decine di migliaia di lavoratori impiegati nelle varie realtà lavorative del Terzo Reich in quel delicato momento storico le autorità tedesche scelsero di usare la pratica del terrore.
Le testimonianze dei lavoratori raccolte da Antonio Gibelli e da Cesare Bermani confermano un brusco peggioramento delle condizioni dopo l’8 settembre. Tuttavia, dal loro studio emerge anche che i lavoratori non godettero mai, nemmeno prima di quella data, delle condizioni privilegiate derivanti dal loro status di alleati. Molti dei fremdarbeiter italiani sostennero di essere sempre stati trattati dai tedeschi allo stesso modo (a volte anche peggio) dei prigionieri di guerra. Gibelli afferma che il lavoro in Germania aveva assunto “le caratteristiche di lavoro forzato soggetto a disciplina militare prima ancora che la Germania da paese alleato divenisse potenza nemica” (Gibelli 1970, 115-33). Dello stesso parere è Bermani (1998), il quale scrive:
dopo l’8 settembre 1943 i lavoratori italiani rimasti in Germania, in genere, dopo un brevissimo periodo in cui subirono il contraccolpo dell’uscita dell’Italia dal conflitto, continuarono sostanzialmente a vivere come prima. O, per meglio dire, vissero nella situazione che, già precedentemente fattasi dura per loro, andava peggiorando man mano che si avvicinava la disfatta tedesca. (p. 240)
A rendere l’8 settembre una data periodizzante e il periodo successivo decisamente drammatico per i fremdarbeiter italiani fu la sistematica e impunita opera di rastrellamento e di internamento. Da quando le due nazioni erano divenute antagoniste, gli italiani nel Reich non avevano più alcuna possibilità di appellarsi all’aiuto dello stato italiano e questo li lasciava alla mercé della morsa nazista. Ai lavoratori rimasti nel Reich dopo l’8 settembre e ai circa 650.000 Internati Militari Italiani (IMI), si devono aggiungere gli 82.517 (secondo altre fonti 88.644) civili rastrellati o assunti rispettando più o meno la volontà degli interessati e gli italiani residenti nei territori dell’Europa occidentale – Francia, Belgio e Lussemburgo – caduti sotto la forca del Reich.
Tra gli 82.517 lavoratori coatti che furono rastrellati e trasferiti involontariamente dall’Italia alla Germania tra l’ottobre 1943 e il 15 gennaio 1945 se ne contano 39.080 che decisero “spontaneamente” di lasciare un’Italia ormai fuori dal conflitto bellico mondiale per muoversi verso una Germania esasperata da continui bombardamenti scagliati dagli alleati e che ormai si avviava ad una inevitabile sconfitta. Questi sedicenti “volontari” vennero attirati in Germania dalla promessa di vantaggiosi contratti di lavoro (Bermani 1998, 248). Tali contratti, come osserva Corni (2009), non vennero nella realtà mai rispettati. Infatti, in seguito alla crisi politica del fascismo, i soggetti coinvolti “furono bloccati entro i confini del Reich e divennero indiscutibilmente dei lavoratori forzati” (p. 144). Le notizie frastagliate e confuse che giungevano in Italia dalla Germania riguardo i soprusi ai quali i lavoratori italiani dovevano sottostare e ai bombardamenti sempre più asfissianti non erano sufficienti a far desistere i “volontari” nemmeno dopo l’8 settembre. Questo a riprova di quanto le condizioni lavorative in Italia fossero critiche e non lasciassero ampie alternative.
Come abbiamo potuto constatare, tutti i lavoratori italiani che per differenti motivi finirono a lavorare nel Reich dopo l’8 settembre e che vennero “utilizzati come manodopera in una Germania che si avvicina[va] a grandi passi alla crisi finale ma che [aveva] ancora la capacità di resistere per quasi due anni” (Corni, Dipper 2006, 173), sono il risultato logico degli accadimenti e delle scelte compiute durante gli anni precedenti all’interno dell’Asse. Mi trovo in accordo con Corni e Dipper (2006) quando sostengono che “la vicenda migratoria che si snoda tra il 1938 e il 1943, al di là del particolarissimo contesto politico e istituzionale che la caratterizza, [ha] rappresentato per molti versi un punto di svolta destinato a influire, in molti e diversi modi, sui decenni successivi” (p. 173). Tale evento ebbe come risultato la creazione di modelli per la gestione della circolazione di manodopera che verranno ripresi negli anni Cinquanta e i continui flussi che porteranno nei decenni a seguire migliaia di italiani – immemori del recente passato, o semplicemente costretti dalla necessità – provenienti da ogni parte della penisola a trasferirsi per periodi più o meno lunghi in Germania.
Elenco delle abbreviazioni utilizzate
|
ACS ADAP AR BA CFLI DAGR DDI DGPS DPP GBA PA/AA RV RVK |
Archivio Centrale dello Stato, Roma Akten zur deutschen Auswärtigen Abteilung Arbeitsrecht (Sezione diritto del alvoro) Bundesarchiv (Archivio Federale), Coblenza Confederazione fascista lavoratori dell’industria Divisione affari generali e riservati Documenti diplomatici italiani Direzione generale di pubblica sicurezza Divisione polizia politica Generalbevollmächtiger für den Arbeitseinsatz (Alto commissario per l’impieo della manodopera) Politisches Archiv del Auswärtigen Amtes (Archivio politico del ministero degli Esteri), Bonn Regionalverkehr Köln GmbH |
1. ADAP, serie C, volume VI, tomo 2, documento n. 368, pp. 795-798.
2. DDI, Nona serie, Volume VI documento n. 297, pp. 282-284, allegato, datato 12 dicembre 1940; oltre che da Favagrossa il documento è firmato anche dal ministro per gli Scambi e le Valute Raffaello Riccardi.
3. Nel documento PA/AA, Diritto del lavoro, (AR), R V, n. 11, Italia, busta 2, lettera del 14 gennaio 1943, prot. R50990, indirizzata dall’ambasciatore tedesco presso il Quirinale Georg von Mackensen all’ Auswärtiges Amt.
4. PA/AA, Diritto del lavoro, (AR), R V, n. 11, Italia, busta 2, lettera del 14 gennaio 1943, prot. R50990, indirizzata dall’ambasciatore tedesco presso il Quirinale, Georg von Mackensen, all’Auswärtiges Amt.
5. Riproduzione della tabella esposta da B. Mantelli (1992), p. 33
6. Cfr. il testo integrale in PA/AA, carte Emil Wiehl, Italia, fascicolo 12, pp. 445081-096.
7. Nel dettaglio si contato 221.000 prigionieri di guerra e 1.080.000 Ostarbeiten (il nome dato ai civili sovietici deportati in Germania).
8. Come osserva B. Mantelli (1992) ci sono differenti cifre in merito, che vanno da 86.522 a 150.000; la pubblicazione periodica, curata dall’ufficio del GBA, «Der Arbeitseinsatz im Grosdeutschen Reich» (L’impiego del lavoro nel grande Reich tedesco), nn. 10/11 del 30 novembre 1943, afferma, a p. 3, che gli italiani allora occupati in Germania erano in tutto 117.548, fra cui 14.307 donne.
9. Notizia fiduciaria datata «Vicenza, 5 marzo 1941». In ACS, Min. Int., DGPS, DAGR, DPP 1927-1944, b. 223.
10. Lettera dell’Ispettore Generale di PS [illeggibile], prot. N. 02241, a Min. Int., DGPS, DPP, Roma, oggetto: Reclutamento di operai per la Germania, Milano, 24 febbraio 1941. In ACS, Min. Int.,DGPS, DAGR, DPP 1927-1944, b. 223.
11. Notizia fiduciaria datata «Roma, 8 aprile 1941». In ACS, Min. Int., DGPS, DAGR, DPP 1927-1944, b. 223.
12. Notizia fiduciaria datata datata «Rovereto, 31 ottobre 1939». In ACS, Min. Int., DGPS, DAGR, DPP 1927-1944, b. 223.
13. Notizia fiduciaria datata «Roma, 23 maggio 1941». In ACS, Min. Int., DGPS, DAGR, DPP 1927-1944, b. 223.
14. Per il diffondersi in Italia delle notizie sul trattamento dei compatrioti in Germania cfr. ACS, (1939-42). Min. Interno, Dir. gen. P.S., Polizia politica 1927-44, fasc. «Operai italiani in Germania», b. 223.
15. Di questi ne partirono effettivamente solo 50.681 poiché, come abbiamo visto, nel gennaio 1943 giunse da Roma la decisione di procedere con il rimpatrio dei lavoratori presenti nel Reich.
16. ACS, Segr. Part. Del Duce, Carteggio ris. (1922-1943), b. 50, fasc. 242/R, «Aldo Vidussoni», fasc. «Visita al Fronte Est, al Quartier Generale del Führer ed a Monaco della missione del PNF guidata dal segretario del PNF», Roma 24 ottobre 1942.
17. Cfr. DDI, nona serie, vol. VIII, pp. 261 sgg., 464 sgg.
18. Notizia fiduciaria datata «Roma, 26 settembre 1940». In ACS, Min. Int., DGPS, DAGR, DPP 1927-1944, b. 223.
19. Notizia fiduciaria datata «Cosenza, 25 settembre 1942». In ACS, Min. Int., DGPS, DAGR, DPP 1927-1944, b. 223.
20. Notizia fiduciaria datata «Roma, 22 dicembre 1942». In ACS, Min. Int., DGPS, DAGR, DPP 1927-1944, b. 223.
21. Cfr. DDI, Nona serie, volume VIII, documento n. 211, p. 230.
22 L’idea che muove parte della storiografia è che l’emigrazione di lavoratori in Germania sia da considerarsi una contropartita per i rifornimenti di materie prime, in particolar modo di carbone, Cfr Collotti 1983, 454.
23. Archivio privato Giuseppe Landi, cartella 16, CFLI, dati statistici permanenti III, Germania, Direzione dei servizi del lavoro, servizio del collocamento, pro-memoria per il presidente, datato 28 maggio 1942.
24. BA, RVK, R 10 VIII, fascicolo 54, relazione sui risultati dell’impiego di minatori italiani, datata 26 agosto 1942, pp. 21-23 del fascicolo.
25. Notizia fiduciaria datata «Genova, 21 settembre 1942». In ACS, Min. Int., DGPS, DAGR, DPP 1927-1944, b. 223.
Alfieri D. 1948 Due dittatori di fronte, Milano, Rizzoli. Bermani C. 1998 Al lavoro nella Germania di Hitler. Racconti e memorie dell’emigrazione italiana 1937-1945, Torino, Bollati Boringhieri. Berti G. 1942 Due anni di politica fascista di guerra nelle campagne e la rovina del contadiname, in “Stato operaio”, 6-7. Bertolo G. 1974 Operai e contadini nella crisi italiana del 1943/1944, Milano, Feltrinelli. Briani V. 1970 Il lavoro italiano all’estero negli ultimi cento anni, Roma, Italiani nel mondo. Collotti E. 1983 L’alleanza italo-tedesca 1941-1943, in AA. VV., “Storia della società italiana”, volume 22, La dittatura fascista, Milano, Teti, pp. 449-508. Corni G. 2009 Popoli in movimento, Palermo, Sellerio editore. Corni G., Dipper C. 2006 Italiani in Germania tra Ottocento e Novecento. Spostamenti, rapporti, immagini, influenze, Annali dell’Istituo storico italo-germanico in Trento: Quaderni, number 67, Bologna, il Mulino. Dazzi A. 1942 Accordi fra Italia e Germania in materia di lavoro e assicurazioni sociali 1937-1942, Roma, Tipografia riservata del MAE. De Felice R. 1990 Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943, I. Dalla guerra «breve» alla guerra lunga, Torino, Giulio Einaudi Editore. Gallerano N., Ganapini L., Legnani M., Salvati M. 1974 Crisi di regime e crisi sociale, in Bertolo G., pp. 3-78. Giannini A. 1954 L’accordo italo-germanico per il carbone (1940), in “Rivista di studi politici internazionali”, Anno XXI, n.3, pp. 462-468. Gibelli A. 1970 Il reclutamento di manodopera nella provincia di Genova per il lavoro in Germania (1940-1945), in “Il movimento di liberazione in Italia”, 99-100, pp. 115-33. Gorla G. 1959 L’Italia nella seconda guerra mondiale: diario di un milanese, ministro del re nel governo di Mussolini, Milano, Baldini & Castoldi. Herbert U. 1985 Fremdarbeiter. Politik und Praxis des Ausländer-Einsatzes in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlino-Bonn, Dietz. Hillgruber A. 1965 Hitlers Strategie: Politik und Kriegsführung, 1940-1941, Frankfurt am Main, Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, trad. it. La strategia militare di Hitler, Milano, Rizzoli, 1986. Mantelli B. 1992 «Camerati del lavoro». I lavoratori italiani emigrati nel Terzo Reich nel periodo dell’Asse 1938-1943, Firenze, La Nuova Italia. 2001 L’emigrazione di manodopera italiana nel Terzo Reich (1938-43), in Storia dell’emigrazione italiana, vol. 1 Partenze, P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), Roma, Donzelli Editore. Mason T. W. 1977 Sozialpolitik im Dritten Reich: Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Opladen, Westdeutscher Verlag GmbH, trad. it. La politica sociale del Terzo Reich, Bari, De Donato, 1980. Milward A. S. 1965 The German Economy at War, London, The Athlone Press, trad. it. L’economia di guerra della Germania, Milano, Angeli, 1971. Mommsen H. (cur.) 2002 Totalitarismo, lager e modernità. Identità e storia dell’universo concentrazionario, Milano, Bruno Mondadori. Morelli A. 1987 Fascismo e antifascismo nell’emigrazione italiana in Belgio 1922-1944, Roma, Bonacci. Raspin A. 1986 The Italian War Economy, 1940-1943. With Particular Reference to Italian Relation with Germany, New York and London, Garland Publishing. Ulteriori riferimenti bibliografici AA.VV. 1989 Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale, Istituto Storico della Resistenza in Piemonte, Milano, Franco Angeli. 2009 Gli internati militari italiani. Diari e lettere dai lager nazisti 1943-45, Torino, Einaudi. Bartolini A. 1965 Storia della resistenza italiana all’estero, Padova, Rebellato. Bertucelli L., Procacci G. 2001 Deportazione e internamento militare in Germania. La provincia di Modena, Milano, Unicopli. Borsetti N. 2005 La mia Resistenza non armata. Appunti e disegni di un militare italiano prigioniero nei lager della Germania dal 1943 al 1945, A. Borsetti Venier (cur.), Firenze, Morgana Edizioni. Dragoni U. 1996 La scelta degli I.M.I. Militari italiani prigionieri in Germania (1943-1945), Firenze, Le Lettere. Ferraro G. 2015 Dai campi di prigionia nazisti a Salò. Il diario di Antonio Bruni, Cosenza, Pellegrini. Fumagalli J. 2010 Diario di una Prigionia, Vaprio d’Adda, Bama. Gregori A. 2013 A scuola se piove – Memorie dal lager di un Internato Militare Italiano, Ravenna, SBC Edizioni. Hammermann G. 2004 Gli Internati militari in Germania, Bologna, Il Mulino. Natta A. 1996 L’altra Resistenza. I militari italiani internati in Germania, Torino, Einaudi. Porelli S. 2012 Il lungo ritorno da Cefalonia, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali. Schreiber G. 1992 I militari italiani internati, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio storico, Roma. Toldo P. 1993 Militari italiani deportati nella Germania nazista: Una ricerca nel territorio dell’ex D.D.R. In: Storia contemporanea in Friuli, anno 23, n. 24, pp 161–200. 1996 Italienische Militärinternierte im nationalsozialistischen Deutschland. In: Spurensuche: Stalag 304 Zeithein bei Riesa. Eine Tagung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. 25-28.4.1996, Riesa, Dresden, pp. 62–69. 1996 L’organizzazione del lavoro e le condizioni di vita in una fabbrica della Germania nazista dagli atti di un processo del dopoguerra, In: Storia contemporanea in Friuli, anno 26, n. 27, pp. 199–228. Trepaoli A.M. 2013 Reticolati. Viaggio sulle tracce degli internati militari italiani 1943-1945, Perugia, Futura.Bibliografia
Biography
Biografia


