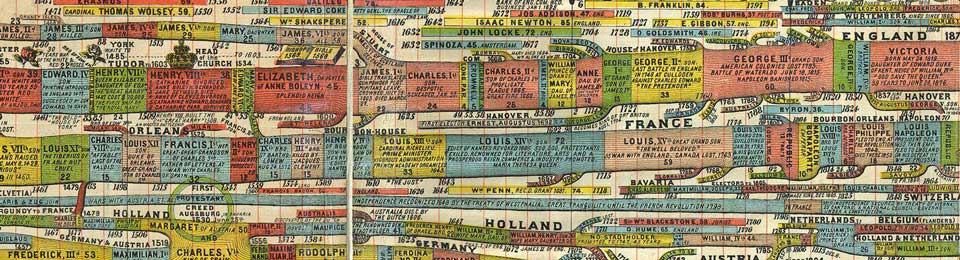
A cura di Roberto Parisini
Interviene Francesca Sofia
Introduzione
A “Storia delle istituzioni politiche” è stato recentemente dedicato un volume documentario curato da Ettore Rotelli (2012, 7), attraverso il quale si “intende dar conto di un’attività troppo spesso misconosciuta e troppo poco apprezzata nella sua consistenza, qualità e funzione sociale”.
Il lavoro traccia la storia di un cammino, ormai secolare, continuamente attraversato dalla ridefinizione di orizzonti sospesi tra il giuridico e la scienza politica, e infine progressivamente inserito in quel processo, avviato dagli anni Cinquanta, di moltiplicazione delle storie, dove “Storia delle istituzioni politiche sarebbe la storia dell’attività umana rivolta a costituire, riformare o anche soltanto rovesciare le istituzioni fondamentali delle società politiche”. La storia “propria di quelle istituzioni che di tale attività sono lo svolgimento, il risultato, lo strumento oppure l’obiettivo” (Rotelli 2012, 24).
Tappe importanti di quel processo sono state iniziative editoriali come quelle, dal 1959, dell’Isap (l’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica fondato dal Comune e dalla Provincia di Milano) e, ancor di più, dieci anni dopo l’introduzione della disciplina nelle facoltà di Scienze politiche appena riformate, che imponeva ai docenti un impegno non transitorio, né subalterno alle cattedre di storia del diritto e delle dottrine politiche. L’istituzione della prima cattedra, l’apertura di nuovi spazi accademici erano le premesse per il riconoscimento dell’importanza scientifica e didattica della “Storia delle istituzioni politiche” (Bonini 2012, 554). Più specificamente era anche un riconoscimento di funzionalità nello sforzo più generale di interpretare una fase complessa e cruciale della nostra storia nazionale; fase di forte crisi che andava visibilmente accompagnandosi, secondo un ben noto paradigma storiografico, ad un altrettanto oscuro ma intenso processo di trasformazione.
Quarant’anni dopo, siamo ancora in un contesto di forte crisi, sensibilmente diverso ma altrettanto complesso da decifrare. Di certo due pilastri del nostro mondo più recente, welfare e consumismo, vanno declinando e questo profila scenari sociali e politici assai complessi. Le istituzioni che, dagli anni Settanta, hanno distribuito il benessere e i fondamenti della cittadinanza vedono drasticamente ridimensionati i propri ruoli e i propri strumenti. Il timore è che, grattando la vernice di un cinquantennio di redistribuzione delle risorse più equilibrata ma non sostanziale, si rischi ora di veder semplicemente riaffiorare il nocciolo duro del privilegio, in un contesto generale dove a tanti appare ormai inappropriato il ricorso al cemento dell’ideologia.
Tenendo questo quadro ben presente sullo sfondo, mi pare non irrilevante parlare dello stato di salute delle discipline universitarie afferenti alla storia (che è, come scrive Rotelli con apprezzabile enfasi, “scienza sociale fra le scienze sociali”), a cominciare appunto dalla “Storia delle istituzioni politiche”.
Parliamo di ricerca scientifica ma anche di didattica universitaria, dell’attualità del loro ruolo, delle scelte, delle dinamiche e delle incidenze che possono avere nell’offrire indirizzi e quadri di riferimento tanto a gruppi dirigenti che sembrano ancora piuttosto disorientati, quanto alle più giovani generazioni che si avviano a completare, con gli studi accademici, la propria formazione e, soprattutto, a dare corpo e struttura alle proprie aspirazioni e al proprio futuro.
Dalle scienze politiche alle discipline storiche, F. Sofia
Nella mia esperienza, ricerca e didattica vanno considerate separatamente. Il mainstream della prima in questo momento mira a estendere il discorso ad una dimensione globale. La World History tiene banco e, nell’ambito che a me più interessa, la tendenza è quella della comparazione dell’antico regime europeo con contemporanee esperienze di livello extraeuropeo. Ne rappresenta una sintesi riuscita il manuale a più voci coordinato da Marco Meriggi e Leonida Tedoldi, dove esplicitamente viene richiamato “il punto di vista dell’oggi […] globale e policentrico” con il quale i diversi saggi raccolti nel volume tentano di ripensare l’avventura dello Stato moderno, inteso quest’ultimo come “punto di coagulo del quotidiano negoziato tra istituzioni e vita sociale” (Meriggi, Tedoldi 2014, 13).
Ma non è questo l’aspetto della ricerca che adesso attira la mia attenzione. Mi interessa di più ritrovare in un’organizzazione politica precedente alla rivoluzione francese soluzioni istituzionali che oggi ci possano essere vicine. Per quanto possa apparire paradossale, i contesti sono meno distanti di quanto si creda a prima vista. Come ha scritto nel manuale ricordato sopra Luca Mannori (2014, 35), man mano che le regole istituzionali che fanno capo alle grandi rivoluzioni di fine Settecento si sono dimostrate problematiche nel risolvere i problemi di una società sempre più complessa, “lo Stato d’antico regine è allora tornato a proporsi come qualcosa di ben diverso da un semplice modello negativo”. Gli esponenti della mia generazione sono cresciuti all’interno di una Weltanschaung condivisa dove c’erano sì le distanze di classe, ma vi era pure l’unità della legge: l’uguaglianza, per quanto formale, rappresentava un assioma condiviso. Era a partire da questo assioma che noi giovani militanti potevamo rivendicare l’uguaglianza sostanziale. Oggi invece, ci troviamo sempre più vicini ad un universo in cui ha cittadinanza fa capo a una pluralità di fonti giuridiche, in cui l’interpretazione giurisprudenziale prevale sulla norma, in cui sono tramontate le classi ma è ricomparso il privilegio. Auspici anche le trasformazioni che a partire dagli anni Ottanta hanno interessato il mondo del lavoro, le ineguaglianze categoriali (i ricchi e i poveri, i quadri e gli operai) si sono in un certo individualizzate, dando vita a quello che è stato definito “individualismo della singolarità” (Rosanvallon 2011, 310). E se l’individualismo nato dalla rivoluzione francese intendeva la democrazia come regime politico, avendo come sua massima ambizione il suffragio universale, il nuovo individualismo pensa la democrazia come forma sociale, in cui quello che conta è essere socialmente importante: non solo un essere umano, come affermavano le antiche rivendicazioni, ma qualcuno con una propria storia e caratteristiche proprie. E come nell’antico regime le diseguaglianze tornano dunque ad essere il frutto composito di condizioni sociali (per ciò stesso riproducibili) e di situazioni individuali diversificate. Si pensi per esempio alle nobiltà francese precedente la rivoluzione: teoricamente era tutta inclusa nel secondo Ordine della nazione, i suoi membri godevano tutti i medesimi privilegi (esenzioni fiscali, privilegi di foro, ecc.) ma solo la nobiltà più antica poteva accedere alle maggiori cariche di corte, anche se qualche volta ne era impedita dalle traballanti condizioni economiche.
Da qui la mia predilezione per uno scienziato politico come Sismondi, il quale, pur vivendo a cavallo tra Sette e Ottocento, affronta lo studio delle istituzioni coeve con un bagaglio categoriale molto più prossimo a quello vigente nell’antico regime, anticipando in un certo senso quanto gli attuali analisti politici stanno compiendo oggi. Non è certo un caso che solo recentemente sia stato riscoperto il suo pensiero politico mettendo quasi in ombra la sua fama secolare di storico e di economista. “L’un des grands théoriciens politiques du début du XIXe siècle”: così lo ha definito uno dei maggiori studiosi odierni della complessità democratica (Rosanvallon 2006, 13).
L’emersione dell’”individualismo delle singolarità” che soppianta la vecchia uguaglianza ha anche, a mio avviso, una pesante ricaduta istituzionale, perché si accompagna allo sbriciolamento dello stato sociale: nelle forme perverse che esso ha assunto in Italia, siamo spesso portati a considerarlo come una sorta di assistenzialismo, ma va ricordato che al suo esordio lo stato sociale aveva per fine l’allargamento della classe media, ossia quella classe che rappresenta il reale punto di coagulo dell’uguaglianza sociale. Mi è parso sempre assai significativo l’art. 164 della costituzione della Repubblica di Weimar, che recita letteralmente: “lo Stato deve promuovere con la sua attività e amministrativa lo sviluppo della classe media indipendente e proteggerla dall’eccessivo carico tributario e dall’assorbimento in altre classi” (Alvazzi del Frate 2003, 182). Sarà la grande crisi a farsi carico di scardinare il soggetto sociale di quell’articolo e, dietro di lui, l’intera repubblica.
Ancora una volta la crisi del welfare ci riporta ad uno scenario assai simile a quello dell’antico regime, dove erano le istituzioni private o le Chiese che si incaricavano della protezione sociale, come oggi avviene con il volontariato. Soggetti tutti, però, che non avevano e non hanno in animo di riorientare l’indirizzo della società, né di ridistribuire il reddito.
Parzialmente differente è quanto espongo a lezione, e ciò per una ragione molto semplice. La mia “Storia delle istituzioni politiche” non è incardinata in una Scuola di giurisprudenza o di Scienze politiche, ma appartiene a un corso di laurea del dipartimento di Storia. Gli studenti che mi trovo di fronte, specie quelli del triennio, non hanno una formazione giuridica, nel migliore dei casi solo coloro che hanno frequentato gli istituti tecnici possiedono qualche vaga nozione. Da qui gli argomenti della didattica si sono in qualche modo imposti da soli, sul filo dell’esperienza diretta. I ragazzi hanno una voglia disperata di capire come è organizzato uno Stato, che cosa è un governo, quali e quanti sono i modi per dargli o negargli la fiducia; quali e quanti sono i sistemi elettorali, che significa scrutinio di lista oppure scrutinio uninominale. Sono queste categorie fondamentali, di cui sembra non farsi carico la scuola superiore e che i media evocano continuamente ma in modo spesso confuso o deformato. che affronto a lezione. E lo faccio privilegiando l’aspetto genetico di ogni istituzione al fine di rendere esplicite le ragioni politiche sottese ad ogni soluzione tecnico-giuridica.
Il pretesto da cui parto è in genere un testo costituzionale: ne spiego l’origine, il contesto, le particolarità, le applicazioni successive. Il che mi consente anche di far comprendere agli studenti qual è, tutto sommato, il fine delle costituzioni. Detto in estrema sintesi, le grandi costituzioni che funzionano sono quelle che raggiungono forme di composizione in cui ciascuna delle parti presenti riesce a riconoscersi. Esemplare da questo punto di vista la più antica costituzione tuttora vigente, quella degli Stati Uniti del 1787, frutto di un complesso compromesso tra il nord e il sud, perché, oltre alla rilevanza della schiavitù, vi erano coinvolte disparità economiche e sociali difficilmente conciliabili. Da questo punto di vista, il successo della costituzione americana è consistito nel porre in essere un sistema di tipo procedurale, volto a fissare le modalità di funzionamento e non i contenuti degli equilibri politici, che dovevano invece nascere dalle concrete dinamiche politiche e sociali.
Dello stesso tenore è anche la nostra costituzione. Si pensi ad esempio al famoso articolo primo, che definisce la Repubblica “fondata sul lavoro”. La definizione è una variante della costituzione sovietica del 1918 (che definiva la Repubblica, “una libera società socialistica di tutti i lavoratori della Russia”), e da questa ripresa dalla costituzione della Repubblica spagnola del 1931( art. 1: “La Spagna è una repubblica dei lavoratori di tutte le classi”) . Quella specifica dizione, che a “lavoratori” sostituiva “lavoro” è frutto di un compromesso promosso da Fanfani di contro all’iniziale proposta di Togliatti che avrebbe desiderato un calco letterale del primo articolo della costituzione spagnola: l’espressione “sul lavoro”, secondo il suo proponente, era più consono a dar spazio all’interclassismo democristiano, includendovi anche gli imprenditori. A parere dei costituenti, attraverso il raggiungimento di questo compromesso, l’interpretazione e l’applicazione della norma (“lavoro” uguale a “imprenditori” oppure “lavoro” riferito unicamente ai “lavoratori”) sarebbero spettate, di volta in volta, al legislatore di turno. Nonostante la lunga guerra fredda, la conventio ad excludendum e tutto quel che ne è conseguito, non va mai dimentico che sono stati i partiti (comunisti compresi) gli artefici della costituzione, e ciascuno di questi vi ha potuto iscrivere e poi leggere la propria identità. Sono queste le grandi costituzioni che reggono. E la nostra ha retto fintanto che hanno funzionato i partiti che le avevano dato vita.
Naturalmente, arrivando all’oggi, questo riscontro si fa sempre più incerto. Sarei anche favorevole a qualche ritocco alla nostra costituzione, specie laddove si tratta di garantire i diritti di nuova generazione. Ma nel dibattito pubblico, quando si affronta il problema della riforma costituzionale, non è questo l’aspetto saliente: sono piuttosto i valori portanti della nostra costituzione ad essere presi di mira. E questo avviene perché la costituzione stessa non fa più parte del tessuto genetico della nostra classe politica. Tanto più ci si allontana dalla generazione dei costituenti, tanto meno i politici appaiono in grado di servirsi di questo strumento che, prima, rappresentava il motore della vita politica collettiva, dal momento che tutti erano convinti che fosse necessario attuarne i valori, pur nelle spiccate divergenze delle sue declinazioni partitiche.
La costituzione oggi ha assunto sempre più spesso una gravosità inibitoria, è diventata l’insegna che serve a marcare nettamente il confine tra ciò che la politica può fare e ciò che non può fare. La rilevanza che viepiù riveste la Corte costituzionale nell’agone politico è direttamente proporzionale alla distanza che separa le attuali classi politiche dalla costituzione, alla loro difficoltà a identificarsi con le sue norme programmatiche. Essa, in un certo senso, da scopo che era, è diventata un limite. Paradossalmente a partire dagli anni Settanta, quando la Costituzione in molte sue norme qualificanti è stata attuata, diventando più attuale e vivente che nel momento in cui era stata varata, la carta fondamentale ha iniziato a mutare di significato: per utilizzare una metafora, da faro, si è progressivamente trasformata in un semaforo (Fioravanti 1998).
È una svolta fondamentale tutta da interpretare, che meriterebbe senza dubbio tutta l’attenzione della ricerca, anche nell’ambito della disciplina storica delle istituzioni politiche; ma è anche vero che si tratta di una prospettiva indebolita da un’altra fondamentale e crescente divaricazione: quella tra riflessione scientifica e nuova classe politica. A quest’ultima, in questo momento, paiono interessare poco la visione e l’interpretazione del filosofo o dello scienziato politico, e ancor meno quelle dello storico. In altre parole, mi pare che si stia oscurando progressivamente il ruolo sociale dell’università e della ricerca. Nemmeno la sociologia, che pure accademicamente domina,anche per finanziamenti, l’intera area disciplinare SPS (a cui afferiscono, oltre alla “Storia delle istituzioni politiche”, anche “Filosofia politica”, “Storia delle istituzioni politiche”, “Storia delle relazioni internazionali”, ecc.) ottiene ormai grande udienza; mi pare che l’opinione pubblica, i politici, insomma il contesto generale non consideri più tanto rilevante che la società sia leggibile nelle sue complessità, e preferisca rivolgersi alla semplificazione dei media.
Declina insomma anche quella funzione di “consigliere del principe” che certe aree umanistiche hanno sempre avuto o che, per questo, sono addirittura state fondate. È il caso di Scienze politiche, creata addirittura dal fascismo, che ha annoverato a partire dagli anni Settanta “Storia delle istituzioni politiche” tra i suoi corsi obbligatori.
Quella di cui parliamo rimane tuttavia una ricerca che sarebbe interessante fare. Riflettendo in termini storici, anche in questo caso collocherei il principio di questa divaricazione negli anni Ottanta, gli anni del Thatcherismo, del Craxismo, del neoliberismo aggressivo degli Stati Uniti reaganiani, passando attraverso un contesto di economie globali, di crescente finanziarizzazione, di scandali e corruzioni miliardarie. Si trasforma il consumismo in consumerismo; altre sono le generazioni, individui che hanno molto relativizzato le proprie appartenenze e i propri riferimenti sociali; che hanno tutt’altra idea dei propri bisogni e della propria vita; ma la nascita del consumatore consapevole e collettivamente organizzato ha riscontri parziali e anche molto disuguali.
Come tutto questo influisce sulle forme che il potere assume nella società, sulla loro declinazione politica e istituzionale, sulla sostanza di una costituzione che si vuole come atto sociale e collettivo?
Una ricerca dentro la quale metterei anche, forse un po’ provocatoriamente, come termine di paragone una riconsiderazione in positivo (rispetto all’oggi) delle influenze del clientelismo democristiano, quello che non vira semplicemente in rapporti mafiosi, ma che incanala, seppure in modo perverso e distorto, le domande sociali nell’agenda politica, generando una sudditanza degli interessi di partito agli interessi organizzati, piuttosto che una preminenza politica tout court (sul rapporto tra clientelismo e sviluppo cfr. Eisenstadt, Lemarchand 1981).
Vi è ancora molto da definire negli orizzonti e nei soggetti, ma si tratta di una ricerca senza dubbio da fare, anche sul versante della storia delle istituzioni politiche.
Bibliografia
Alvazzi del Frate P.
2003 Testi di storia costituzionale. Raccolta di fonti legislative ad uso didattico, Torino, Giappichelli.
Bonini F.
2012 Per una storia delle istituzioni politiche in Italia, in Storia e critica della politica. Studi in memoria di Luciano Russi, in Carletti.
Carletti G. (cur.)
2012 Storia e critica della politica. Studi in memoria di Luciano Russi, Soveria Mannelli, Rubettino.
Eisenstadt S.N., Lemarchand R. (ed.)
1981 Political clientelism, patronage and development, London, Sage.
Fioravanti M.
1998 Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno, Bologna, Il Mulino.
Mannori L.
2014 Le istituzioni politiche dell’antico regime, in Meriggi, Tedoldi.
Meriggi M., Tedoldi L.
2014a Introduzione, in Meriggi, Tedoldi.
2014b (cur.) Storia delle istituzioni politiche. Dall’antico regime all’era globale, Roma, Carocci.
Rosanvallon P.
2006 La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Seuil.
2011 La société des égaux, Paris, Seuil.
Rotelli E. (cur.)
2012 Storia delle istituzioni politiche. Ricerca e docenza, Soveria Mannelli, Rubettino.


