
di Alberto Malfitano
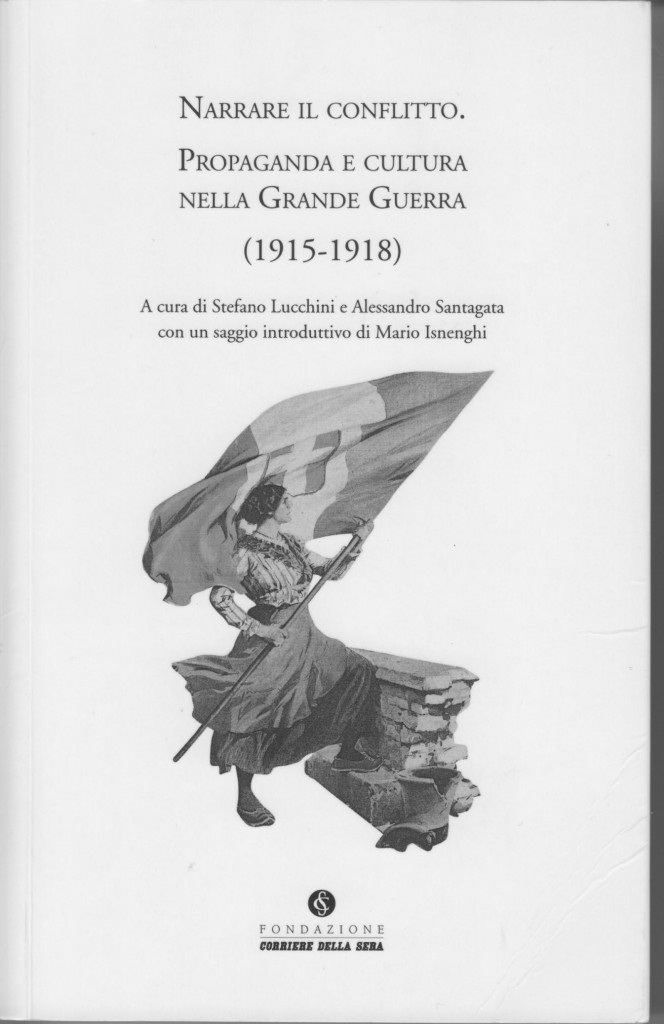 Pur essendo studiata ormai da un secolo, la Grande guerra ha ancora molto da offrire agli storici che la indagano. Nel caso di questo volume edito dalla Fondazione Corriere della Sera, il tema, di estremo interesse, è quello della narrazione del conflitto agli italiani. La comoda rappresentazione, in voga per anni, di un fronte giornalistico impedito a svolgere il proprio dovere dalle restrizioni, in primo luogo militari, imposte ai cronisti, impossibilitati a verificare cosa accadesse in prima linea e, salvo rare eccezioni, come l’Avanti!, proni di fronte alla necessità di piegare le esigenze informative a quelle belliche, oggi non regge più. Ben venga pertanto il volume curato da Stefano Lucchini e Alessandro Santagata, che va nella direzione di colmare le lacune ancora esistenti in questo campo, indagando il peso della censura e della propaganda, categorie centrali per comprendere quell’evento, sulla stampa italiana, e il ruolo del suo principale rappresentante, il Corriere della Sera.
Pur essendo studiata ormai da un secolo, la Grande guerra ha ancora molto da offrire agli storici che la indagano. Nel caso di questo volume edito dalla Fondazione Corriere della Sera, il tema, di estremo interesse, è quello della narrazione del conflitto agli italiani. La comoda rappresentazione, in voga per anni, di un fronte giornalistico impedito a svolgere il proprio dovere dalle restrizioni, in primo luogo militari, imposte ai cronisti, impossibilitati a verificare cosa accadesse in prima linea e, salvo rare eccezioni, come l’Avanti!, proni di fronte alla necessità di piegare le esigenze informative a quelle belliche, oggi non regge più. Ben venga pertanto il volume curato da Stefano Lucchini e Alessandro Santagata, che va nella direzione di colmare le lacune ancora esistenti in questo campo, indagando il peso della censura e della propaganda, categorie centrali per comprendere quell’evento, sulla stampa italiana, e il ruolo del suo principale rappresentante, il Corriere della Sera.
Il saggio introduttivo di Mario Isnenghi, tra i primi a indagare le forme di narrazione del conflitto, ripercorre l’evoluzione della propaganda nel passaggio da Cadorna a Diaz, toccando figure fondamentali per l’attività di persuasione sulla necessità della guerra, come Tullio Marchetti. Ma buona parte del libro intende individuare come ha agito, giorno dopo giorno, il Corriere della Sera, il più diffuso quotidiano d’Italia e quello che aveva assunto le caratteristiche di un “giornale partito”, secondo la definizione che ne dato pochi anni fa Simona Colarizi. Una tribuna autorevole da cui parlare all’opinione pubblica italiana per informarla ma anche influenzarne le scelte. Da quella tribuna il suo storico direttore, Luigi Albertini, parlò agli italiani per venticinque anni, e in quelli decisivi qui presi in considerazione, tra il 1914 e il 1915, fu una voce potente. L’analizza in maniera rigorosa e chiara Andrea Moroni, mettendo in luce quale fu la linea che Albertini impresse al Corriere nel corso degli anni presi in considerazione e delle fasi della vita pubblica che segnarono quel tragico periodo: il dibattito tra interventisti e neutralisti, la “guerra di Cadorna”, di cui Albertini divenne buon amico nel corso degli anni, il conflitto dopo Caporetto e con Diaz comandante supremo. Seguendo le varie tappe si comprende come e quanto il giornale di via Solferino, e le riviste consorelle, come il Corriere dei Piccoli e la Domenica del Corriere, fossero impegnati a fondo, con tutte le armi a propria disposizione, per sostenere in primo luogo l’intervento in guerra. Vi era in Albertini la convinzione che le ambizioni italiane di espansione verso l’area adriatica fossero a rischio e che con l’Impero asburgico lo scontro fosse inevitabile. Rimanere fuori dalla guerra non avrebbe portato alcun vantaggio: in caso di vittoria austriaca, le prospettive di espansione verso la costa adriatica orientale sarebbero state definitivamente frustrate da un’Austria ancora più forte mentre, in caso di sconfitta, la Germania avrebbe impedito che un’Austria indebolita si privasse di Trento, Trieste e delle coste istriane e dalmate. E’ interessante notare come, partendo dalle stesse ipotesi, Albertini giungesse a conclusioni del tutto opposte a quelle di Giolitti, che riteneva che l’Italia avesse solo da guadagnare dalla neutralità. A suo dire, infatti, se l’Austria avesse perso, le terre irredente sarebbero giunte senza colpo ferire, e se avesse vinto non ci sarebbe stata storia. Così Giolitti, che già era stata bersaglio polemico del Corriere negli anni dei suoi governi, divenne ancora di più l’obiettivo degli attacchi scagliati dal quotidiano milanese, fino all’apice del maggio 1915, in un clima di violenze e intimidazioni contro lo statista piemontese e i neutralisti in generale, che il quotidiano avallò in tal modo, come fa giustamente notare Moroni, da dimenticare per alcuni giorni l’ossequio a una linea di moderazione e di rispetto istituzionale di cui era sempre stato alfiere.
Durante la guerra, Albertini sostenne sempre lo sforzo italiano, tentando di mantenere alto il consenso e alimentando la propaganda per mantenere coeso il fronte interno, ma dovendo pagare lo scotto rispetto alla propria missione principale, informare il pubblico, spesso sacrificata sull’altare dell’enfasi patriottica, in una contraddizione difficile da sbrogliare.
La retorica e la finzione di cui erano ricchi gli articoli erano strumenti fondamentali per gli scopi di una propaganda che doveva forgiare lo spirito nazionale davanti alla terribile prova del conflitto. I primi a esserne intrisi erano i bollettini del Comando supremo, la primaria fonte di informazioni per il paese rispetto agli accadimenti bellici. Le omissioni, le sfumature, fino alle vere e proprie menzogne, erano funzionali alla demonizzazione del nemico, resa necessaria per convincere della giustezza della guerra e della missione di civiltà che vi era sottesa. Ogni nazione ebbe la necessità di offrire al proprio popolo una narrazione che lo ponesse inequivocabilmente dalla parte del ‘giusto’, un compito particolarmente arduo perché, come già scriveva Isnenghi, le nazioni in guerra appartenevano, con diverse sfumature, alla stessa civiltà, al contrario di ciò che avvenne durante il secondo conflitto mondiale, quando le differenze tra le nazioni in guerra, sotto ogni aspetto, erano ben più evidenti e percepibili. I bollettini militari furono lo strumento che per primo doveva assolvere alla funzione di dare una visione addomesticata della guerra in corso, ma la realtà, come fa correttamente notare Alessandro Santagata nel suo saggio, si prese la rivincita facendo il proprio prepotente ingresso con la rotta di Caporetto, troppo grande per essere minimizzata. La vicenda si trasformò anzi in un tragico j’accuse contro la “mancata resistenza” dei reparti italiani, secondo la celebre versione del bollettino di guerra del 28 ottobre, che tradiva, come è noto, il fossato ancora esistente tra classi dirigenti, politiche e militari, italiane e il popolo in armi, ritenuto infido, e quindi colpevole della sconfitta, dal comandante supremo.
Eppure, riportando lo sguardo sul Corriere della Sera, va sottolineato un aspetto che lo pone al di fuori del coro dei fogli italiani dell’epoca schiacciati sulla linea nazionalistica in auge. Con la resistenza sul Piave e nell’ipotesi di una sconfitta austriaca, Albertini ascoltò con attenzione le proposte di Wilson che prefiguravano un sistema dei rapporti internazionali differente da quello dominato dal nazionalismo e alternativo a quello sovietico che si stava imponendo in Russia. Il direttore del Corriere, dimostrando la sua sensibilità per il contesto globale e le novità che vi si stavano muovendo, cominciò a valutare in maniera benevola l’ipotesi della creazione di uno stato jugoslavo al di là del mare, ritendendola una valida precondizione per una pace duratura in Europa.
Quella del Corriere durante la guerra, e in generale della stampa italiana, è insomma una storia tutt’altro che scontata e ingabbiata tra le pareti della censura e della propaganda. La speranza è che altre ricerche mirino a indagare, con l’acutezza dimostrata in questo caso, il ruolo dei fogli italiani negli anni della Grande guerra.


