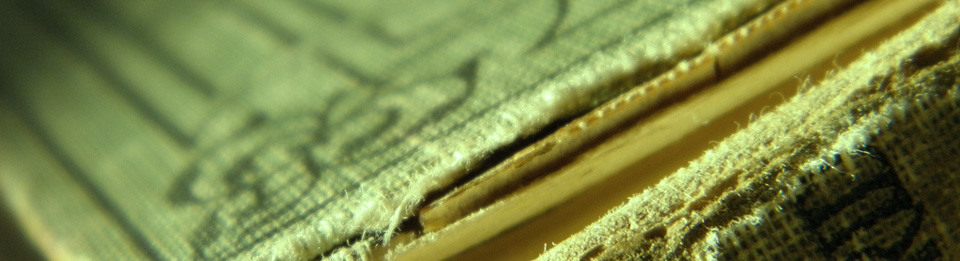
Di Alberto Gagliardo
 Laurent Binet, l’autore di HHhH (Torino, Einaudi, 2011, traduzione di Margherita Botto), che con Le benevole (id., 2008) di Jonathan Littell è senza dubbio tra i romanzi più belli e significativi tra quelli ambientati durante la seconda guerra mondiale (in particolare quelli che mettono in scena il tema difficile e terribile della Shoah), ha detto che quel conflitto è «la nostra guerra di Troia».
Laurent Binet, l’autore di HHhH (Torino, Einaudi, 2011, traduzione di Margherita Botto), che con Le benevole (id., 2008) di Jonathan Littell è senza dubbio tra i romanzi più belli e significativi tra quelli ambientati durante la seconda guerra mondiale (in particolare quelli che mettono in scena il tema difficile e terribile della Shoah), ha detto che quel conflitto è «la nostra guerra di Troia».
Intendeva che quel periodo è un generatore di storie e di racconti destinato a durare a lungo; e lo è soprattutto se lo intendiamo nel senso in cui la storiografia oggi lo racconta, cioè come momento apicale della storia europea (ma non solo), le cui radici affondano almeno nel 1914-18, e le sue ramificazioni si estendono almeno fino al 1989-91: il «secolo breve», insomma.
Proprio a quel pozzo va ad attingere le sue storie il romanzo di Giaime Alonge, Il sentimento del ferro (Roma, Fandango Libri, 2019, 461 pagg., € 20), ma, a differenza degli altri due prima citati, qui l’Autore fa qualcosa di diverso e di più: come in Underground, il film del 1995 di Emir Kusturica, la vicenda che si genera negli anni del secondo conflitto mondiale scava sotto la superficie della Storia per riemergere nel 1982 sotto altre forme e in nuovi contesti internazionali, a ricordarci che da lì continua a venire tanta parte del nostro presente.
Giaime Alonge, già autore del romanzo L’arte di uccidere un uomo (Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2009), insegna Storia del cinema all’Università di Torino, e ha collaborato come sceneggiatore con Daniele Gaglianone, e dunque conosce bene i meccanismi narrativi (di plot e di montaggio) che inchiodano il lettore a una trama, spingendolo a precipizio verso lo scioglimento conclusivo. Ma conosce bene anche la storia del Novecento (almeno tre delle sue pubblicazioni scientifiche si confrontano con questo periodo storico) e ce la racconta contemperando l’acribia dell’accademico con la tecnica dell’action movie writer.
Il luogo dove la vicenda narrata ha il suo cuore generativo è il Lager istituito dalla Germania nazista a Działdowo, Soldau in tedesco, visto che, dopo la campagna di Polonia, quella regione fece parte della Prussia orientale.
Quel campo fu realizzato nell’inverno 1939-1940, su impulso di Reinhard Heydrich, da Otto Rasch. Inizialmente fu un Durchgangslager (Dulag), o campo di transito, ma in seguito all’Aktion T4, vi furono internati i malati mentali dei sanatori della Prussia orientale e, dal 21 maggio all’8 giugno 1940, 1.558 pazienti vi furono uccisi, utilizzando il gas di scarico reimmesso all’interno di un camion, dal commando di Herbert Lange, comandante di Chełmno.
Chiusa quella fase “eugenetica”, durante l’estate del 1941 Soldau fu riorganizzato come Arbeitserziehungslager e i prigionieri vi furono destinati a lavori agricoli forzati. Il campo fu chiuso nel gennaio del 1945; 13.000 dei 30.000 prigionieri furono uccisi.
Fin qui la Storia, come la leggiamo sui saggi scientifici e sui manuali scolastici.
Non lontano da questo Lager, più esattamente nella tenuta del barone antinazista Wilhelm von Lehndorff (il cognome, non per niente, è lo stesso di uno dei partecipanti all’operazione Walkiria, l’attentato a Hitler del 20 luglio 1944), il maggiore delle SS (Sturmbannführer) Hans Lichtblau, trent’anni, dottore in chimica vegetale, viene messo dall’Obergruppenführer Heydrich in persona al comando di un programma che studi la possibilità di sintetizzare farmaci per la sterilizzazione degli ebrei, prima, potenti analgesici da somministrare alle truppe durante il conflitto, poi, possibili usi militari dell’appena sintetizzato LSD, in ultimo.
Tale ricerca prevede l’utilizzo di detenuti come cavie per esperimenti scientifici o come assistenti negli stessi. Di questo gruppo misto («battezzato Gardenia da un Kapo particolarmente faceto», p. 128) fanno parte anche Shlomo Libowitz, un ebreo polacco di estrazione contadina, e Anton Epstein, un ebreo ceco alto borghese (studente di medicina, perfettamente assimilato), che vedono morire tutti i loro compagni di prigionia. Loro però sopravvivono e, un ventennio dopo, sebbene abbiano fatto scelte diverse (mentre Shlomo è andato a vivere in Israele e ha abbracciato la versione più nazionalista del sionismo, Anton è tornato a vivere a Praga ed è rimasto fedele al suo originario spirito socialista e internazionalista) vengono coinvolti in una spietata caccia a Lichtblau, che era riuscito a salvarsi grazie alla rete di protezione messa in piedi anche con la collaborazione della Chiesa e che ha assunto una nuova identità (e non sarà un caso che Alonge ha dato all’antagonista del romanzo il cognome dello studioso americano che ha indagato proprio il tema de I nazisti della porta accanto. Come l’America divenne un porto sicuro per gli uomini di Hitler, Torino, Bollati Boringhieri, 2015).
La vicenda, come si ricava da questa sintesi necessariamente reticente, si dipana su due piani temporali, il primo dei quali va dal 9 settembre 1941 al 18 maggio 1948, il secondo dal 25 giugno al 5 agosto 1982, che si alternano con regolarità assoluta nel corso di tutto il racconto. Tra essi, però, si tendono fili sottili ma robustissimi, capaci non solo di sostenere la trama serrata del racconto, ma anche di governare l’ordito ampio della costruzione storica e geopolitica, sempre molto puntuale.
Il risultato è un romanzo efficace, avvincente e rigoroso, pieno di sorprese, che sa tenere insieme fatti e personaggi storici con altri di invenzione, secondo la migliore tradizione del romanzo storico e che può, a buon diritto, configurarsi come uno dei prodotti migliori del cosiddetto new italian epic.
Partecipando alla caccia che i due protagonisti danno al nazista Lichtblau, il lettore viene condotto in un viaggio attraverso un Novecento in cui si rincorrono echi e risonanze insospettate, dove fatti, persone, cose degli anni Quaranta riappaiono in posizioni e forme insospettabili negli anni successivi.
Non potendo dire dei protagonisti per non svelare troppo, prendiamo ad esempio i caccia Messerschmitt Bf 109 che nel primo capitolo, il 9 settembre 1941, in piena operazione Barbarossa, scortano un commando di Fallschirmjäger (paracadutisti tedeschi) in cerca del materiale segreto prodotto in una stazione sperimentale sovietica; ebbene ritroviamo quei velivoli il 18 maggio 1948, nel 79° capitolo del libro, il penultimo, trasformati in Avia S-199 che operano nell’ambito della guerra arabo-israeliana. L’Avia S-199 fu infatti un aereo monoposto, costruito dall’omonima azienda cecoslovacca, parte delle industrie pesanti Škoda, che fu il primo caccia utilizzato dall’aviazione militare israeliana (Heyl Ha’Avir) durante il conflitto esploso all’indomani della proclamazione dello stato di Israele. Venne realizzato grazie ai progetti e ai componenti proprio del Messerschmitt Bf 109, prodotto sempre in Cecoslovacchia per la Luftwaffe durante l’occupazione, e differiva dal modello originale solo per il diverso propulsore che montava.
Un altro esempio ci viene da un flash-back di Shlomo, che, mentre sfugge a un inseguimento nel ghetto di Łodz, ricorda come qualche anno prima avesse assistito a una conferenza del leader sionista Vladimir Jabotinsky, che in quella occasione venne introdotto da un oratore piuttosto fiacco, all’epoca venticinquenne, che rispondeva al nome di Menachem Begin. Il nome di colui che sarà primo ministro israeliano dal 1977 al 1983, più volte ritorna o aleggia nella storia narrata, sia quando si rievoca l’attentato del 22 luglio 1946 al King David Hotel (91 morti: 28 britannici, 41 arabi, 17 ebrei e 5 persone di diversa nazionalità), sia nell’ultimo capitolo di cui si dirà più diffusamente di seguito.
Ma dietro queste (e altre) continuità ce n’è una che tutte le racchiude e che tutte esprimono, la più inquietante, quella espressa icasticamente nella quarta di copertina del libro: «La cosa peggiore che può farti il nemico è renderti uguale a lui». Anche per la posizione che assume nel testo, tale frase diventa davvero il suggello della vicenda e ne sintetizza il suo conradiano heart of darkness (e con esso quello dell’intero Novecento e, forse, dell’intera Storia).
L’interrogativo che Alonge si pone e rivolge anche al lettore, con particolare evidenza nell’ultimo capitolo, è se tutto l’orrore (altra parola conradiana!) distruttivo da cui Anton e Shlomo provengono possa giustificare il trattamento che, ad esempio, i sionisti dell’Irgun (l’organizzazione paramilitare terroristica in cui militava Begin) riservarono ai palestinesi arabi a Deir Yassin, dove tra il 9 e il 10 aprile 1948 furono uccise oltre cento persone tra uomini, donne, anziani e bambini; o la cacciata di intere famiglie arabe, con la relativa distruzione delle loro case.
Lo spettro di quel dilemma si pone, con forza sintetica, anche a uno dei protagonisti del libro quando, inseguendo Lichtblau, oramai vicino al termine di una vendetta meditata da anni, per non rischiare di perderne le tracce si rivolge a una donna inerme, che sicuramente lo aveva visto fuggire, cui estorce l’informazione puntandole una pistola alla tempia (davanti agli occhi del figlioletto terrorizzato), ma soprattutto minacciandola di tornare a bruciarle l’abitazione nel caso in cui avesse mentito:
In vita sua, Shlomo Libowitz aveva fatto alcune cose di cui non andava molto fiero, ma una cosa simile non l’aveva mai fatta, e una parte di sé se ne vergognava. Suo padre Baruch se ne sarebbe vergognato. E anche Rivka. Ma loro non c’erano. Loro non dovevano catturare Lichtblau (p. 448).
Qui dunque c’è il tema di fondo del romanzo, posto, tuttavia, in maniera interrogativa, dunque problematica, non assertiva né dogmatica. Il tema è quello della vendetta, meglio ancora della sua liceità e legittimità, delle sue forme e dei suoi limiti. Ci si chiede se avere visto il male negli occhi, anche quello più estremo della Storia, assolve sempre e comunque da ogni colpa; se le politiche dello stato di Israele non condannino i suoi cittadini e gli ebrei tutti a una nuova prigionia identitaria e nazionalista, dunque a trasformarsi in vittime di sé stessi.
Una spia linguistica di questa ambiguità è rappresentata dal fatto che è con la stessa formula, «ci vengo io» (pp. 118 e 394), che Anton si arruola nel Kommando Gardenia e Shlomo nei gruppi sionisti che organizzavano l’immigrazione clandestina verso la Palestina sotto mandato britannico e la lotta anti inglese.
Ma per non scadere in schematiche condanne o assoluzioni, il racconto spinge contemporaneamente il lettore a chiedersi che ne può essere dell’utopia sionista originaria, libertaria ed egualitaria, quando essa è passata per il fuoco dei crematori; che cosa possa restare dell’umano quando, come Shlomo a Soldau, hai visto uccidere tuo padre davanti ai tuoi occhi, quando il tuo popolo è stato sterminato a milioni senza pietà.
Il finale, coerentemente con l’impianto “laico” dell’approccio, rimane aperto: i due protagonisti compiono scelte divergenti, senza che però l’uno si erga a giudice di quella dell’altro; anzi ognuno risulta in qualche modo consapevole dell’aspetto di “bontà” (meglio: di “necessità” o forse di “inevitabilità”) di quella dell’altro – per la quale, anzi, sembra provare una sorta di “nostalgia” (più evidente in Shlomo, che nelle ultime righe del romanzo è sgomento di fronte a una tv che trasmette, pare di capire, le immagini del massacro di Sabra e Shatila).
Per tutte queste ragioni Il sentimento del ferro, dietro la sua forma coinvolgente e, se il termine non fosse viziato da un’accezione sminuente, vorrei dire “pop”, è un romanzo di spessore, maturo, anche (soprattutto?) per l’uso che fa della Storia, di cui quasi ad ogni pagina restituisce la complessità, la stratificazione, la problematicità.
Ci mette di fronte alla evidenza che ogni storia contiene sempre al suo interno numerose contraddizioni; che non c’è mai una sola verità da narrare, ma sempre molteplici punti di vista su quella realtà.
Prendiamo il discusso ruolo della Chiesa in questa vicenda novecentesca, cui si è fatto cenno nelle righe precedenti. Anche a questo proposito il romanzo di Alonge restituisce entrambi i volti con cui questa istituzione si pose di fronte alla Shoah: da un lato quello di monsignor Alois Keller che protesta con Lichtblau contro le “azioni” dei tedeschi nei confronti degli ebrei e per questo viene deportato a Dachau; dall’altro quello del suo segretario Witold Grabski, che invece condivide l’antisemitismo hitleriano e, spinto anche dal ricatto della Gestapo, collabora in seguito al salvataggio dei criminali nazisti.
Oppure le forme di lotta adottate da alcuni gruppi sionisti, che, provocando anche tra gli stessi ebrei profondi dubbi, mostrano risvolti o prospettive paradossali:
L’anno precedente quelli dell’Irgun avevano lanciato una campagna terroristica contro le truppe britanniche in Palestina. Certo, gli inglesi dovevano andarsene, ma sparargli addosso mentre era ancora in corso la guerra con la Germania era una pura assurdità. Begin si era di fatto alleato con Hitler (p. 377).
“Non abbiamo diritto anche noi ad avere una patria?”, lo incalzò Dov.
“Certo”, rispose Marc, convinto. “Però, se per avere una patria dovevamo cacciare la gente da casa sua, allora sarebbe stato più giusto prenderci la Baviera (p. 455).
Ma prima ancora di tutte le singole questioni, solo alcune delle quali abbiamo provato qui a enucleare, questo romanzo ci ricorda, con il linguaggio proprio del “genere”, che lo studio della Storia, soprattutto oggi che le scelte ministeriali tendono a relegarla negli angoli dei curricoli scolastici, è una palestra di metodo e di civiltà, perché insegna a non accontentarsi delle risposte semplici o semplificate, a cercare negli avvenimenti sempre le cause profonde, che vanno indagate con strumenti di precisione, presi a prestito da differenti ambiti disciplinari e perciò chiedono impegno, studio, fatica, ascolto, analisi, critica.
Ci suggerisce, infine, che occorre sempre mettersi in cerca di domande scomode e provare a rispondere con attenzione e rispetto dei fatti, ma più ancora delle vittime. Tutte.
Perché la cosa peggiore che può farti il nemico, è renderti uguale a lui, anche nell’ignoranza o nella superficialità.


