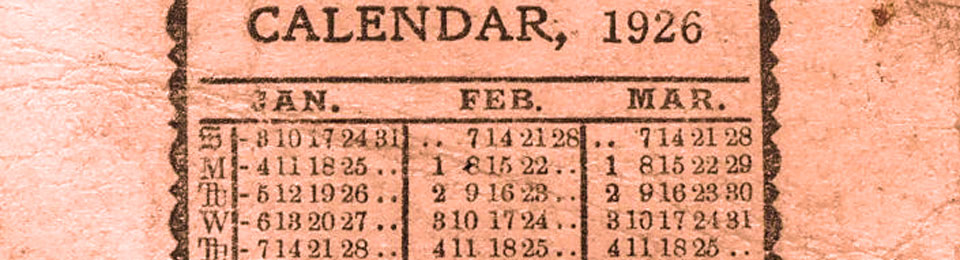
Federico Chiaricati
Venerdì 7 febbraio 2014 si è tenuto, a Bologna, presso la Sala del Refettorio dell’Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il seminario Far da sé, insieme. Le tradizioni associative in Emilia-Romagna dal mutualismo al Terzo settore, in occasione della Prima edizione della Festa di Clionet, associazione di ricerca storica attiva da alcuni anni in Emilia-Romagna e nelle Marche (www.clionet.it).
L’introduzione ai lavori di Carlo De Maria, presidente dell’Associazione, ha inteso spiegare la scelta tematica intorno alla quale si è organizzato il seminario (in sostanza, le due parole-chiave “autonomia” e “associazione” e la loro declinazione territoriale), a partire da alcune caratteristiche culturali che contraddistinguono la rete di amici e collaboratori di Clionet; un network di studiosi trenta-quarantenni la cui formazione storiografica è stata influenzata da due crisi avvenute sul finire del secolo scorso. La prima, tutta italiana, riguarda la fine dei partiti ideologici, che ha portato anche all’affievolirsi di un filone storiografico di particolare rilevanza nel nostro paese, e cioè la storia dei partiti. Questo mutamento ha condotto alla riscoperta delle forme di partecipazione e azione sociale esterne o marginali rispetto alla più stretta dimensione partitica. Lo studio delle reti informali, dei percorsi individuali e collettivi ha, così, avuto una certa fortuna negli ultimi vent’anni.
Il secondo elemento di crisi individuato da De Maria è il declino del modello europeo di democrazia industriale e welfarista. Una esperienza che ha condotto a scavare nuovamente fino alle origini della storia del movimento operaio e socialista, recuperando in particolare l’idea ottocentesca dell’autonomia del sociale rispetto allo Stato, che può dirsi alla base del mutualismo e della cooperazione. Pensando all’oggi, dunque, la domanda da porsi è come il patrimonio di autonomia sociale che ci viene dalle esperienze mutualistiche e cooperative ottocentesche possa aiutarci a rivitalizzare il welfare, correggendone laddove necessario l’impostazione centralistica e burocratica. In tutto questo, naturalmente, può giocare un ruolo la galassia del Terzo settore. De Maria fa cenno all’opportunità di valorizzare appieno la riforma del titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 (che ha introdotto la sussidiarietà nella Carta fondamentale), lavorando a una compiuta integrazione del momento statale, da una parte, e dell’autonoma iniziativa della cittadinanza, dall’altra. In quest’ottica sono centrali le idee di Pino Ferraris (Ieri e domani, Edizioni dell’Asino, Roma 2011), per il quale, ricorda De Maria, sperimentare forme associative nuove, recuperando la memoria delle esperienze passate (in particolare, quelle nate nell’ambito del movimento operaio e socialista a cavallo tra Otto e Novecento), significava riscoprire il gusto di “fare società”.
In conclusione, il presidente di Clionet ha osservato come la storia del movimento di emancipazione in una terra come l’Emilia-Romagna ci lasci in eredità sia esempi di “associazionismo per” (che esprimono l’autonomia, il far da sé solidale) sia forme di “associazionismo contro” (cioè, di estrema conflittualità); ebbene, in un momento storico come quello odierno in cui il conflitto sociale è frammentato e non ha più il valore di crescita collettiva che ha espresso per buona parte del XX secolo, secondo De Maria è la cultura dell’autonomia, più di quella del conflitto, che deve essere riscoperta e valorizzata.
A questa corposa introduzione, sono seguite undici brevi relazioni, che hanno affrontato, per periodi storici diversi, e sotto angolature differenti, il manifestarsi e lo svolgersi di reti autonome di azione politica e sociale, cercando di individuarne le caratteristiche di fondo.
L’intervento di Antonio Senta, assegnista di ricerca all’Università di Trieste, si è concentrato sulla storia della Prima Internazionale e, dunque, sugli anni Sessanta e Settanta del XIX secolo. Senta ha introdotto il proprio discorso con una citazione risalente a circa centocinquant’anni fa: “l’operaio ha fatto tutto e tutto può disfare, perché tutto sa rifare”, parole riprese più recentemente da un certo operaismo italiano. L’affermazione è di Ippolito Dalvit, fabbricante di ferri chirurgici di precisione ed esponente della Prima Internazionale in Emilia, a Bologna in particolare. Proprio nella città emiliana, tra il 17 e il 19 marzo 1872, si tenne quello che può essere definito il primo congresso regionale dell’Internazionale nel nostro paese, in corrispondenza dell’anniversario della Comune di Parigi (in quella occasione fu inaugurata la bandiera del Fascio operaio bolognese). Solamente alcuni mesi più tardi, nell’agosto 1872, sarebbe stata ufficialmente fondata, a Rimini, la Federazione italiana dell’Associazione internazionale dei lavoratori. Furono allora riaffermati due principi fondamentali dell’Internazionale in Italia, e cioè il suo carattere federale (sottolineandone, quindi, l’impronta antigerarchica e antiautoritaria) e la contrarietà alla conquista del potere politico (rimarcando, così, la vicinanza alle idee di Bakunin rispetto a quelle di Marx). La Federazione italiana nasceva su queste basi ideali e territoriali (con il fulcro tra Emilia, Romagna e Toscana), costituendo ciò che Pier Carlo Masini ha definito “il primo partito socialista italiano”. Senta ha concluso notando come la vita interna dell’associazione conobbe un doppio livello: da una parte, era un organismo di massa, di resistenza e di lotta sindacale (divisa in sezioni di mestiere), a cui prendeva parte un proletariato prevalentemente urbano, di natura semi-artigianale; nello stesso tempo, però, era un’organizzazione insurrezionale con al suo interno una struttura segreta composta dai cosiddetti “fratelli”, uniti tra loro da giuramento. E in questo era del tutto simile alle altre organizzazioni rivoluzionarie sette-ottocentesche, ad esempio a quelle di matrice risorgimentale.
La relazione successiva, quella di Alberto Ferraboschi (responsabile dell’Archivio storico della Provincia di Reggio Emilia), ha dedicato attenzione al rapporto tra municipi e associazionismo popolare nei decenni a cavallo del 1900, adottando quattro diverse prospettive: politico-istituzionale, sociologica, amministrativa ed economica. Il primo ambito, che vede come cesura fondamentale le elezioni amministrative del 1889, le prime a suffragio allargato, corrisponde a quello che si può definire come processo di istituzionalizzazione del tessuto delle pratiche sociali e delle forme di aggregazione popolare. Con l’allargamento del corpo elettorale, cioè, si affermano sulla scena pubblica ampi settori popolari e della piccola borghesia artigianale. Lungo la via Emilia si possono ricordare i “laboratori” politici e sociali di Imola e Reggio Emilia, grazie alle figure di Andrea Costa e Camillo Prampolini, mentre solo successivamente emergeranno esperienze “avanzate” anche nella fascia appenninica. Il secondo ambito affrontato da Ferraboschi, quello sociologico, richiama la metamorfosi della classe dirigente locale in rapporto all’ascesa dell’associazionismo; in altre parole, il passaggio dalle vecchie élite di matrice aristocratica e borghese alle nuove di impronta popolare. Si arriva, così, al governo locale dei partiti di massa, realizzatosi attraverso le esperienze del municipalismo popolare.
Benché gradualmente, il rapporto tra istituzioni e associazionismo si traduce sul piano delle culture e delle pratiche amministrative, introducendo il terzo aspetto analizzato dalla relazione di Ferraboschi, quello propriamente amministrativo. Si assiste, a tal proposito, al superamento dell’impostazione prettamente liberale della divisione tra politica e amministrazione; per i nuovi ceti popolari, infatti, le amministrazioni locali non dovevano essere delle semplici istituzioni apolitiche, neutre, ma dovevano invece diventare degli strumenti politici capaci di affrontare i problemi e proporre riforme importanti. Nelle amministrazioni comunali, si assiste in questo periodo a una forte politicizzazione attraverso l’espansione dell’azione pubblica locale e forme di sperimentazione istituzionale. L’esempio più importante è sicuramente rappresentato dalla municipalizzazione dei servizi pubblici. L’ultimo ambito toccato da Ferraboschi riguarda proprio la dimensione economica, rispetto alla quale, oltre alla novità delle aziende municipalizzate, il relatore ricorda come il radicamento sul territorio delle Camere del Lavoro porti a un incremento dei servizi e delle tutele di natura socio-economica per gli strati popolari. Grosso modo negli stessi anni, si apre per le cooperative la possibilità di partecipare agli appalti dei lavori pubblici, incrementano in questo modo una importante forma di associazionismo economico. Ferraboschi ricorda, in conclusione, gli elementi di antagonismo e tensione che si manifestarono tra “centro” e “periferia”, cioè tra amministrazioni rosse e governi nazionali, i quali, almeno in una prima fase, interpretarono come un pericoloso fattore di eversione le espressioni del protagonismo popolare di cui si è appena parlato.
Fabio Montella (Istituto storico della Resistenza di Modena), passando alla fase storica successiva, si è concentrato sulle conseguenze che lo shock della Grande Guerra produsse sulle forme e sulle possibilità di autorganizzazione dei ceti subalterni. Le pratiche mutualistiche, che avevano a loro volta sostituito precedenti logiche caritative e corporative, vennero scardinate da un inedito interventismo dello Stato, sempre più pervasivo in ogni campo della vita popolare. Attraverso il moltiplicarsi di organizzazioni e comitati legati alla guerra, si consolidò la presenza dello Stato sul territorio: uno dei principali effetti e lasciti della Grande Guerra. Il crescente ruolo del potere pubblico portò a una svolta nel lungo processo di evoluzione dei diritti di cittadinanza, sia come “freno” che come “impulso”. Durante la guerra si registrò, infatti, una stretta sui diritti politici e civili, ma si ampliarono contemporaneamente i diritti sociali: previdenza, tutela del lavoro e assistenza. Si arrivò, in sostanza, all’inserimento del singolo individuo non più nel corpo della comunità locale, ma in quello dello Stato-nazione, con una perdita secca di autonomia dei singoli e dei gruppi in cambio di alcune garanzie sociali.
La relazione di Enrico Acciai (Istituto storico della Resistenza di Livorno) ha messo a fuoco il tema dell’associazionismo durante l’esilio antifascista, partendo dalla esperienza di ricerca compiuta dal relatore sui volontari italiani che si recarono in Spagna a combattere per la Repubblica. L’abbandono delle famiglie da parte dei combattenti comportava spesso per mogli e figli la perdita dell’unico sostegno economico. Da qui, l’importanza (e il ruolo esemplare) delle reti di mutuo supporto che nacquero intorno a quella esperienza, coinvolgendo direttamente o indirettamente interi nuclei familiari. Dopo questa premessa, l’intervento di Acciai ha allargato lo sguardo al fenomeno dell’emigrazione politica italiana tra le due guerre mondiali. In Francia, come altrove, le reti mutualistiche (nella forma di cooperative, società di mutuo soccorso e comitati pro-vittime politiche) si crearono più facilmente laddove c’erano esuli della stessa zona di origine, con consolidati rapporti fiduciari tra loro. A spingere gli emigrati a unirsi in comitati e associazioni erano essenzialmente tre fattori: la precarietà lavorativa (con un forte rischio di marginalizzazione in terra straniera); la pressione continua e costante della polizia fascista, con l’infiltrazione di spie e provocatori che potevano più facilmente ingannare e raggirare persone isolate; l’atteggiamento di diffidenza delle autorità del paese di accoglienza (gli esuli andavano in Francia pensando fosse un paese disposto ad accoglierli a braccia aperte, mentre la realtà era molto diversa). Si tratta, nota Acciai in chiusura, di elementi poco trattati dalla storiografia dell’antifascismo, che è sempre stata molto più interessata alla dimensione politica che a quella sociale.
L’intervento seguente, di Toni Rovatti (redattrice di “E-Review”, la nuova rivista on line degli Istituti storici emiliano-romagnoli), si è concentrato su un periodo particolarmente travagliato della storia italiana, e cioè l’autunno-inverno del 1943, caratterizzato da un grave vuoto di rappresentanza istituzionale, ma anche dalla nascita della Resistenza. La necessità di associarsi che si manifesta in quel frangente, non è tanto un riemergere del “politico” o del “partitico”, bensì un’esigenza prima di tutto individuale, quasi egoistica: la necessità di difendersi e “salvare la pelle”. Fondamentale, per comprendere questa nuova pulsione ad associarsi, è leggere la cronologia dei bandi della Repubblica sociale italiana (RSI). Il primo bando è del novembre 1943 e richiamava alla leva le classi ’23-’24-’25, chiedendo la presentazione in caserma di quei giovani entro il 30 novembre; il successivo è del febbraio 1944, a questo seguirono altri bandi a maggio e giugno. In sostanza, tutti gli uomini dai 18 ai 30 anni vennero richiamati alle armi: per costoro il primo problema a porsi è quello di difendere se stessi, allontanandosi dai territori d’origine. Si formano, così, gruppi di “renitenti”, che col tempo diventano “resistenti”. Nascono progressivamente delle reti che, secondo Rovatti, favoriscono uno scatto di consapevolezza politica e civile, portando a una responsabilizzazione e a una auto-legittimazione come “partigiani”. Solo nei mesi successivi, nelle formazioni che riescono a superare la prima repressione nazi-fascista, emerge il forte attivismo dei partiti antifascisti. Siamo già nel 1944. Gradualmente, le formazioni partigiane diventano il punto di riferimento delle popolazioni locali, come si può vedere dall’esperienza emiliana di Montefiorino e in altre “zone liberate”. Se fino al giugno 1944, tanto per fare un esempio, le denunce della cittadinanza venivano rivolte alla Guardia nazionale repubblicana (la GNR fascista) o ai carabinieri; più tardi ci si rivolgeva invece alla “polizia partigiana”. Subentrò, insomma, un riconoscimento istituzionale, un farsi Stato, che la Resistenza esprimerà nella maniera più alta nell’immediato dopoguerra.
Passando proprio agli anni del dopoguerra, Alfredo Mignini (del collettivo studentesco “Il Caso S.”) ha impostato il suo intervento sull’associazionismo comunista, concentrandosi in particolare sull’esperienza di Solidarietà democratica, impegnata nella difesa dei detenuti politici, i cosiddetti “colpiti dalla reazione”. Un’associazione, questa, strettamente legata alle direttive centrali del PCI, ma animata a livello locale da spontanee forme di mobilitazione e attivismo. Dopo l’attentato a Togliatti del 1948, e le conseguenti tensioni politiche e sociali, si assistette a un crescente numero di processi nei confronti di ex-partigiani e semplici militanti (soprattutto operai e contadini). Solidarietà democratica nasce proprio allora, per organizzare l’ausilio legale, morale e materiale e l’assistenza alle famiglie, alimentando nello stesso tempo battaglie pubbliche di denuncia contro i governi centristi. Mignini ricorda come solo nella provincia di Bologna, tra il ’48 e il ’53, Solidarietà democratica assista circa diciassettemila persone in quasi ottomila processi. Per sostenere questo tipo di lavoro si intensificarono le iniziative di auto-finanziamento, come “l’angolo del carcerato”, che a partire dagli anni Cinquanta diventerà presenza fissa alle feste dell’Unità. Nel decennio successivo, con il generale cambiamento di clima politico che caratterizza gli anni Sessanta, l’esperienza associativa di Solidarietà democratica vedrà rapidamente esaurire la propria funzione di auto-tutela popolare.
L’intervento successivo, tenuto da Mirco Carrattieri, presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Reggio Emilia, ha affrontato il tema dell’associazionismo cattolico, rilevando come, in questo campo, non ci sia un’analisi storiografica esaustiva delle specificità emiliano-romagnole. In Emilia, infatti, si trovano le prime associazioni cattoliche di matrice intransigente dell’Italia unita (nate a Bologna), così come, circa un secolo più tardi, le formazioni del dissenso cattolico degli anni Settanta (i Cristiani per il socialismo, ad esempio). Nel dibattito politico-culturale, la posizione del mondo cattolico emiliano-romagnolo della seconda metà del Novecento è stata rappresentata in due modi diversi. Da un lato l’immagine della “grande contrapposizione”, nella quale i cattolici sono il nemico e l’alternativa, posizione che nasce in particolare dal contesto dell’immediato dopoguerra. L’altra rappresentazione è quella della “repubblica conciliare”, espressione resa nota nella pubblicistica della seconda metà degli anni Sessanta e usata in più sedi da vari autori e analisti; un filone ideale che ha portato alla definizione di “cattocomunismo”. Carrattieri sottolinea, però, che queste due raffigurazioni siano in realtà delle semplificazioni, per approfondire le quali sono di aiuto gli studi storiografici. Considerando, in particolare, la cosiddetta “repubblica conciliare”, ci sono momenti e figure che richiamano una problematica convergenza dei due mondi, comunista e cattolico, di cui furono artefici le personalità più “indipendenti” al loro interno. In questo senso, una delle figure simbolo è Dossetti, del quale Carrattieri ricorda la forte spinta all’associazionismo e all’inventiva istituzionale (si pensi, ad esempio, alla stesura delle norme giuridiche degli istituti secolari di laici organizzati, caratteristici del cattolicesimo emiliano). Carrattieri ricorda anche altri nomi importanti: Angelo Salizzoni, luogotenente di Moro in Emilia-Romagna, che proviene proprio dal mondo dell’associazionismo cattolico, con un ruolo importante nel dialogo fra i due mondi in contrapposizione; Corrado Corghi, che è stato il primo segretario regionale della DC e che diventa poi uno degli animatori nazionali delle riviste del dissenso cattolico; Osvaldo Piacentini, architetto, urbanista, intellettuale cattolico al centro della programmazione urbanistica delle città emiliano-romagnole; Ermanno Gorrieri, secondo segretario regionale della DC, protagonista della vita politica modenese del dopoguerra e figura centrale per l’elaborazione del primo piano di sviluppo della Regione Emilia-Romagna. Carrattieri individua, infatti, il momento chiave del dialogo cattolici-comunisti tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta: nella fase costituente del nuovo ente Regione, il mondo cattolico è fondamentale, anche nell’autorappresentazione e nella costruzione del “modello Emilia”.
Di associazionismo femminile si è invece occupata Eloisa Betti, assegnista di ricerca dell’Università di Bologna. Il primo punto che da lei analizzato riguarda la stretta relazione di questo tema con il “modello emiliano”, e quindi la specificità del contesto regionale rispetto alla storia delle donne in Italia. I due aspetti maggiormente caratteristici sono la forte presenza femminile nell’ambio del lavoro extradomestico (sia nell’agricoltura che nell’industria) e la considerevole partecipazione civica e politica delle donne, che si traduce nell’adesione a forme associative, e a partiti e sindacati, in percentuali tra le più elevate d’Italia. All’interno della riflessione sul rapporto tra associazionismo femminile e “modello emiliano” è centrale l’analisi di uno dei pilastri del “modello”, cioè il suo sistema di welfare. Nello specifico la Betti analizza il ruolo dell’UDI, che a partire dagli anni Cinquanta non si limita solo alla progettazione di asili nido (pensati come strutture per promuovere la conciliazione tra lavoro e famiglia) ma mira anche a nuovi modelli educativi. Tali iniziative sono possibili anche grazie alla forte collaborazione con altre componenti della società, come le istituzioni locali, la cooperazione, i sindacati e i partiti politici, dove le donne sono presenti e attive. Questa forza propositiva si accresce poi con gli anni Sessanta quando si instaurerà una proficua collaborazione tra l’associazionismo femminile di area cattolica e quello social-comunista su alcuni temi comuni come la discriminazione nei confronti delle donne nel lavoro, soprattutto dopo il matrimonio, e su altre questioni riguardanti i diritti e i servizi sociali. L’associazionismo femminile, rileva Betti in conclusione, non va quindi visto come separato dalla storia nazionale o regionale, perché il suo contributo si situa nell’ambito di processi di carattere più generale, che vanno nella direzione di promuovere un miglioramento complessivo della società.
Dopo alcuni approfondimenti di Daniele Dieci (ricercatore dell’Ires Cgil Emilia-Romagna) in tema di sindacato e rappresentanza dei lavoratori, a partire da una promettente ricerca in corso sul lavoro operaio a Modena negli anni Cinquanta, ha preso la parola Tito Menzani, docente a contratto di Storia economica all’Università di Bologna, che ha sviluppato il tema della cooperazione, riconducendone il forte insediamento in Emilia-Romagna alle solide tradizioni associative presenti in regione e, con specifico riferimento alla fase storica più recente, alla capacità delle singole cooperative di “fare rete”, dando vita a forti network cooperativi, sotto forma di consorzi; fino ad arrivare a vere e proprie fusioni tra cooperative, con la nascita di imprese di più grandi dimensioni: fusioni fortemente volute dal movimento cooperativo per rafforzarsi economicamente.
Ultimo tra i relatori, Matteo Troilo, vice-presidente di Clionet, ha parlato della galassia del Terzo settore. Nel farlo è partito da una definizione di base. Il Terzo settore comprende quelle forme associazionistiche che operano in una sfera che non è totalmente privata ma nemmeno assimilabile al settore pubblico. Si tratta di realtà che non svolgono solamente opera di assistenza sociale, anche se questa è l’unica attività solitamente menzionata quando si parla di Terzo settore. Ricorda, infatti, Troilo come nel dopoguerra le forme di impegno sociale in Italia abbiano coperto diversi ambiti, come il pacifismo, il meridionalismo, il lavoro di comunità, l’intervento pedagogico e l’impresa responsabile. Il forte legame tra assistenza sociale e Terzo settore nasce solamente più tardi, tra gli anni Novanta e Duemila, quando diversi economisti cominciano a considerare le associazioni non profit come possibili elementi complementari nelle politiche di welfare. Su un altro piano di analisi, Marco Revelli ha intravisto nell’associazionismo e nel volontariato (cioè nel “movimento” del Terzo settore) i mezzi per uscire non solo dalla crisi del welfare state ma anche da quella dell’impegno politico, emersa in Italia quasi contemporaneamente. Il discorso di Troilo prosegue rilevando come sia stato, in particolare, nelle regioni in cui l’associazionismo è tradizionalmente più diffuso che si è colta in maniera maggiormente efficace la possibilità di giungere all’integrazione tra settore pubblico e Terzo settore nell’erogazione di servizi alle persone. Oggi, non a caso, l’Emilia Romagna si sta confermando come una delle regioni di punta per le istituzioni non profit italiane, sia in termini assoluti che in termini di rapporto tra numero di istituzioni e popolazione.
Il seminario si è chiuso con una tavola rotonda. Il primo a prendere la parola è stato Andrea Marchi, vice-presidente dell’Istituto Parri, il quale ha sottolineato come l’unione tra i diversi istituti bolognesi che sono andati a comporre l’attuale “Istituto per la Storia e le Memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna” sia un’occasione per offrire alla città un punto di riferimento per le riflessioni storiografiche, come accaduto con la Festa di Clionet. Cesare Minghini, presidente dell’Istituto per le ricerche economiche e sociali (Ires) della Cgil Emilia-Romagna, dopo una riflessione sui cambiamenti che si stanno vivendo nel mondo del lavoro e nella società nazionale e regionale, si è interrogato su quali aspetti del “modello emiliano” possono essere ancora oggi valorizzati. La presenza tradizionalmente molto forte dell’elemento associativo, secondo Minghini, è da far risalire alle radici di estrema povertà dell’Emilia-Romagna, che ha spinto la popolazione a reagire, unendo le forze, a condizioni di vita assai dure. Rilevando la grave crisi dei soggetti che erano stati i protagonisti del “modello”, come i partiti politici e i sindacati, e il profondo cambiamento di altri, come la cooperazione, Minghini sottolinea però la necessità che le forme di associazionismo sociale e culturale, ancora diffuse, provino sempre più a interagire e ad allearsi tra loro, per cercare di alimentare e far avanzare il dibattito e la consapevolezza sul “che fare”, anche in sinergia con le forze socio-economiche. Thomas Casadei, consigliere regionale del Partito democratico, ricorda come anche in ambito istituzionale, da qualche tempo, sul tema delle tradizioni associative, del mutualismo, del Terzo settore e dell’economia solidale, siano in corso non solo dibattiti e discussioni ma anche dei veri percorsi legislativi. Citando l’esempio dei GAS, Gruppi di acquisto solidale, e il percorso legislativo che si sta attuando in proposito a livello regionale, Casadei sottolinea come quella realtà, presente da tempo ma fino a ora in un qualche modo marginale o marginalizzata, abbia cominciato a essere riconosciuta anche sul piano istituzionale. Casadei, quindi, rileva come da parte dell’istituzione regionale vi sia il tentativo di andare oltre i confini tradizionali non per superare tout court ciò che è stato fatto fino a oggi, ma per dimostrare come in realtà il “modello emiliano” sia qualcosa di molto dinamico e capace di rinnovarsi. Walter Cardi, presidente del Comitato onoranze per i caduti di Marzabotto, si è concentrato sulla valorizzazione della memoria: il lavoro continuo che molte associazioni locali hanno svolto per la diffusione di una cultura della pace ha contribuito indubbiamente a migliorare i caratteri della nostra convivenza. Anche Cardi concorda con l’importanza di confronti pubblici come quello organizzato da Clionet, perché in queste occasioni non solo si ripercorrono tappe e momenti che portano fino alla nostra contemporaneità, ma si evidenzia anche come nel corso degli anni sia cambiata la spinta “dal basso”, quel fare insieme in autonomia che ha caratterizzato la parte migliore della società emiliano-romagnola. Learco Andalò, sollecitato da Carlo De Maria sul tema della crisi della politica, ha attinto alla sua esperienza di organizzatore culturale e militante socialista per suggerire una riflessione su quelle forme associative formali e informali, spesso nate intorno a piccole istituzioni decentrate (come biblioteche, archivi e musei), che possono essere a suo parere i luoghi di un nuovo impegno civico.
Le conclusioni, affidate a Patrizia Dogliani, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna, hanno preso le mosse da un recente articolo pubblicato da “la Repubblica”, in merito a una supposta crisi del fare storia. Dogliani, non concordando con l’articolo, nota come forse sia in crisi la produzione accademica, ma certo non la storiografia in generale, e lo dimostrano iniziative come quella di Clionet, con la presenza di relatori che non solo sono giovani, ma “da esterni” e “non strutturati” stimolano la ricerca universitaria. Dogliani conferma l’esistenza di un rinnovamento in atto, che parte – come è stato rilevato nell’introduzione da De Maria – da un approccio diverso agli studi storici, meno legato alla storia di partito e più alle biografie e alle autonomie sociali e territoriali. Ricordando l’intervento di Senta sulla Prima Internazionale, Dogliani rileva poi come si torni a parlare di un’azione politica che ha un legame molto forte con il territorio. Emerge la necessità di allargare il campo di ricerca cercando, ad esempio, di leggere i cambiamenti del territorio e porre la problematica della storia ambientale. Se la storia non è in crisi, la ricerca vive però di scarse risorse, ma può riuscire ad avere ugualmente un rapporto pubblico e civile più profondo e incisivo.


