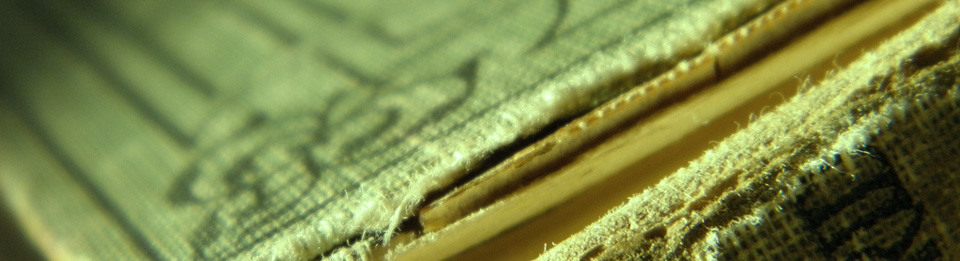
Andrea Girometti
 La raccolta di scritti di Giovanni Arrighi edita da Manifestolibri, rappresenta, ad un tempo, la sintesi di un pensiero in continua ridefinizione ed un punto d’osservazione per riflettere criticamente su alcune delle tesi più note e “controverse” dell’autore. Tra i principali esponenti, insieme a Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein e Terence Hopkins, della cosiddetta teoria del sistema-mondo, cioè, come precisa Giorgio Cesarale nella sua preziosa introduzione (Le lezioni di Giovanni Arrighi, pp. 7-28), dell’“approccio ‘sistemico’ allo studio della storia e della struttura del capitalismo globale”, Arrighi si è concentrato, sin dai suoi primi interventi, sull’esigenza di proporre una lettura delle dinamiche capitalistiche capace di individuarne le tendenze di longue durée (in termini non certo di mera continuità) correlata ad un impegno militante mai nascosto. A testimonianza che prendere parte e produrre conoscenza, se fosse necessario rammentarlo, è tutt’altro che antitetico, bensì congiunzione essenziale, propedeutica ed inscindibile di ogni processo conoscitivo consapevole. Diventa dunque dirimente fare i conti con i propri strumenti concettuali e monitorarne in itinere l’efficacia. Pertanto, non a caso, il primo scritto che compare nella raccolta – I tortuosi sentieri del capitale (pp. 29-63) – è una approfondita intervista concessa da Arrighi poco prima della sua scomparsa (avvenuta nel 2009) al geografo e studioso marxista David Harvey. In essa l’intellettuale italiano ripercorre i “tre momenti” che hanno distinto la sua riflessione teorico-politica, senza tralasciare alcuni aspetti biografici: dalla laurea alla Bocconi, la cui “Facoltà di Economia era un caposaldo di indirizzo neoclassico neppure minimamente sfiorato dalla teoria keynesiana” (p. 29), alle prime sfortunate ma formative esperienze lavorative in ambito imprenditoriale, sino all’incarico di docenza presso l’University College di Rhodesia e Nyasaland,sede distaccata dipendente dall’Università di Londra dove ebbe modo di sperimentare “una vera rinascita intellettuale” (p. 30). L’inservibilità dei modelli neoclassici per far luce sulla realtà africana si coniugò con la scoperta di nuovi paradigmi mutuati dagli antropologi sociali. È in quel frangente che si apre il “periodo africano” di Arrighi, costellato da studi come The Political Economy of Rhodesia (1966), in cui lo studioso italiano giunge ad una prima conclusione dissonante rispetto a tanta letteratura d’impronta marxista: l’irriducibilità di capitalismo e proletarizzazione. Quest’ultima ne rappresenta una possibile condizione, non l’unica. Al di fuori di un modello unidimensionale e semplificato – il riferimento polemico è agli studi di Robert Brenner –, Arrighi traccerà una genealogia “plurale” del capitalismo, o meglio dei capitalismi. D’altronde, come si era declinato negli stessi Stati Uniti lo sviluppo capitalistico se non come la risultante di “una combinazione di schiavitù, genocidio dei nativi e immigrazione di manodopera dall’Europa”? (p. 32). Complessivamente il “periodo africano” induce Arrighi a contestare alcuni assunti indiscussi del socialismo africano con l’obiettivo – come ha sottolineato opportunamente Cesarale – di porre in discussione la necessità di coniugare sviluppo e forme di dipendenza dai centri del capitale internazionale, nonché di criticare il mancato intervento, ritenuto marginale dai più, sulla distribuzione del reddito nei paesi terzi. Quest’ultima posizione sarà mantenuta dall’autore sino ai suoi ultimi scritti sull’Africa (Arrighi 2002) in cui “l’involuzione degli Stati africani […] è fatta risalire alle tendenze delle burocrazie […] di conservare ad ogni costo i privilegi garantiti loro dalla esistente [ed immutata] distribuzione del reddito” (p. 10).
La raccolta di scritti di Giovanni Arrighi edita da Manifestolibri, rappresenta, ad un tempo, la sintesi di un pensiero in continua ridefinizione ed un punto d’osservazione per riflettere criticamente su alcune delle tesi più note e “controverse” dell’autore. Tra i principali esponenti, insieme a Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein e Terence Hopkins, della cosiddetta teoria del sistema-mondo, cioè, come precisa Giorgio Cesarale nella sua preziosa introduzione (Le lezioni di Giovanni Arrighi, pp. 7-28), dell’“approccio ‘sistemico’ allo studio della storia e della struttura del capitalismo globale”, Arrighi si è concentrato, sin dai suoi primi interventi, sull’esigenza di proporre una lettura delle dinamiche capitalistiche capace di individuarne le tendenze di longue durée (in termini non certo di mera continuità) correlata ad un impegno militante mai nascosto. A testimonianza che prendere parte e produrre conoscenza, se fosse necessario rammentarlo, è tutt’altro che antitetico, bensì congiunzione essenziale, propedeutica ed inscindibile di ogni processo conoscitivo consapevole. Diventa dunque dirimente fare i conti con i propri strumenti concettuali e monitorarne in itinere l’efficacia. Pertanto, non a caso, il primo scritto che compare nella raccolta – I tortuosi sentieri del capitale (pp. 29-63) – è una approfondita intervista concessa da Arrighi poco prima della sua scomparsa (avvenuta nel 2009) al geografo e studioso marxista David Harvey. In essa l’intellettuale italiano ripercorre i “tre momenti” che hanno distinto la sua riflessione teorico-politica, senza tralasciare alcuni aspetti biografici: dalla laurea alla Bocconi, la cui “Facoltà di Economia era un caposaldo di indirizzo neoclassico neppure minimamente sfiorato dalla teoria keynesiana” (p. 29), alle prime sfortunate ma formative esperienze lavorative in ambito imprenditoriale, sino all’incarico di docenza presso l’University College di Rhodesia e Nyasaland,sede distaccata dipendente dall’Università di Londra dove ebbe modo di sperimentare “una vera rinascita intellettuale” (p. 30). L’inservibilità dei modelli neoclassici per far luce sulla realtà africana si coniugò con la scoperta di nuovi paradigmi mutuati dagli antropologi sociali. È in quel frangente che si apre il “periodo africano” di Arrighi, costellato da studi come The Political Economy of Rhodesia (1966), in cui lo studioso italiano giunge ad una prima conclusione dissonante rispetto a tanta letteratura d’impronta marxista: l’irriducibilità di capitalismo e proletarizzazione. Quest’ultima ne rappresenta una possibile condizione, non l’unica. Al di fuori di un modello unidimensionale e semplificato – il riferimento polemico è agli studi di Robert Brenner –, Arrighi traccerà una genealogia “plurale” del capitalismo, o meglio dei capitalismi. D’altronde, come si era declinato negli stessi Stati Uniti lo sviluppo capitalistico se non come la risultante di “una combinazione di schiavitù, genocidio dei nativi e immigrazione di manodopera dall’Europa”? (p. 32). Complessivamente il “periodo africano” induce Arrighi a contestare alcuni assunti indiscussi del socialismo africano con l’obiettivo – come ha sottolineato opportunamente Cesarale – di porre in discussione la necessità di coniugare sviluppo e forme di dipendenza dai centri del capitale internazionale, nonché di criticare il mancato intervento, ritenuto marginale dai più, sulla distribuzione del reddito nei paesi terzi. Quest’ultima posizione sarà mantenuta dall’autore sino ai suoi ultimi scritti sull’Africa (Arrighi 2002) in cui “l’involuzione degli Stati africani […] è fatta risalire alle tendenze delle burocrazie […] di conservare ad ogni costo i privilegi garantiti loro dalla esistente [ed immutata] distribuzione del reddito” (p. 10).
Il successivo rientro in Italia, nel 1969, vedrà Arrighi impegnato direttamente nei movimenti della sinistra extraparlamentare, prima come docente presso la Facoltà di Sociologia di Trento, epicentro della mobilitazione, poi, spostatosi su un ambito apparentemente periferico, a Cosenza, all’Università della Calabria. La diversa collocazione geografica designa il centro d’interesse ad un tempo teorico e politico: osservatore partecipante in primis dello sviluppo capitalistico nelle sue aree più “recettive” (il Nord-Italia lungo l’asse Milano-Torino), in seconda istanza dei processi di proletarizzazione degli immigrati calabresi, riecheggiando l’esperienza africana. Sono gli anni in cui insieme al Gruppo Gramsci si proponeva di pensare “una strategia di carattere gramsciano per il movimento”, in cui nasce, ben prima delle formulazioni di Toni Negri (di cui Arrighi non esita ad indicare la successiva opzione avventuristica), l’idea di “autonomia intellettuale della classe operaia”. Autonomia come “aiuto offerto da parte di studenti e intellettuali, alle avanguardie dei lavoratori perché sviluppassero la loro autonomia […] attraverso la comprensione dei processi più ampi a livello nazionale e globale all’interno dei quali si attuava la loro lotta” (p. 34). La conclusione dell’esperienza italiana, in cui, tra l’altro, Arrighi inizia a concentrare la sua riflessione sulla crisi del capitalismo che si apre nei ’70 (Arrighi 1975) – facendone il focus della sua riflessione successiva –, ed a sostituire il concetto leniniano d’imperialismo con quello di egemonia (Arrighi 1978), introduce la “fase americana” che caratterizzerà sino alla fine l’impegno dello studioso italiano. In essa l’incontro già abbozzato con la scuola sistemica fa definitivamente presa. Già nei sui precedenti scritti se ne potevano trovare i prodromi: dalla centralità euristica assegnata all’indagine del capitalismo mondiale, piuttosto che nazionale, all’articolazione gerarchica del sistema capitalistico suddiviso in zone centrali e periferiche – su cui sembra agire un’influenza non detta della scuola dipendentista sudamericana (Turchetto 2006); dalla non sovrapponibilità di capitalismo e proletariato, all’importanza ricoperta dai “gruppi di status” in cui i vettori identità, razza, nazione e genere giocano un ruolo non marginale nella composizione sociale e politica della forza-lavoro mondiale.
Tuttavia, come sostiene Cesarale, è in questa fase che Arrighi riconosce esplicitamente “la centralità dell’insegnamento di Fernand Braudel” (p. 16), da cui mutua, rielaborandole, diverse tesi (ma anche in questo caso il debito con la scuola dipendentista sudamericana andrebbe valutato con più attenzione). Pur riconoscendo in Braudel l’assenza di un quadro teorico definito (p. 38), egli individua nelle posizioni dello storico francese (in particolare Braudel 1987) il concetto essenziale di espansione finanziaria come indicatore, ad un tempo, del tramonto di un sistema egemonico e di una persistenza, in quanto carattere periodico dello sviluppo capitalistico. Di più: la complementarietà di Marx e Braudel. Per cui la fase di sviluppo finanziario, segnando l’”autunno” di un processo di leadership nell’accumulazione, corrisponde ad una nuova “primavera in qualche altro luogo” (p. 39), cioè all’avvio di uno sviluppo produttivo in altre aree del sistema-mondo, in particolare attraverso i meccanismi del credito e del debito internazionale descritti da Marx nel Capitale, seppure non elaborati in tutta la loro portata teorica, non essendo tematizzato in Marx il ruolo attivo dello Stato nei processi di accumulazione se non nei termini della cosiddetta “accumulazione originaria” (pp. 151-152). Sulla base di queste riformulazioni teoriche Arrighi giunge, da un lato, diversamente dai marxisti, ad identificare il capitalismo con un sistema di accumulazione della ricchezza (già presente dalla fine del Medioevo), piuttosto che come modo di produzione affermatosi con la “rivoluzione industriale”. O ancor meglio: nell’osservare la congiunzione necessaria tra Stato e capitale Arrighi identifica il capitalismo come “modo di accumulazione e dominio” (Arrighi 1999), delineando un sistema sottoposto al succedersi di diversi cicli egemonici – irriducibili ad un percorso progressivo già scritto – che agiscono sull’insieme gerarchicamente articolato dell’economia-mondo, determinando un’unità “mobile” tra mercato mondiale, divisione internazionale del lavoro e sistema interstatale. Soggetti e punti di sutura dell’economia-mondo, di fatto produttori di egemonia, in quanto “portatori” di interessi generali capaci di suscitare “emulazione”, sono gli Stati dominanti che assumono la guida del sistema. È sul piano inclinato del conflitto interstatale che si gioca l’esercizio dell’egemonia, categoria gramsciana ri-esportata da Arrighi in quest’ultima dimensione (p. 38), ed è in questa arena che prendono forma i quattro cicli egemonici che hanno caratterizzato lo sviluppo capitalistico, analizzati dettagliatamente nel testo più importante di Arrighi, Il lungo XX secolo (Arrighi 1996): dal ciclo genovese-iberico, a quello olandese, da quello britannico a quello (odierno) statunitense, non senza scarti, precipizi e rischi di rimanere travolti da un surplus di caos sistemico che occupa, almeno potenzialmente in forme non conoscibili, gli interstizi di ogni transizione.
Una sistematizzazione di queste tesi è riportata nel saggio scritto nel 2001 con Beverly J. Silver (Capitalismo e (dis)ordine mondiale pp. 143-179). Nello specifico gli autori osservano:
a) una forte somiglianza tra l’inizio e la fine del ventesimo secolo, rilevando la centralità esercitata dal capitale finanziario in entrambe le epoche, considerato (a torto) da alcuni osservatori un fenomeno del tutto nuovo o addirittura finale/supremo del capitalismo, se non la sopraggiunta odierna “egemonia dei mercati globali”;
b) la finanziarizzazione come carattere ricorrente del capitalismo storico a partire dal XVI secolo. Momento che succede ad una fase di espansione materiale (che ne indica un rendimento decrescente, il passaggio da una “tacita” cooperazione ad una prevalente competizione) e con quest’ultima costituisce un ciclo sistemico di accumulazione,ricalcando la formula generale del capitale tratteggiata da Marx (D-M-D’);
c) le fasi di espansione finanziaria non esprimono solo una ciclicità del capitalismo storico, ma equivalgono a “fasi” di profonda trasformazione del sistema-mondo, momenti inquadrabili come “transizioni egemoniche”.
In sintesi: l’affermazione di un’egemonia “conduce all’espansione, l’espansione al caos e il caos a una nuova egemonia” e ciò non è privo di caratteri evolutivi (reintroducendo forse una qualche tensione teleologica nel modello impiegato), dovendo dotarsi ogni nuova egemonia di “una maggiore concentrazione di capacità organizzativa, un maggior volume e densità del sistema rispetto all’egemonia precedente” (p. 162). Un’anomalia, peraltro, si riscontra nel declino americano rispetto alle precedenti transizioni egemoniche: la disgiunzione tra capacità finanziaria e militare. Quest’ultima rappresenta una forte arma di pressione per rallentare il passaggio di consegne, aumentando tuttavia il livello di contraddizioni sistemiche ed i relativi effetti destabilizzanti, anche se, osservano gli autori nel poscritto del 2006, la sconfitta militare in Iraq e lo svuotamento della politica neoconservatrice – il fallimento del progetto etichettato come “nuovo secolo americano” –, e, contemporaneamente, il consolidamento di un nuovo centro economico-produttivo in Asia guidato da una Cina rinnovata anche negli indirizzi politico-istituzionali grazie a lotte e mobilitazioni di massa, possono indurre diverso orientamento americano (in sostanza l’accettazione del proprio declino) e mettere in campo strategie inedite e transnazionali – come sono state le manifestazioni pacifiste del 2003 – di pressione dal basso. Pertanto, se il quadro di disuguaglianze globali che evidenzia il divario tra centro e periferia – la regola, almeno sino alla fine degli anni ’80, è stata un aumento della divaricazione tra gli Stati ricchi e gli Stati e le regioni a basso e medio reddito, mentre i “miracoli economici” (ad es. il Giappone) rappresentano rarissime eccezioni – non ha intaccato la logica di “ricchezza oligarchica” che informa la struttura capitalistica, rendendo evanescente un generale sviluppo economico (Le disuguaglianze mondiali, pp. 109-141), un ruolo essenziale nel minare l’ordine egemonico può essere certamente giocato dai movimenti antisistemici. La loro centralità nell’innescare la crisi dell’egemonia statunitense negli anni ’60-70 – rispetto alla quale la successiva ristrutturazione finanziaria ha attivato un meccanismo reattivo, è stata ampiamente analizzata da Arrighi (Arrighi, Hopkins, Wallerstein, 1992) –, così come l’appello all’azione collettiva per razionalizzare il “caos sistemico” è richiamato costantemente (si veda lo stesso capitolo Capitalismo e (dis)ordine mondiale pp. 143-179). Allo stesso tempo, nel corso del “lungo XX secolo”, non sono sfuggite ad Arrighi le derive (istituzionalizzazione e burocratizzazione conseguenti al tentativo di conquistare il potere statale) e le nuove modalità d’azione collettive condensate nella richiesta di miglioramenti hic et nunc delle condizioni di vita e di lavoro, nonché di sviluppo di campagne mirate su base internazionale. Le stesse analisi, a ridosso del crollo del sistema sovietico, riservate dell’evoluzione del movimento operaio mondiale in Secolo marxista, secolo americano (pp. 65-107) rappresentano un utile tentativo di fare i conti con la matrice marxiana e poi marxista del movimento, repertoriandone i successi e le aporie. In questi termini la capacità di spiegare le tendenze capitalistiche (elaborate nel celebre Manifesto del partito comunista), condensate nella polarizzazione di classe tra borghesia e proletariato, nell’impoverimento e contestuale rafforzamento del proletariato, nella delegittimazione dell’ordine borghese, sembra funzionare sino al 1896, con una vistosa eccezione sul lato della politica proletaria: l’unica insurrezione vincente – la Comune parigina – sembra prodotta da un surplus di azione politica disgiunta dalle tendenze socio-economiche strutturali sopra descritte ed indotta dall’incapacità “che lo Stato borghese aveva dimostrato [nel] proteggere la società francese in generale, e il proletariato parigino in particolare, da un altro Stato [la Prussia]” (p. 73). L’incomprensione del ruolo centrale giocato dagli Stati e dalle dinamiche interstatali è una delle maggiori lacune – anzi “un grave errore” – che Arrighi rinviene in Marx: ovvero “l’idea che il mercato mondiale operasse sopra le teste, anziché attraverso l’azione degli attori statali”, mentre al tempo di Marx esso era “uno strumento del dominio inglese sul sistema allargato dell’Europa” (p. 75). La stessa formazione dei partiti politici di matrice marxista subisce una forte divaricazione strategica non sufficientemente elaborata ed infine esiziale per l’intero movimento. Ciò che si produce è una vistosa biforcazione: dove il movimento operaio aveva accumulato potere sociale prevalse l’opzione riformista (elaborata da Bernstein) e venne meno ogni idea di costituire un (contro)potere basato su istituzioni come “soviet” e “comuni”, contrariamente, una tendenza rivoluzionaria (su cui scommise in primis Lenin) corrispose ad un immiserimento del proletariato e si correlò con la costituzione di partiti guidati dall’alto, portatori di propri interessi – in cui le avanguardie non si limitarono ad esercitare un ruolo morale e pedagogico –, e con “una vittoria di eserciti su altri eserciti” (p. 83). La mancata omogeneizzazione delle condizioni sociali del proletariato come elemento sufficiente ad un’azione comune proletaria, a partire da tendenze così contrastanti, l’inconsapevolezza marxiana della rilevanza giocata dalle differenze in seno al proletariato (età, genere, etnia, nazione, religione, ecc), la disgiunzione tra le posizioni marxiane espresse nel Manifesto (il “partito comunista” come organizzazione non distinta/opposta ad altri partiti operai; la presenza di interessi non distinti da quelli del proletariato mondiale; l’assenza di principi settari atti a plasmare il movimento proletario) e lo stesso marxismo storico in ambito politico, rendono, tuttavia, secondo Arrighi, più attuali oggi le previsione marxiane espresse nel Manifesto. La declinante egemonia statunitense, resa esplicita da una politica di riduzione dei costi e di massiccia finanziarizzazione – il cosiddetto “neoliberismo” – potrebbe indurre un’opzione antagonistica, correlata direttamente ad una condizione subalterna generalizzata, eccedente la scarsa rappresentatività delle tradizionali organizzazioni politiche e sindacali dei lavoratori, minandone la funzione sostitutiva. L’esercizio del “potere sociale che si sta accumulando nelle mani della forza lavoro diventa di per sé rivoluzionario” (p. 103), ricongiungendo “movimento” e “fine”. Ciò era già evidente nel ’68, e negli anni ’80 assume caratteri emblematici ad es. nell’esperienza di Solidarnosc, movimento non marxista contrapposto ad un’organizzazione marxista…e tuttavia ben più marxiano di quest’ultima. Sennonché – a tacitare un certo ottimismo – nel processo di livellamento verso il basso delle condizioni sociali, all’interno della classe lavoratrice emerge “spontaneamente” la tendenza ad “accentuare le differenze di status per proteggersi dal capitale” (p. 44), facendo dell’uso di tali differenze – patriarcato, nazionalismo e razzismo inclusi – “parte integrante del movimento operaio internazionale” con cui è necessario fare i conti in vista di un’eventuale “trasformazione socialista del mondo” (p 105).
L’ultimo capitolo della raccolta di testi di Arrighi (Dopo il neoliberismo. Il nuovo ruolo del Sud del mondo pp. 181-217) – il più recente, redatto insieme a Lu Zhang – è un’analisi sulle conseguenze della caduta di efficacia delle politiche neoliberiste e sulla possibilità che si costituisca una nuova Bandung, un inedito patto tra i paesi un tempo definiti ”in via di sviluppo”, capaci di convergere economicamente (e non solo in termini politico-ideologici), proponendosi come nuovo polo egemonico orientato verso “uno sviluppo socialmente più equo ed ecologicamente più sostenibile” (Arrighi 2008). Se la contro-rivoluzione liberista ha rappresentato il vero motore dell’allargamento delle disuguaglianze interne agli Stati e, cosa non affatto scontata nelle tesi mainstream, anche “dell’intensificarsi delle pressioni competitive sul lavoro e sui paesi del Sud”, non determinate principalmente “dall’integrazione nei mercati mondiali dell’offerta illimitata di lavoro di Cina e India” (p. 188), con ripercussioni nella distribuzione del reddito mondiale – misurata dalla “modesta diminuzione nell’indice di Gini tra il 1980 e il 2000” – che non ha scalfito il 10% più ricco della popolazione mondiale condensandosi “esclusivamente [nella] redistribuzione dai paesi a medio reddito verso quelli a reddito più alto e più basso” (p. 183), ciò che emerge è che senza le brillanti performance di Cina e India la povertà sarebbe rimasta costante. I successi di questi Stati, in particolare della Cina, secondo Arrighi non vanno affatto addebitati ad un allineamento subalterno alle misure propagandate dal Washington consensus, semmai ad una non abdicazione di sovranità sulle proprie politiche di sviluppo, al tentativo di tenere insieme coesione sociale e ristrutturazioni economiche, all’aver usato come fattore competitivo “i vantaggi di un’economia nazionale auto-centrata informalmente protetta da lingua, usanze, istituzioni e reti di rapporti accessibili agli stranieri soltanto attraverso intermediati locali”. In altre parole l’aver scommesso, in particolare nella seconda metà dell’ultimo decennio, come già l’autore aveva evidenziato ampiamente in Adam Smith a Pechino (Arrighi 2008), sul recupero di un concezione dello sviluppo, divergente rispetto all’Occidente, incentrato su una “rivoluzione industriosa”. Essa si caratterizza per un’alta intensità di lavoro (in cui ha giocato un ruolo non marginale un’accumulazione senza espropriazione nelle campagne) e si pone come alternativa ad uno sviluppo capitalistico – in questi termini uno sviluppo di mercato come declinato da Smith ed uno propriamente capitalistico sarebbero divergenti – componendosi efficacemente con forme di concorrenza intercapitalistica “controllate”, investimenti in tecnologie capital-saving, valorizzazione di imprese pubbliche o semi-pubbliche come le “imprese di municipalità e di villaggio”, gestione centralizzata del credito. Con ciò non si vuol dire che lo sfruttamento del lavoro non sia aumentato e l’apertura alla concorrenza tra imprese statali e private sia priva di problemi, innanzitutto politici oltre che economici. Occorre inoltre precisare che secondo Arrighi una rivitalizzazione della “rivoluziona industriosa” non sarebbe stata possibile senza gli input forniti dalla tradizione rivoluzionaria cinese, in primis dalla Rivoluzione culturale che, da un lato, pur con tutte le sue contraddizioni, ha migliorato le condizioni sociali della popolazione, su cui poi hanno potuto agire efficacemente le riforme degli anni ’80, dall’altro, ha lasciato in eredità un alto livello di conflittualità sociale, elemento di cui il Partito-Stato non può non tener conto e che delegittima alla radice una politica meramente coercitiva. Se queste tesi sono certamente tra le più “controverse” – cosa intendere per socialismo (per non parlare del rimosso comunismo) e capitalismo, in particolare nel “laboratorio cinese”? È davvero così antitetico lo sviluppo tra Occidente e Oriente? Quanto conta il grado di conflitto sociale nel ridefinire non solo gli indirizzi politici ma gli assetti istituzionali, le forme di partecipazione ai vari livelli del decision making pubblico? –, tuttavia le possibilità di un’altra configurazione mondiale, che Arrighi individua nella potenziale affermazione a livello globale di un’economia di mercato non-capitalistica, frutto di un riequilibrio dei rapporti d’influenza interstatali, sembrano spostarsi verso Sud, in aree extraoccidentali. È tutt’altro che scontato l’esito, d’altronde l’avvenire dura a lungo…
Biografia
Biography
Bibliografia
Arrighi G.
1967 The Political Economy of Rhodesia, The Hague, Mouton.
1975 Una nueva crisis general capitalista, in “Zona Abierta” (Madrid), 5, 1975 (trad it. Verso una teoria della crisi capitalistica, in Dinamiche della crisi mondiale, a cura di R. Parboni, Roma, Editori Riuniti, 1988).
1978 La geometria dell’imperialismo: i limiti del paradigma hobsoniano, Milano, Feltrinelli.
1996 Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo, Milano, Il Saggiatore.
1999 I cicli sistemici di accumulazione, Catanzaro, Rubbettino.
2002 The African Crisis. World Systemic an Regional Aspect, in“New Left Review”, II/15.
2008 Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, Milano, Feltrinelli.
Arrighi, G., Hopkins T.K., Wallerstein, I.
1992 Antisystemic Movements, Roma, Manifestolibri.
Braudel F.
1987 Civiltà materiale, economia e capitalismo, 3 voll. , Torino, Einaudi.
Turchetto M.
2008 Imperialismo e globalizzazione: prospettive del marxismo contemporaneo in Aruzza.
Aruzza C. (cur.)
2008 Pensare Marx, ripensare Marx, Roma, Edizioni Alegre.


