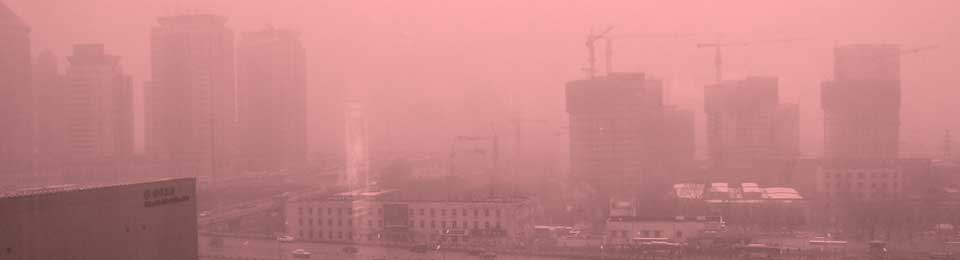
di Andrea Francioni
Abstract
Abstract english
In recent years China’s rapidly proliferating global interests have changed the western perception of this country, fuelling the debate about Beijing’s goals on an international level. This article explores how the “China threat” theory has come to acquire vast popularity in the West, and particularly in the United States, since the 1990s, and which responses the People’s Republic has been able to conceive to counter the risk of a renewed containment. “Peaceful development” is one of the first, and most useful, foreign policy concepts to be introduced under the Hu Jintao leadership: it has come out of the political debate about foreign perception of the country’s ambitions, a debate still taking place both inside the formal, central government bureaucracy, and outside, among think-tank analysts and university-based scholars. This concept, popularized since 2004, is part of Beijing’s strategy of reassuring the West, as well as its neighbours, who are deeply concerned about China’s rise to great-power status.
Un des jours les plus graves de la crise où, pendant le ministère Rouvier, on crut qu’il allait y avoir la guerre entre la France et l’Allemagne, comme je dînais seul chez M.me de Guermantes avec M. de Bréauté, j’avais trouvé à la duchesse l’air soucieux. J’avais cru, comme elle se mêlait volontiers de politique, qu’elle voulait montrer par là sa crainte de la guerre, comme un jour où elle était venue à table si soucieuse, répondant à peine par monosyllabes; à quelqu’un qui l’interrogeait timidement sur l’objet de son souci elle avait répondu d’un air grave: “La Chine m’inquiète”.
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Le côté de Guermantes (1920).
Introduzione
Per chi studia la politica internazionale è difficile sfuggire alle suggestioni esercitate dalla nascita, o rinascita, della Cina come grande potenza, sia che si affronti il tema in chiave predittiva degli scenari futuri, sia che si vogliano individuare le radici storiche di una simile evoluzione (Scott 2007; Ross, Zhu 2008; Bergsten et al. 2008). L’ascesa di Pechino è ormai un filone d’analisi ben consolidato nell’ambito della letteratura specialistica e della pubblicistica di settore, e non sorprende che il più attivo terreno di dibattito politico e accademico siano stati in questi anni gli Stati Uniti, dove con maggiore urgenza si è avvertita la necessità di ridefinire il quadro strategico terremotato dal crollo dell’Unione Sovietica.
È opportuno chiarire fin da subito che l’obiettivo del presente contributo non è passare in rassegna le molteplici questioni di politica internazionale sollevate nel corso dell’ultimo ventennio dal rapido proliferare degli interessi globali della Repubblica popolare cinese: non mi soffermerò nello specifico sui rapporti fra Pechino e Washington – anche se, per riflesso, vi accennerò – o su quelli fra Pechino e Bruxelles; non esaminerò le iniziative che la Cina ha assunto, specialmente con il nuovo secolo, in Africa, America Latina e Medio Oriente; non mi dilungherò sui singoli contesti regionali dove Pechino è ormai l’attore di primo piano: quello centro-asiatico, per un verso, in cui dispiega i suoi effetti la relazione con Mosca; quelli dell’Asia orientale e sud-orientale, per un altro, nei quali le controparti di maggior peso sono Giappone, India e i paesi dell’Asean (Zhao 2004; Johnston, Ross 2006; Guo, Hua 2009; Sutter 2010).
Intendo invece affrontare il tema della proiezione esterna di questa rinata potenza prendendo in esame il dibattito sull’ascesa di Pechino durante gli anni, a partire dal 1992, in cui il fenomeno storicamente ha preso corpo (Zhu 2010), in senso proprio – in termini, dunque, di evoluzione delle relazioni bi o multilaterali della Rpc e di cambiamento dello scenario geopolitico complessivo, specialmente nel fondamentale quadrante strategico dell’Asia-Pacifico – e, per quello che interessa qui mettere a fuoco, a livello di percezione da parte degli osservatori, degli analisti e dell’opinione pubblica internazionale. Un simile approccio implica attenzione non solo per il dibattito politico e accademico fiorito in primo luogo negli Stati Uniti intorno alla “questione cinese”, ma anche per il discorso di politica estera articolato in Cina sotto la leadership di Jiang Zemin e Hu Jintao, un discorso che affonda le radici negli anni ’80, in sostanziale continuità con la direttiva “pace e sviluppo” (heping yu fazhan) di Deng Xiaoping, e a sua volta si precisa nell’arco di un decennio (1996-2005) sulla scorta della dialettica sull’ascesa del Paese che si innesca fra Pechino e Washington (Yi 2005).
Il ritorno della “minaccia cinese”
C’è un aggettivo che ricorre nelle dichiarazioni pubbliche, nei comunicati ufficiali e, a monte, nell’elaborazione di politica estera dell’attuale dirigenza cinese: “pacifico”, declinato a seconda delle circostanze. “Crescita pacifica”, “sviluppo pacifico”, in parte “ascesa pacifica”, sono espressioni di uso frequente nelle comunicazioni di Pechino alla comunità internazionale (De Giorgi 2007, 394). C’è un altro aggettivo che il governo cinese ripete costantemente, questa volta in particolare quando si rivolge all’interno, un aggettivo che richiama atmosfere confuciane: “armonioso”. “Sviluppo armonioso”, “società armoniosa”, ma anche “mondo armonioso” o “legami armoniosi”, quando si guarda oltre i confini nazionali (Chin 2008, 13-26; Congiu 2008). “Sviluppo pacifico” e “Società armoniosa”, usati singolarmente o in coppia, sono il vero e proprio mantra della dirigenza in carica e potrebbero diventare il lascito, a livello politico-dottrinale, della quarta generazione di leader – quella rappresentata dal presidente della Repubblica e segretario del Pcc Hu Jintao, dal presidente dell’Assemblea nazionale popolare Wu Bangguo e dal premier Wen Jiabao. Non è escluso che, come è accaduto con il “Pensiero di Mao Zedong”, la “Teoria di Deng Xiaoping”, il “Pensiero delle tre rappresentatività” di Jiang Zemin, anche “Sviluppo pacifico” e “Società armoniosa” vengano prima o poi inseriti fra i principi base in quella specie di pantheon post-rivoluzionario che è ormai lo Statuto del Partito comunista cinese, accanto al concetto di “Sviluppo scientifico”, di cui già Hu Jintao può rivendicare la paternità (Miranda 2007).
La teoria dello “Sviluppo pacifico” (heping fazhan), che dalla fine del 2004 rappresenta la linea guida della politica estera cinese (Yang 2009, 21; Samarani 2010, 19), trae origine dal dibattito politico-accademico fiorito nel Paese intorno al concetto di “ascesa pacifica” (heping jueqi), a sua volta elaborato in risposta alla retorica della “minaccia cinese” (China threat) o, alternativamente, del “collasso cinese” (China collapse), veicolata in Occidente da alcuni influenti opinion maker e think tank conservatori, soprattutto americani (Chung 2003; Wang 2009; Onnis 2011, 75-80). E allora occorre iniziare da qui, cioè da come all’esordio del mondo post-bipolare negli Stati Uniti gli osservatori e gli esperti di relazioni internazionali comincino a percepire e valutare la rapida crescita delle capacità economiche, della forza militare, dell’influenza culturale e del potere politico di Pechino. Già all’epoca, ormai quasi vent’anni fa, pochi argomenti sono capaci di evocare visioni tanto contrastanti, di dar vita a dibattiti così accesi quanto la questione dell’ascesa cinese. A fronte di una maggioranza di studiosi impegnati in ricerche molto articolate e ricche di sfumature, certo attente alle implicazioni del fenomeno a livello di sostenibilità della crescita, di competizione per l’accesso alle risorse, di possibili nuovi equilibri strategici globali, ma propense a considerarlo come uno sviluppo non necessariamente eversivo dell’ordine internazionale occidentale e a valutarlo in termini di opportunità (Robinson, Shambaugh 1994; Shambaugh 1996; Segal 1996), a fronte di questa maggioranza di studiosi, dicevo, vi è anche chi si produce in analisi assai meno sofisticate, e tuttavia non per questo meno persuasive per l’opinione pubblica (Roy 1996), in parte perché attingono dalla storia immagini di sicuro impatto mediatico – come quella del “pericolo giallo” (Greenfield 1992) –, in parte perché scavano nella memoria recente del pubblico americano facendo riaffiorare paure nutrite fino a poco prima nei confronti dell’altro gigante asiatico, il Giappone, le cui presunte mire di egemonia economica mondiale sono state denunciate per buona parte degli anni ’80 (van Wolferen 1989).
In effetti, tralasciando i precedenti storici della “minaccia cinese” – che vanno dalla sindrome della “perdita della Cina” all’esordio della Guerra Fredda in Asia, alla politica muscolare del primo Reagan sulla questione di Taiwan, attraversando sottotraccia anche tutta la fase altrimenti contrassegnata dal processo di apertura e di normalizzazione dei rapporti fra Rpc e Occidente durante gli anni ’70 (Harding 1992; Ross 1995) – occorre dire che a partire dai primi anni ’90 esiste negli Stati Uniti una coerente e durevole letteratura su questo tema, che di fatto mira a relegare Pechino nel ruolo di competitore, di rivale di Washington (Pan 2004): semplificando molto la questione, si potrebbe dire che il tema della minaccia, della nuova minaccia che si prefigura dopo l’esaurimento dello scontro con l’Unione Sovietica, è atta a fornire una linea strategica di fondo alla politica estera americana in un ambiente internazionale reso più fluido, e per molti aspetti meno controllabile, dalla fine della Guerra Fredda (Teles 1998, 44-45; Yee, Storey 2002, 11). È appunto una semplificazione ridurre il problema all’ideologia dei nostalgici del bipolarismo, ma non vi è dubbio che questa rappresenta, se non la corrente di pensiero dominante, di certo quella più aggressiva e che fa maggior presa sull’opinione pubblica (Al-Rodhan 2007).
In Cina sono state avanzate diverse ipotesi circa la genesi della China threat theory (Zhongguo weixielun): fra gli altri, il generale Xu Xin, già presidente del China Institute for International Strategic Studies (Ciiss) di Pechino, un centro studi subordinato al Dipartimento dell’intelligence dello Stato maggiore dell’Esercito popolare di liberazione (Epl) (Gill, Mulvenon 2002), suggerisce che il battesimo della teoria sia avvenuto in occasione di un simposio organizzato il 25 agosto 1992 dalla conservatrice Heritage Foundation di Washington, durante il quale esponenti del governo statunitense indicano nella Rpc la principale responsabile della ripresa della corsa agli armamenti nella regione dell’Asia-Pacifico. Sempre secondo Xu, la nozione della minaccia viene rilanciata già il mese successivo dall’ex ambasciatore americano a Pechino (ed ex agente della Cia), James Lilley, che in un discorso tenuto a Hong Kong critica apertamente l’espansione del bilancio militare cinese (Deng 2006, 191-192). La versione ufficiale, accreditata anche al di fuori degli ambienti legati all’Esercito e comunemente accettata dagli analisti, spiega con una combinazione di fattori la nascita della teoria: il viaggio di Deng Xiaoping nelle province meridionali del Paese nel 1992 rilancia le riforme di mercato, avviando un nuovo ciclo di crescita dopo la battuta d’arresto di fine anni ’80, e rinfocola i timori suscitati in Occidente dall’ascesa cinese, timori in quel momento sopiti sotto il peso delle prognosi infauste sulla tenuta del regime diffusesi in coincidenza con il crollo del blocco sovietico e la crisi di piazza Tiananmen; contestualmente, nel febbraio 1992, l’Assemblea nazionale popolare vara una legge che, estendendo la piattaforma continentale e il limite marittimo della zona economica speciale di pertinenza cinese, riafferma la sovranità di Pechino sugli arcipelaghi contestati del Mar Cinese Meridionale (Isole Spratley/Nasha e Paracel/Xisha) e del Mar Cinese Orientale (Isole Senkaku/Diaoyu), oltre a ribadire il suo diritto ad esercitare il controllo sulle vie marittime che passano per lo Stretto di Taiwan (Deng 2008, 104-105; Ferretti 2006, 55). Stando a questa lettura, gli ingredienti fondamentali della teoria sono già ben delineati: l’enfasi posta sulle spese militari, sulla vendita di armi a partner non affidabili, sulle rivendicazioni territoriali, tratteggia l’immagine di una potenza espansionista, le cui tendenze aggressive sono destinate ad essere incoraggiate dalla fenomenale crescita economica.
Quale che sia la genesi esatta della teoria (Yee, Storey 2002), di certo a partire dal 1992 essa comincia a diffondersi negli Stati Uniti. Vi sono pochi dubbi che la “questione cinese” costituisca uno dei temi caldi di politica estera nell’anno delle elezioni presidenziali. Per esempio, l’opposizione al governo della Rpc è uno dei piatti forti della battaglia per la nomination repubblicana condotta da Patrick Buchanan, e si rivela ancora capace di mobilitare parte consistente dell’elettorato di destra; lo stesso candidato democratico, Bill Clinton, sempre pronto a sfruttare argomenti percepiti come vincenti, fa della critica serrata ai “macellai di Pechino” uno dei leitmotiv della sua campagna e lo strumento di polemica più efficace contro il proprio avversario, il “filo-cinese” George H.W. Bush, fautore della rapida ripresa della strategia dell’attenzione verso la Rpc dopo Tiananmen: peraltro il modo disinvolto con cui il futuro presidente affronta la questione gli renderà inizialmente assai difficile smarcarsi dalle posizioni elettorali una volta giunto alla Casa Bianca (Teles 1998, 47-48).
L’esasperazione dei toni critici verso Pechino, che interessa, pur con accentazioni diverse, entrambi gli schieramenti, non sorprende dato il contesto della campagna presidenziale, tuttavia importa sottolineare che, a prescindere dal passaggio elettorale, a questa data il concetto di China threat è ormai entrato a pieno titolo nel dibattito di politica estera per iniziativa di alcuni analisti conservatori (Marble 2000; Broomfield 2003), come attesta un articolo di Ross H. Munro, direttore del programma di studi asiatici del Center for Security Studies di Washington, pubblicato proprio nel 1992 sulla Policy Review. Non è necessario insistere sul punto perché il titolo sintetizza perfettamente il concetto di fondo: “Awakening Dragon: the Real Danger in Asia is from China” (Munro 1992). Un anno dopo il tema viene ripreso, questa volta su una rivista di maggiore impatto e di cui sono noti i legami con l’establishment politico ed economico americano, Foreign Affairs, organo del Council on Foreign Relations. L’esperto di cose cinesi e columnist del New York Times, Nicholas D. Kristof, vi pubblica un articolo nel quale molto sobriamente si fa il parallelo storico fra l’ascesa cinese e quella di Germania e Giappone durante gli anni ’30; si evoca la “China’s next war” nel Mar Cinese Meridionale, grazie alla quale Pechino potrebbe essere in grado di estendere le proprie acque territoriali fino a comprendervi le Isole Spratly e Paracel, con il che – scrive Kristof – si metterebbero a repentaglio le rotte commerciali, incluse quelle petrolifere, che fanno capo al Giappone (Kristof 1993, 67); si punta il dito soprattutto contro il riarmo della Rpc, basta leggere l’incipit dell’articolo:
China is the fastest growing economy in the world, with what may be the fastest growing military budget. It has nuclear weapons, border disputes with most of its neighbors, and a rapidly improving army that may – within a decade or so – be able to resolve old quarrels in its own favor (59).
Insomma il messaggio è che la Rpc è un attore potenzialmente eversivo dell’ordine internazionale, rispetto al quale occorrere prevedere una rinnovata strategia di containment.
Siamo all’esordio delle presidenze Clinton e l’atteggiamento assertivo che l’amministrazione democratica tiene nei confronti di Pechino per buona parte del primo mandato sul tema dei diritti umani (pesa ancora Tienanmen e si approfondisce il contrasto sui dissidenti politici), del riarmo cinese, di Taiwan (gli anni 1995-96 sono quelli della terza crisi nello stretto), sulla stessa questione del commercio bilaterale (basta ricordare le tensioni che periodicamente si riaccendono sulla concessione del trattamento della “nazione più favorita”), riflette in qualche misura il tono del dibattito sul containment della Rpc (Sutter 2010, 135-139). Occorrerà un po’ di tempo perché si affermi chiaramente anche a livello di discorso pubblico la teoria strategica opposta, quella dell’engagement di Pechino (Khalilzad et al. 1999, 63-75), propugnata con convinzione dagli ambienti liberal già in questa fase – per esempio dal sinologo della Johns Hopkins University di Baltimora, David M. Lampton, che poco prima di Kristof pubblica, sempre su Foreign Affairs, una sorta di manifesto della engagement school (Conable, Lampton 1993) – ma praticata in maniera discontinua fino al 1996 da un’amministrazione democratica tenuta sotto pressione dai media e dal Congresso (Sutter 1998), e di fatto annunciata ufficialmente solo nel 1997-98 quando, in occasione dei due vertici fra Bill Clinton e Jiang Zemin, il presidente americano afferma la volontà di stabilire con Pechino una “partnership strategica costruttiva”, specialmente sui problemi del commercio, della proliferazione nucleare, dell’ambiente, dello sviluppo, delle istituzioni multilaterali (Garrison 2005, 148-151). Alle spalle di questa scelta c’è sicuramente – oltre alla crescente consapevolezza della necessità di venire a patti con l’ascesa di Pechino – anche una riflessione sul comportamento cinese in occasione della crisi finanziaria nel Sud-Est asiatico del 1997, quando il governo della Rpc decide di non svalutare il renminbi per non aggravare il quasi-collasso delle economie della regione e di intervenire con prestiti di emergenza per stabilizzare le valute dei paesi maggiormente colpiti dalla recessione (Andornino 2008, 213-214; Onnis 2011, 83-85): si tratta di una prima manifestazione di quello che Robert Sutter ha definito il peaceful approach della Cina all’Asia (Sutter 2005, 265) e serve ad aprire la strada all’idea che la Rpc possa essere considerata una “potenza responsabile” e, in quanto tale, possa essere cooptata nel sistema internazionale come fattore di stabilità, perlomeno nel contesto regionale.
Tuttavia, come si diceva, il periodo di assestamento della politica di engagement si protrae praticamente per tutta la durata della prima presidenza Clinton, anni particolarmente fecondi per quella corrente di pensiero conosciuta come China threat school (Yang 2009, 19). Eppure il contributo più pesante alla teoria del contenimento viene offerto da un autore che non può essere ascritto sic et simpliciter a quella scuola, se non altro perché contempla orizzonti più ampi, occupandosi in particolare di definire secondo quali schemi si va riconfigurando il quadro geopolitico mondiale dopo il crollo del comunismo. Mi riferisco a Samuel Huntington, le cui tesi sullo “scontro delle civiltà” vengono alla luce nel 1993 ancora una volta su Foreign Affairs (Huntington 1993) e sfociano, sull’onda di un dibattito che fa del professore di Harvard un’autentica vedette internazionale, in un famoso libro pubblicato negli Stati Uniti tre anni dopo (Huntington 1996, 2000). Huntington dedica diverse pagine del suo volume maggiore all’ascesa della Cina, disegnando uno scenario in cui, complice il declino dell’Occidente, il baricentro del potere mondiale si sta spostando in maniera marcata verso l’Asia orientale, ed è perfino scontato dire che in prima fila in questo minaccioso movimento di “affermazione asiatica” egli colloca Pechino:
l’aumento di potere più significativo viene oggi registrato, e continuerà ad esserlo in futuro, dalle civiltà asiatiche, con la Cina che sta gradualmente assumendo il ruolo di maggior antagonista dell’Occidente in fatto di influenza su scala mondiale. Tali spostamenti di potere tra civiltà portano e porteranno anche in futuro le società non occidentali a un maggiore desiderio di affermazione culturale e a rifiutare sempre più decisamente la cultura occidentale (Huntington 2000, 111).
Il presagio assume tinte ancora più fosche quando Huntington asserisce che a questa transizione di potere si accompagna la ripresa in Cina di un nazionalismo culturale figlio della tradizione imperiale, che di fatto ha ormai sostituito ai fini della legittimazione del regime la dismessa ideologia maoista (148). Difficile a questo punto non attribuire alla Cina nazione neo-imperiale intenti egemonici su tutta l’area geografica storicamente influenzata dalla “civiltà sinica” – dalla penisola indocinese alla Corea, passando per la Malaysia, l’Indonesia e le Filippine – e ancor più difficile sfuggire alla tentazione dei paralleli storici evocando la nascita di una fantomatica “sfera di co-prosperità” della Grande Cina, basata sui legami culturali e la spettacolare crescita della presenza economica di Pechino nella regione (243-253). Insomma, una Cina Stato-guida e polo d’attrazione di un’intera civiltà che, magari facendo leva su un inedito asse con Pakistan e Iran – l’asse islamico-confuciano, secondo la definizione di Huntington (353-355) –, potrebbe essere tentata dall’idea di sovvertire l’ordine internazionale centrato su Washington. È questa la reale minaccia dalla quale la civiltà occidentale si deve guardare perché “se il dinamismo dell’Islam è […] il reiterato elemento scatenante di molte guerre di faglia relativamente circoscritte, l’ascesa della Cina costituisce la potenziale miccia di un grande conflitto tra stati guida di civiltà diverse” (305-306), di una guerra planetaria per definire un nuovo “ordine di civiltà”, che Huntington, facendosi prendere la mano dalla fantapolitica, si diverte a collocare già nel 2010 (466-472).
Le posizioni di Huntington sul risorgente nazionalismo cinese e sui pericoli di un ipotetico asse islamico-confuciano sono destinate a fare scuola nel dibattito politico americano. Lo stesso si può dire delle preoccupazioni neomalthusiane di Lester Brown circa la sostenibilità della crescita cinese (Brown 1995), che vengono alla ribalta quasi in contemporanea con gli scritti di Huntington e danno origine – indipendentemente dalle reali intenzioni dell’autore – a una variante significativa della teoria della “minaccia cinese”. Per Lester Brown, direttore del Worldwatch Institute, la sfida ambientale più pressante del XXI secolo non sarà rappresentata dal global warming, dall’assottigliamento della fascia di ozono o dallo sperpero delle risorse naturali, ma dal rischio che il pianeta, nell’arco di qualche decennio, non sia più in grado di nutrire i suoi abitanti. Egli prevede una crescita senza precedenti dei prezzi delle derrate a seguito del progressivo aumento dei consumi, che si impenneranno – afferma Brown – quando la popolazione cinese nel suo complesso, probabilmente già intorno al 2030, avrà assunto stili di vita paragonabili a quelli occidentali: l’aumento dei prezzi del cibo provocherà malcontento sociale, crisi alimentari e, nella peggiore delle ipotesi, enormi movimenti migratori interni e internazionali, con conseguenze destabilizzanti per il sistema politico cinese e per gli equilibri geopolitici globali. L’analisi svolta da Brown non ha accenti di per sé anti-cinesi, semmai l’autore intende richiamare l’attenzione sulle probabili conseguenze, in termini di sostenibilità, del ritmo di crescita fatto registrare da Pechino:
It will be tempting to blame China for the likely rise in food prices, because its demand for food is exceeding the carrying capacity of its land and water resources, putting excessive demand on exportable supplies from countries that are living within their carrying capacities. But China is only one of scores of countries in this situation. It just happens to be the largest and, by an accident of history, the one that tips the world balance from surplus to scarcity (24).
Certo è che le previsioni di Brown – echeggiate già in questa fase (Goldstone 1995; Huang 1995) – col tempo forniranno alimento alla teoria del cosiddetto “collasso cinese” (Zhongguo bengkuilun), molto in voga all’inizio del nuovo secolo come parte della corrente di pensiero che denuncia l’insaziabile fame di risorse naturali della Rpc: in questo senso, come si diceva, la China collapse theory può essere considerata una variante della China threat theory (Yang 2009, 19). Torneremo sul punto al momento opportuno, ma occorre sottolineare fin da ora questo passaggio perché la saldatura fra i due versanti del generico atteggiamento anti-cinese avviene proprio grazie all’emergere della questione della sostenibilità. Infatti, se nei primi anni ’90 la tesi del collasso aveva conosciuto un effimero momento di popolarità grazie al paragone – semplicistico e destinato ad essere rapidamente smentito dai fatti – fra la disintegrazione politica e territoriale dell’Urss e le presunte, analoghe prospettive di crisi politica innescate nella Rpc dalla Primavera di Pechino (Chang 1992; Chung 2006, 107-108), alla metà del decennio l’analisi di Brown dà rinnovata credibilità alle ipotesi di deriva “sovietica” del regime cinese, la cui implosione sotto il peso della pressione demografica metterebbe a repentaglio l’ordine internazionale.
Gioco di specchi
Vediamo quali sono le reazioni di Pechino, insomma come si sviluppa il discorso di politica estera in Cina in risposta a queste immagini fosche del Paese. In effetti, sono soprattutto la vasta popolarità degli scritti di Huntington e le tesi millenaristiche di Brown a innescare il confronto nel mondo politico e accademico cinese, nell’ambito del quale fino alla metà degli anni ’90 il dibattito sulla percezione all’estero delle ambizioni della Rpc rimane abbastanza asfittico (Goldstein 2005, 118-130; Scott 2007, 83-98). In prima battuta, le risposte che giungono da Pechino non fanno parte di una strategia organica, non si intravede dietro le prese di posizione una solida concezione del ruolo della Cina nella società internazionale post-bipolare e ci si limita a controbattere con argomenti polemici, talora assai aspri, all’idea che la Rpc costituisca la sfida più pericolosa per l’Occidente. Anzi, inizialmente la tentazione è quella di ribaltare la teoria della China threat, immaginando l’esistenza di un’agenda politica non dichiarata che a sua volta minaccia di interferire con le legittime aspirazioni di crescita di un Paese emergente, al quale si attribuiscono inesistenti velleità egemoniche al solo scopo di giustificare politiche aggressive. Un commentatore autorevole come Wang Jisi, direttore dell’Istituto di studi americani presso l’Accademia cinese di scienze sociali (Cass), scrive sulla Beijing Review, settimanale governativo rivolto al pubblico straniero:
Huntington hopes his theory will line up the different fractions of American society, and even the whole West, to fight an imaginary enemy […] in a sense Huntington’s thesis is more a political essay than an academic report, given that he has written it to advise the US government (Wang, Zou 1996, 11).
D’altra parte sono questi i mesi della crisi nello Stretto di Taiwan, che provoca nel Paese fenomeni di mobilitazione popolare di segno nazionalistico da cui le componenti di sinistra del regime traggono spunto per ribadire una lettura del contesto internazionale improntata alle logiche della Guerra Fredda (Fewsmith, Rosen 2001, 159-161 e 175-177). Il pensiero dominante all’interno dei circoli conservatori è che “since Tiananmen, the Gulf War and the transformation of the Soviet Union and Eastern Europe, foreign powers have come to believe that they can completely destroy the socialist states, including the Prc, and control the world because they no longer need China to balance Soviet power” (Hughes 2006, 96): in questo quadro, la teoria di Huntington è inevitabilmente destinata a rafforzare l’idea della “minaccia straniera”, veicolata sull’onda del revival nazionalistico di metà anni ’90 (93-98).
Veementi sono anche le reazioni alla tesi di Lester Brown, che possono essere riassunte con le parole di Hu Angang, ricercatore dell’Accademia cinese delle scienze (Cas), il quale, nel rigettare l’analisi del direttore del Worldwatch Institute come non scientifica, la mette ironicamente a confronto con la celebre ammonizione del segretario di Stato americano Dean Acheson contenuta nel Libro Bianco sulla Cina del 1949 – “The first problem which every Chinese Government has had to face is that of feeding (its) population. So far none has succeeded” (Acheson 1967, iv) – ammonizione e profezia di sventura indirizzata all’allora trionfante Pcc e clamorosamente smentita dalla storia, almeno secondo Hu (Brown 1995, 16).
In queste reazioni si coglie la difficoltà ad articolare un discorso convincente e il recupero di alcuni degli argomenti classici della propaganda anti-imperialista e terzomondista dell’epoca di Mao (Chen 2001) consente di controbattere in una logica di pura polemica politica; non è nemmeno da escludere che, come ha notato David Scott, alcuni ambienti conservatori a Pechino si sentano in realtà lusingati dal fatto che il proprio Paese sia accreditato come un rivale plausibile dell’Occidente (Scott 2007, 90). Ma la vena di nazionalismo che affiora nei primi commenti (Hughes 1997; Zheng 1999, 77-78) rende subito evidente il rischio di aprire la strada a un perverso gioco di specchi, rafforzando la convinzione di chi, dall’altra parte dell’oceano, propende per una precoce e decisa strategia di containment, che si teme possa interferire col percorso di sviluppo cinese e mettere in pericolo la stabilità del regime. In definitiva è questa preoccupazione che induce la leadership, per un verso, ad intraprendere tutta una serie di iniziative volte a rassicurare la comunità internazionale (basti pensare ai già ricordati provvedimenti assunti in occasione della crisi finanziaria asiatica) (Goldstein 2005, 130-135; Moore, Yang 2001, 220-222), per l’altro, ad avviare il processo di elaborazione di una credibile teoria di politica estera, capace di trasmettere un’immagine positiva del Paese in quanto potenza pacifica e fattore di stabilità (Scott 2007, 90).
Per spiegare questo passaggio può essere utile una breve digressione. Rosemary Foot ha documentato l’attenzione che storicamente la Rpc ha dedicato a coltivare la propria immagine internazionale (Foot 2001), ma occorre sottolineare che negli anni ’90 l’attività di image-building, intesa come parte integrante del lavoro di politica estera, ha fatto registrare un sempre crescente livello di sofisticazione (Wang 2005). Il punto è stato affermato con chiarezza da Guido Samarani:
a partire dagli anni Novanta, ha preso corpo a Pechino una maggiore consapevolezza della crescente importanza dell’immagine che il paese era in grado di proiettare all’esterno e del fatto che le scelte e gli atteggiamenti assunti sulle maggiori questioni mondiali venivano sempre più sottoposti ad un attento monitoraggio da parte di organismi internazionali e di singoli stati. […] la Cina ha preso coscienza del fatto che era indispensabile ricostruire la propria immagine internazionale dopo Tian’anmen; inoltre, si è fatta sempre più strada a Pechino la piena consapevolezza del fatto che non pochi paesi asiatici cominciavano ad interrogarsi sulle prospettive future della prepotente crescita economica cinese e sull’impatto che essa stava avendo sulla stabilità in Asia Orientale (Samarani 2010, 15-16).
Per coordinare gli sforzi in questo settore di attività nel 1990 il Pcc istituisce un Dipartimento della propaganda all’estero, posto alle dirette dipendenze del Comitato centrale, poi ribattezzato a beneficio del pubblico straniero Department of Publicity (De Giorgi 2010, 41); e il Consiglio di Stato – il governo – dà vita nel 1991 a un Information Office da cui transitano tutte le sue comunicazioni ufficiali e che pubblica con cadenza regolare i cosiddetti White Papers, concepiti come strumenti per spiegare alla comunità internazionale la posizione cinese su questioni particolarmente sensibili: dai diritti umani al problema di Taiwan, dalla politica di difesa alla non proliferazione, dai temi dell’ambiente e del commercio internazionale ai diritti delle minoranze etniche del Tibet e dello Xinjiang, dalla lotta alle droghe alle disparità di genere, dalla sicurezza sociale ai diritti di proprietà intellettuale, dai problemi demografici alla promozione dello Stato di diritto (Information Office 1991).
Il vero e proprio salto di qualità nell’attività di pubbliche relazioni all’estero viene compiuto tuttavia nella seconda metà del decennio, quando i tentativi di ribattere all’idea della Cina come Paese destabilizzante e aggressivo cominciano a permeare la retorica ufficiale. A questo punto le élite politiche avvertono non solo il rischio di una delegittimazione di Pechino come attore internazionale ma, come si accennava, temono soprattutto di dover pagare i costi in termini di sicurezza dell’attribuzione alla Rpc di una connotazione negativa – a causa del formarsi all’estero di un’opinione pubblica generalmente favorevole ad esercitare pressioni o a ingerirsi negli affari interni cinesi – e di dover subire il deterioramento dei rapporti con i paesi dell’area, che avrebbe ricadute imprevedibili sulle prospettive interne di sviluppo (Deng 2006, 204). Nell’ottobre 1996 viene pubblicato un documento significativo di questa nuova linea d’azione: è il “Libro Bianco” The Grain Issue in China, una ampia e radicale confutazione delle tesi di Lester Brown – come si evince dal titolo del primo paragrafo: New China has solved the problem of feeding its people – nella quale la dettagliata esposizione delle politiche di settore e dei risultati attesi prende il posto degli argomenti polemici della prima ora. Si tratta solo di una mossa preliminare che però segnala come il processo di elaborazione di un diverso approccio alla realtà internazionale si sia messo in moto, un processo che coinvolge in un ampio dibattito non solo il partito e gli organi di governo, ma anche think tank (zhiku) più o meno allineati alle posizioni di vertice e buona parte della classe accademica (Glaser, Medeiros 2007), con lo scopo di individuare la “formula ideologica” (Hughes 2006, 142) che permetta di conciliare le ambizioni da grande potenza della Rpc con le preoccupazioni suscitate all’estero dall’ascesa cinese.
L’antidoto Deng
Difficile dare conto di come si articola il discorso di politica estera in questa fase senza tracciare una linea di continuità con la concezione del ruolo di Pechino nel sistema internazionale propugnata da Deng Xiaoping, la quale, ribadita lungo l’arco di tutti gli anni ’80, segna il definitivo distacco dai precetti e dalle pratiche del maoismo (Evans 1997, 260-261) accompagnando il percorso di “riforma e apertura”. Il 16 gennaio 1980, intervenendo a una riunione di quadri convocata dal Comitato centrale, Deng indica chiaramente che la priorità del riformismo anche in politica estera è lo sviluppo, asserendo che il peso della Rpc negli affari internazionali sarà in futuro determinato in larga misura dalla capacità di mantenere un tasso di crescita economica sostenuto: quanto più ricco e prospero diventerà il Paese, tanto maggiori probabilità avrà di ritagliarsi un ruolo rilevante sul piano globale (Deng 1980). Il concetto viene ripreso e ampliato in un discorso del 29 maggio 1984, introducendo quella giustapposizione fra obiettivi interni ed esterni della modernizzazione cinese che dà il tono al lavoro di politica estera negli anni seguenti: “dobbiamo salvaguardare la pace mondiale e assicurare lo sviluppo nazionale” è lo slogan lanciato in quella occasione (Deng 1984), e con esso vengono sintetizzate le determinanti di una strategia di lungo periodo per l’ascesa della Cina al ruolo di grande potenza (Goldstein 2005, 119). Come è stato osservato, la logica che sta alla base della formula “pace e sviluppo” è semplice ma stringente:
China would not seek confrontation with the West, but would instead keep open her doors for investment, modernization and growth, to give her long-term modernization programme the time it needed to be carried out and come to fruition, by the middle of the twenty-first century (Scott 2007, 78).
Insomma, la continuità del processo di modernizzazione può essere assicurata solo in un ambiente internazionale pacifico e dunque da Pechino non debbono venire minacce sostanziali all’ordine costituito, dato che il Paese non può permettersi di distrarre risorse dall’obiettivo di crescita interna – anche se questo non significa rinunciare a marcare a livello di discorso politico e di propaganda le proprie posizioni, specialmente quando sono in ballo questioni di sovranità nazionale (come nei casi del Tibet, di Taiwan, o dello Xinjiang). D’altra parte la formula implica pure che il processo di sviluppo cinese, garantendo in prospettiva sempre migliori condizioni di vita a una popolazione che costituisce un quinto dell’umanità, di per sé contribuisca alla stabilità, tanto interna del Paese, quanto internazionale. Pace, sviluppo e stabilità sono i cardini della teoria politica riformista (Wong 2005, 217-218), in nome dei quali, nei frangenti più critici, si giustifica la repressione del dissenso.
L’indicazione di fondo che emerge da questa impostazione è che la Rpc, nella fase di ascesa, debba limitare i propri interventi negli affari internazionali, una strategia di attesa che viene ribadita di fronte agli eventi del 1989. La lettura di Deng dei nuovi scenari che si aprono con la caduta del Muro di Berlino è improntata alla massima cautela: intervenendo di fronte al Comitato centrale nel 1990 egli ammonisce che il vecchio modello bipolare sta giungendo a termine, ma che ancora non si intravede un diverso modello di relazioni internazionali che possa prenderne il posto; la prospettiva è che in un futuro mondo multipolare la Cina possa affermarsi come uno dei poli (Scott 2007, 86), ma la possibilità che ciò si realizzi è vincolata alla capacità di continuare a concentrare gli sforzi sulla modernizzazione del Paese. Nel novembre 1991, ormai in procinto di lasciare la leadership per dedicarsi alla raccolta delle proprie opere scelte, Deng espone il concetto nella “massima di 24 caratteri”, una serie di “consigli” al partito e al governo su come muoversi nel mutato contesto internazionale, che possono essere tradotti così: “osservare e analizzare gli sviluppi con calma, consolidare la nostra posizione, affrontare le situazioni con pazienza e fiducia, nascondere le nostre capacità e non esporsi, mantenere il basso profilo e non rivendicare mai un ruolo guida” (Friedberg 2006, 12). Queste raccomandazioni vengono condensate in un principio, “tenere il basso profilo e aspettare il momento opportuno, cercando nel frattempo di realizzare qualcosa” (tao guang yang hui, you suo zuo wei) (Chung 2009, 110), che di fatto orienterà il lavoro di politica estera negli anni successivi.
Ciò detto, nel momento in cui la China threat theory sembra in grado di sconfessare agli occhi della comunità internazionale i fondamentali della politica estera riformista, le iniziative messe in campo da Pechino per controbilanciare il danno d’immagine e le possibili ricadute sulla sicurezza e sulle prospettive di sviluppo economico prendono le mosse dalla scelta di rimettere la formula “pace e sviluppo” al centro del dibattito sul ruolo della Rpc nel mondo globale, oltre che dal contestuale tentativo di rassicurare i partner economici asiatici, in primo luogo i paesi membri dell’Asean, implementando la “politica di buon vicinato” (mulin youhao zhengce) (Shambaugh 2004), di promuovere partnership strategiche bilaterali, per esempio con la Russia (Larson, Shevchenko 2010, 82-83), e di dimostrare un approccio collaborativo con le organizzazioni internazionali, come attesta l’evoluzione dei negoziati di adesione al Wto (Pearson 2001, 343-345) o la decisione di accedere ai trattati di non-proliferazione (Sutter 2010, 122-124; Collotti Pischel 2002, 101). Un impegno che si rivela particolarmente gravoso, perché, come si diceva, le ipotesi di contenimento – più o meno realistiche che siano – fomentano il nazionalismo interno, il cui impatto sulla politica estera è stato tenuto sotto controllo durante gli anni ’80 (Zhu 2001, 17), ma che ora riemerge in maniera prepotente assumendo un connotato apertamente anti-occidentale (Sutter 2010, 51-58), che si affianca ai tradizionali motivi di risentimento nei confronti del Giappone.
È sintomatico del clima politico che sta maturando l’inopinato, travolgente successo popolare fatto registrare, sulla scia della crisi nello Stretto di Taiwan, dal pamphlet “La Cina può dire no” (Zhongguo keyi shuo bu), attraverso il quale un gruppo di giovani autori – tra i quali Song Qiang, Zhang Zangzang e Biao Bian – organizzano la risposta militante alle presunte mire egemoniche di Washington, incitando alla resistenza contro la diffusione della “civiltà occidentale” (Zheng 1999, 148-150). Il tono degli interventi raccolti nel volume, tutti di taglio giornalistico, è sciovinistico e mira a fare sensazione; il messaggio è semplice, diretto e infarcito di luoghi comuni: come possono gli Stati Uniti, una potenza imperialista e moralmente indegna, costantemente alle prese con problemi di razzismo, criminalità, corruzione, criticare gli altri paesi? Di fronte a questa America arrogante, che usa l’idealismo dei “diritti umani” in maniera subdola per promuovere i propri interessi nazionali e si prepara a lanciare una nuova Guerra Fredda per impedire l’ascesa cinese, bisogna rialzare la testa e “dire no”, anche se ciò dovesse significare prendere le armi per combattere l’egemonia di Washington; ma occorre anche riscoprire, coltivare e diffondere nel mondo i valori cinesi di pace e progresso per tutti i popoli: solo così il ventunesimo secolo sarà davvero il nuovo “secolo cinese” (Huang, Lee 2003, 48). Come si diceva, il libro, pubblicato nel giugno 1996, diventa rapidamente un best-seller – nel primo mese ne vengono vendute 250 mila copie legali – e il successo apre la strada ad una proliferazione di titoli analoghi, inaugurando un vero e proprio genere giornalistico, la ‘China can say no’ series, secondo la definizione coniata da alcuni studiosi di media (Li 1997, 159). Negli Stati Uniti si diffonde presto il timore che lo stesso governo di Pechino abbia avuto un ruolo in tutta la vicenda, in sostanza abbia approfittato dell’occasione per giocare con i sentimenti nazionalisti del popolo cinese, impressione per certi versi avallata dal fatto che il principale organo di propaganda del regime, l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, in maniera del tutto inusuale, riprende con numerosi lanci le notizie che raccomandano al pubblico la lettura del volume (Yee, Storey 2002, 5; Huang, Lee 2003, 48).
Mentre all’estero la popolarità della ‘China can say no’ series richiama l’attenzione degli osservatori, preoccupa i governi, solleva critiche per il carattere emotivo e irrazionale delle argomentazioni, a Pechino molti si affannano a puntualizzare che i sentimenti espressi da Song Qiang e dai suoi accoliti non esprimono necessariamente l’orientamento della maggioranza dei cinesi nei confronti degli Stati Uniti, né tanto meno quello del governo della Rpc (Yee, Zhu 2002, 25). Peraltro queste giustificazioni rischiano di apparire mere difese d’ufficio di fronte alla pubblicazione nel dicembre 1996 del volume “Dietro la demonizzazione della China” (Yaomohua Zhongguo de beihou), nel quale la denuncia del “complotto americano” contro l’ascesa di Pechino fa leva su argomenti più sostanziali. L’obiettivo dichiarato di questo apparentemente accurato lavoro d’indagine è dimostrare l’esistenza di radicati sentimenti anti-cinesi nel mondo accademico, dell’editoria, dei mass-media in genere d’Oltreoceano, i quali deliberatamente distorcono l’immagine della Rpc e la impongono al pubblico americano per creare consenso attorno alle ipotesi di nuovo containment (Huang, Lee 2003, 48-49). La tesi non è originale, ma si tratta di una denuncia credibile anche al di fuori degli ambienti prettamente nazionalisti perché i due autori principali, Li Xiguang e Liu Kang, hanno solide credenziali di esperti avendo vissuto, lavorato e studiato negli Stati Uniti – l’uno come giornalista del Washington Post, l’altro come docente alla Pennsylvania State University – e perché il frutto delle loro ricerche viene pubblicato non da un editore commerciale, presumibilmente interessato a fare profitti e quindi propenso a enfatizzare i toni – come nel caso de “La Cina può dire no” – ma dall’Accademia cinese di scienze sociali, uno dei più autorevoli network di istituti di ricerca legati al governo: per inciso si noterà come questo dettaglio sia rivelatore del relativo grado di autonomia di cui in questa fase godono gli analisti politici rispetto alla leadership del partito (Samarani 2010, 95-100).
A parte l’impatto popolare del termine “demonizzazione” e il potere evocativo, in un Paese memore della propaganda maoista, della tesi del complotto di forze straniere ostili alla Rpc, l’efficacia della denuncia di Li e Liu è dovuta all’abilità dei due autori di mescolare demagogia e temi dell’agenda politica di Pechino: e così, se per un verso l’origine dell’atteggiamento anti-cinese dei media americani deve essere ricercato nella generica volontà di riaffermare la supremazia bianca e gli “interessi nazionali borghesi” degli Stati Uniti (Li, Liu et al. 1998, 19), per l’altro questa campagna diffamatoria – che usa false informazioni, fabbrica fatti e manipola notizie – è parte di una strategia preordinata che mira a spaventare gli investitori esteri e ad allontanarli dal mercato della Repubblica popolare, distogliere l’attenzione internazionale dall’egemonismo e dall’espansionismo americano, incoraggiare il militarismo giapponese in funzione anti-cinese, compattare un fronte di paesi asiatici in grado di opporsi alle legittime aspirazioni di Pechino. Fra il 1997 e il 1999, Li e i suoi collaboratori danno alle stampe altri contributi sullo stesso tema (Huang, Lee 2003, 49): il clamore che suscitano è tanto che il libro del 1996 viene anche tradotto in inglese (Li, Liu et al. 1998), presumibilmente non per il suo valore scientifico, ma come barometro dei sentimenti anti-americani che allignano nella Repubblica popolare.
Quanto si è scritto si qui può servire a dare un’idea delle reazioni nazionalistiche più eclatanti alla retorica anti-cinese diffusa dalla China threat school, ma bisogna dire che si registrano anche risposte abbastanza sofisticate, come quelle che fanno capo al ristretto circolo intellettuale della cosiddetta “Nuova sinistra”, il cui approccio al tema si distingue per il tentativo di contrapporre alla pretesa di egemonia americana, sottesa alla nozione di “minaccia”, il richiamo a un concetto di identità nazionale che ribadisce la validità del messaggio marxista, aggiornato però con elementi della stessa critica occidentale della modernità, desunti da autori quali Edward Said o Michel Foucault (Zheng 1999, 46-66). Gli studiosi della “Nuova sinistra” predicano la resistenza alla progressiva integrazione della Rpc nelle strutture del capitalismo globale, che ai loro occhi produce solo consumismo e crescenti disuguaglianze sociali; invocano l’emancipazione dal colonialismo culturale di cui gli Stati Uniti sono portatori, a causa del quale la modernizzazione del Paese si è risolta in una mera occidentalizzazione; giudicano essenziale ridefinire l’identità cinese in termini di autonomia rispetto alle categorie universali proprie della dottrina liberale (capitalismo, mercato, democrazia, diritti umani) (Wang 1998, 10-14). Come è stato osservato, questa reazione, che si scaglia contro la globalizzazione dell’economia e l’omologazione culturale, sfocia in una sorta di nativismo neomaoista e postmoderno, grazie al quale gli intellettuali della “Nuova sinistra” si assicurano una certa influenza sul dibattito politico di questi anni, ma che a sua volta alimenta un’idea di eccezionalismo prossima alla xenofobia (Fewsmith, Rosen 2001, 165).
Non è necessario insistere oltre sul nesso fra la retorica della “minaccia” e l’accentuazione di orientamenti nazionalisti nell’opinione pubblica cinese: è sufficiente ricordare che manifestazioni di nazionalismo anti-occidentale, ora di stampo più populistico, ora più radicate nel discorso accademico, punteggiano tutto il periodo fra il 1996 e il 2000 e raggiungono il culmine nel 1999 quando, in occasione dell’accidentale bombardamento dell’ambasciata della Rpc a Belgrado durante le operazioni della Nato contro la Serbia, i commentatori più schierati virano decisamente sul tema speculare alla China threat, quello della “minaccia americana” (Dreyer 2000; Hays Gries 2001), mentre dagli ambienti militaristi si levano voci che incoraggiano ad ingaggiare gli Stati Uniti in una “guerra senza limiti” (chao xian zhan), come recita il titolo di un volume di grande successo pubblicato in quello stesso anno da Qiao Liang e Wang Xianghui, due ufficiali dell’aeronautica militare i quali, richiamandosi addirittura agli insegnamenti di Osama bin Laden, offrono ai propri lettori il catalogo delle tattiche non convenzionali che potrebbero essere usate per combattere un conflitto globale contro Washington (Huang, Lee 2003, 51).
Teorici al lavoro
Se questo è il clima, ben si comprende lo sforzo della leadership di incanalare il dibattito sulla formula “pace e sviluppo”, che prefigura una strategia imperniata sulla collaborazione e sulla comunicazione piuttosto che sul confronto, reclamato invece dai settori di opinione pubblica e dagli ambienti accademici sensibili ai richiami del nazionalismo, oltre che dalle componenti conservatrici del regime. Una strategia che deve mirare soprattutto a tenere sotto controllo le critiche che provengono dagli Stati Uniti, sebbene la teoria della “minaccia cinese” abbia in questa fase propaggini importanti in Giappone, dove fa leva sul complesso dei nodi irrisolti fra i due paesi e viene alimentata dalla ripresa della disputa sulle Isole Diaoyu/Senkaku, a Taiwan, dove è molto popolare fra gli attivisti pro-indipendenza (Yahuda 2004, 298-305; Segal 1996, 125-128; Ross 1999, 178), e attecchisca pure in India, quando Nuova Delhi usa il tema della “minaccia cinese” per giustificare il test nucleare del 1998 (Deng 2006, 194-197; Nayar, Paul 2003, 229-230). Una strategia, infine, che ha anche un suo versante interno, perché la fiammata di nazionalismo che si accende alla metà degli anni ’90 esprime, in maniera più o meno esplicita, insoddisfazione o, peggio, critica nei confronti del governo – cui si imputa un atteggiamento troppo morbido nei confronti degli Stati Uniti – e richiede interventi per raffreddare le polemiche e impedire che interferiscano col lavoro di politica estera (Fewsmith, Rosen 2001, 163-164; Yee, Zhu 2002, 26).
Nel corso del 1997 a più riprese i vertici della Rpc intervengono pubblicamente per confutare la nozione di “minaccia cinese” e, allo stesso tempo, per orientare il dibattito interno (Yang 2009, 20). Ad esempio, nel mese di marzo il presidente Jiang Zemin ha modo di puntualizzare di fronte a un gruppo di giornalisti stranieri:
Some circles in the West have deliberately exaggerated China’s economic capability and spread the so-called ‘China threat’ alarm. This allegation is completely groundless. China’s current reform and open policy and its modernisation efforts need a prolonged period of stability and peace in the international environment. Even when China becomes strong and powerful it will not threaten other countries.
Analogamente, nel dicembre successivo, il premier Li Peng dichiara:
In order to realize China’s development strategy and its basic objective of raising the level of material well-being and cultural life of the Chinese people, we need, on the one hand, a stable and harmonious domestic political environment and, on the other hand, a peaceful international environment, especially a good environment along China’s borders. These are the prerequisites of China’s continuing development. The Chinese people highly value peace and stability. We oppose great power hegemony and China as a socialist state will never seek hegemony nor a sphere of influence. This is a solemn promise made by the Chinese government to the world. China does not pose a threat to any country or region (Yee, Zhu 2002, 23).
Nel momento in cui i vertici cominciano ad abbozzare la risposta ufficiale alla China threat theory, una risposta che mira a dissipare paure e sospetti, oltre che a marginalizzare nel dibattito interno le posizioni oltranziste, anche l’intellettualità politico-accademica – studiosi attivi nelle università o nella pletora di think tank para-governativi (Shambaugh 2002) – viene coinvolta in analisi meno retoriche e dogmatiche delle percezioni negative del Paese: soprattutto molti prendono ad interrogarsi sull’origine della prevenzione nei confronti della Rpc e sulle sue possibili implicazioni di politica estera (Glaser, Medeiros 2007).
Se la questione fondamentale è come sia possibile definire un percorso di ascesa della Cina al ruolo di grande potenza all’interno di un sistema internazionale oggettivamente dominato dagli Stati Uniti, e quindi espandere progressivamente l’influenza di Pechino senza provocare reazioni che mettano in pericolo il successo della modernizzazione (Goldstein 2005, 12), se questa è la sfida, sicuramente Zheng Bijian è la figura-chiave nel processo di elaborazione della nuova teoria di politica estera. Zheng Bijian diviene noto al vasto pubblico di chi in Occidente si occupa di questioni internazionali solo nel 2003, ma già nel decennio precedente egli si dedica ad approfondire a livello di discorso politico e accademico il nesso esistente, nel contesto post-bipolare, fra pace, sviluppo e stabilità, prendendo le mosse dalla pragmatica direttiva di Deng Xiaoping. Zheng Bijian è una formidabile figura di intellettuale di partito, sicuramente non un personaggio di primo piano della nomenclatura (sebbene abbia fatto parte del XIV e del XV Comitato centrale), il quale tuttavia occupa dalla fine degli anni ’80 in poi posizioni importanti nei luoghi dove si elabora e si trasmette l’ideologia del Pcc: originario del Sichuan, e dunque conterraneo di Deng Xiaoping, dopo aver lavorato a fianco del leader riformista Hu Yaobang come segretario personale (1982-87), diviene in rapida successione vicepresidente dell’Accademia cinese di scienze sociali (Cass) e direttore dell’Istituto per il marxismo-leninismo e il pensiero di Mao Zedong (1988), quindi direttore del Dipartimento della propaganda del Comitato centrale (1992), un ruolo ricoperto con tanto zelo da guadagnarsi la stima di Jiang Zemin; infine è nominato vicepresidente della Scuola centrale del partito, l’istituzione che si occupa della formazione dei quadri dirigenti, dove presta servizio a partire dal 1997 avendo come presidente l’attuale leader Hu Jintao, di cui sarà da questo momento in poi uno dei principali consiglieri di politica estera (China Vitae; Suettinger 2004, 1-2; Christensen 2003, 5).
A Zheng Bijian si deve lo sforzo di elaborare una cornice teorica complessiva cui ricondurre l’esercizio del soft power cinese (Wuthnow 2008) e il tentativo di costruire anche all’estero l’immagine di un Paese disposto a mettere la propria influenza politica ed economica al servizio di un “mondo armonioso” (hexie shijie). Insomma è uno degli architetti di quella che Joshua Kurlantzick ha denunciato essere la Charm Offensive di Pechino (Kurlantzick 2007, 37-60). Da questo punto di vista Zheng è in prima linea in patria nel dibattito sulle caratteristiche dell’ascesa cinese, ma è anche il primo e più convincente divulgatore all’estero – non a caso ha diretto per un certo periodo il Dipartimento della propaganda del Comitato centrale del Pcc – dell’idea di “ascesa pacifica”. Nel dicembre 1997, in un discorso tenuto all’Università di Harvard, uno dei templi dell’intellighenzia liberal americana, espone, facendo ricorso a precedenti storici e rendendo omaggio alle idee modernizzatrici di Sun Yat-sen, Mao Zedong e Deng Xiaoping, il concetto base di “percorso pacifico di sviluppo” (peaceful path of development), focalizzando il suo intervento su tre argomenti principali: 1) la stabilità della Cina delle riforme e dell’apertura è uno dei grandi contributi alla stabilità dello scenario internazionale contemporaneo; 2) lo sviluppo cinese creerà un mercato interno più ampio di cui col tempo tutto il mondo si potrà giovare; 3) la Rpc non ha interesse a sovvertire l’ordine globale che le ha consentito l’eccezionale fase di crescita sperimentata negli anni ’90 e, anzi, ha tutto l’interesse a contribuire al mantenimento di un ambiente internazionale pacifico. Nel passaggio centrale del suo discorso Zheng segnala la convergenza di interessi strategici che dovrebbe guidare e sostenere il “percorso pacifico di sviluppo”: “world peace and development offers very good opportunity for China, and China’s reform and development provides a very good opportunity for the whole world (including the United States)” (Zheng 2005a, 86-87).
Si tratta di una prima articolazione della linea Deng, che riscuote subito consensi fra i fautori della teoria dell’engagement, il cui approccio alla questione dell’ascesa cinese è in gran parte sovrapponibile al discorso riformista di politica estera. Come scrive in questi mesi Robert R. Ross, uno degli esponenti di punta della engagement school,
for China, the strategic imperative is to maintain an international environment in which it can focus its resources on economic modernization. Among the worst possible scenarios for China would be heightened strategic conflict with the United States. […] Washington can challenge core Chinese interests, such as the status of Taiwan, and pose a severe challenge to the Chinese military, imposing prohibitively high costs on the Chinese economy and the national budget and fundamentally transforming China’s strategic environment and derailing its modernization plans (Ross 1998, 29).
Chi, nell’accademia e nei media d’Oltreoceano, sostiene e incoraggia la politica cinese dell’amministrazione Clinton, trova in Zheng Bijian una solida sponda per controbattere alle critiche della coalizione conservatrice, a sua volta impegnata a gettare acqua sul fuoco degli entusiasmi suscitati dal summit cino-americano dell’ottobre 1997 (Teles 1998, 62). D’altra parte i tempi dell’invito a Harvard sono stati ben calcolati, dal momento che Zheng fa la sua prolusione poche settimane dopo il viaggio di Jiang Zemin a Washington, quello in cui comincia a prendere forma la “partnership strategica costruttiva”, e nel pieno di una nuova ondata della China threat theory, provocata dall’uscita della Bibbia del containment cinese, The Coming Conflict with China, scritto a quattro mani da Richard Bernstein e Ross H. Munro e pubblicato per la prima volta proprio nel 1997.
Il volume di Bernstein e Munro può essere considerato, per il tono allarmistico circa le ricadute globali della crescita cinese, per l’ossessiva insistenza sulle presunte mire egemoniche della Rpc, in definitiva per la malcelata ostilità nei confronti di Pechino che anima le sue pagine, la degna controparte – sebbene meglio argomentata – de “La Cina può dire no”. L’intento politico dei due autori è chiaramente quello di sabotare la linea dell’engagement, denunciando l’esistenza negli Stati Uniti di Bill Clinton di una “New China Lobby” di accademici, uomini d’affari, funzionari del servizio esteri (Bernstein, Munro 1998, 105-129), un gruppo di pressione impegnato a propagandare l’illusione che sia possibile trovare un terreno di collaborazione con un Paese il quale solo per una precisa scelta tattica – cioè allo scopo di ridurre le tensioni e spianare così la strada alla propria ascesa – ha deciso di mostrare una faccia conciliante, ma che nella realtà è una potenza insoddisfatta della sua posizione internazionale e soprattutto ambiziosa, il cui obiettivo di dominare l’Asia è alimentato dal crescente nazionalismo interno e dal ricordo della passata grandezza imperiale (51-80). In definitiva, la scelta dell’amministrazione Clinton di scommettere sulla partnership con Pechino è errata e contraria agli interessi americani perché fa l’economia della questione di fondo, che le formule diplomatiche non possono nascondere o, tanto meno, eliminare:
The People’s Republic of China, the world’s most populous country, and the United States, its most powerful, have become global rivals, countries whose relations are tense, whose interests are in conflict, and who face tougher, more dangerous times ahead (3).
Può darsi – sostengono Bernstein e Munro – che per un certo periodo Pechino si faccia imbrigliare nella rete dell’engagement, ma al momento opportuno i suoi impulsi aggressivi verranno alla luce ed allora la Rpc non avrà più alcuna remora a sfidare gli Stati Uniti. Non è nemmeno scontato che l’epilogo sia troppo di là da venire: qualora il ritmo di crescita economica diminuisse in maniera sensibile, qualora si approfondissero ulteriormente le disparità di reddito provocando fenomeni di esteso malcontento sociale, qualora la corruzione continuasse ad erodere la reputazione della leadership o magari si assistesse ad una imponente mobilitazione del movimento per la democrazia come nel 1989, a quel punto il regime, per riaffermare la propria legittimità e conservare il potere, non avrebbe alternativa a quella di scaricare sui nemici esterni, e in primo luogo sugli Stati Uniti, la responsabilità delle difficoltà interne, innescando una spirale di conflitto (186-202). In questo senso, nell’elaborazione di Bernstein e Munro la retorica della minaccia si combina con le ipotesi di collasso cinese. Per altro verso, i due autori non rinunciano ad evocare gli scenari di Huntington sullo scontro di civiltà:
China’s close military cooperation with former Soviet Union, its technological and political help to the Islamic countries of Central Asia and North Africa, and its looming dominance of East Asia put it at the center of an informal network of states many of whom have goals and philosophies inimical to those of the United States, and many of whom share China’s sense of grievance at the long global domination of the West (12).
Non è forse nemmeno il caso di sottolineare che il libro di Bernstein e Munro riunisce e sistematizza in un lavoro di grande impatto sull’opinione pubblica tutti gli elementi che negli anni precedenti hanno concorso a definire la China threat, e spinge verso l’allineamento delle diverse posizioni conservatrici dietro la tesi del containment.
Guardare avanti, guardare indietro
A questa data anche nella Repubblica popolare il dibattito sull’incontestabile ascesa internazionale del Paese ha ormai preso quota e risulta assai meno monocorde di quanto si potrebbe pensare, stanti le dichiarazioni ufficiali del governo e del partito (Yee, Zhu 2002, 29-32). Circoscrivendo il campo alle linee di tendenza prevalenti fra gli specialisti, e lasciando da parte gli approcci tradizionalisti o postmodernisti che pure continuano a manifestarsi e ad esercitare pressioni sull’apparato di politica estera (Fewsmith, Rosen 2001, 171), la discussione è caratterizzata da una notevole varietà di sfumature, apprezzabile, per esempio, nelle posizioni espresse dagli esponenti della scuola moderata, che si muovono nel solco del pragmatismo denghista. Su questo fronte il singolo contributo più rilevante appare il volume pubblicato nel 1998 da Shen Jiru – un ricercatore della Cass molto impegnato a promuovere la linea ufficiale – intitolato “La Cina non dovrebbe essere il ‘Signor No’: questioni di strategia internazionale della Cina contemporanea” (Zhongguo budang ‘Buxiansheng’: dangdai Zhongguo de guoji zhanlue wenti). La tesi di fondo di Shen è che, in un mondo in cui cresce l’interdipendenza economica e proliferano gli scambi culturali, pretendere di erigere barriere nazionalistiche sarebbe, oltre che irrealistico, del tutto controproducente: semplicemente la Rpc, uno dei maggiori beneficiari dei processi di globalizzazione in atto, non può permettersi di perseguire una strategia di non cooperazione con la comunità internazionale, tanto più che Pechino, insieme ad altri grandi paesi e all’Unione Europea, condivide ormai la responsabilità di dare forma al futuro – sebbene non imminente – assetto multipolare. La Cina non deve commettere l’errore della vecchia Urss, che nel vano tentativo di contestare l’egemonia americana ha finito per precludersi la possibilità di applicare in tempo utile quelle politiche riformatrici che le avrebbero consentito di scongiurare la crisi del regime sovietico. Pechino deve invece mirare a una “partnership costruttiva” con Washington basata sull’interesse comune alla stabilità del sistema internazionale e cercare, in virtù di tale collaborazione, di convincere gli Stati Uniti, che rimangono l’unica vera potenza globale, a ripensare il loro ruolo egemonico, spingendoli ad aprirsi a una nuova era di “multipolarismo cooperativo” (Miller, Liu 2001, 146-147).
Non è ovviamente una semplice coincidenza il fatto che, mentre Shen Jiru sviluppa le sue riflessioni, al vertice dello Stato Jiang Zemin torni a più riprese sul concetto di “mondo multipolare” (duoji shijie) (Turner 2009), che per alcuni è la versione cinese della “partnership strategica costruttiva” di Clinton, per altri solo la faccia presentabile del discorso nazionalista di politica estera: è stato infatti osservato che di per sé l’idea di “multipolarizzare” il mondo unipolare comporta una sfida all’egemonia americana (Guo 2006, 2). In realtà il volume di Shen Jiru fa molto più che echeggiare le posizioni di Jiang Zemin, perché aiuta a dissipare i dubbi che fin da subito aleggiano intorno alle ulteriori indicazioni per il lavoro di politica estera dettate dalla leadership, le quali, lungi dal discostarsi significativamente dalle concezioni denghiste, affermano la necessità di continuare a “ballare con il lupo” americano (Dreyer 2000, 15-16; Story 2010, 8), quindi a collaborare con Washington per promuovere l’interdipendenza economica e per affrontare i problemi internazionali attraverso la consultazione e il dialogo (Miller, Liu 2001, 139-145). La visione di Jiang non è, infatti, quella di un multipolarismo in atto, ma di un processo di lunga durata verso una maggiore articolazione del sistema globale (Yang 2009, 28) in cui anche la Cina potrà, a condizione di mantenere alto il ritmo della modernizzazione e di non cedere alle scorciatoie della politica di potenza, ambire a giocare un ruolo di rilievo, non solo in termini economici, ma anche politici e militari; una visione che, pur non accettando come dato immutabile la struttura unipolare dell’ordine mondiale emerso negli anni ’90, di per sé non implica il confronto diretto con la potenza egemone, semmai un approccio cooperativo in nome della stabilità nei rapporti fra i principali attori internazionali (Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina, Unione Europea) che apra la strada ad una transizione morbida verso un nuovo assetto di potere, il cui avvento è auspicabile, anche se ancora di là da venire. Come si diceva, le posizioni di Jiang Zemin non prefigurano uno scontro Pechino-Washington e di fatto esprimono il rinnovato impegno della dirigenza sui fondamentali della politica estera stabiliti nell’era Deng (Scott 2007, 86), ora declinati nel duplice obiettivo di ridurre le tensioni attraverso l’attivismo diplomatico e promuovere i legami economici per rafforzare le relazioni politiche (Miller, Liu 2001, 141).
Al netto dell’elaborazione che si registra nella cerchia degli intellettuali riformisti, a vantaggio dei quali gioca l’obiettiva sintonia con le prese di posizione della leadership, nonché il diverso clima nelle relazioni cino-americane fra il 1997 e il 1999, occorre rilevare come nel dibattito interno acquisti molto credito in questo frangente una corrente di studi “realista” o “storicista” (Huang, Lee 2003, 47), il cui esponente di punta è senz’altro Yan Xuetong, un politologo formatosi a Berkeley, all’epoca direttore del Centro di ricerca sulla politica estera del China Institute for Contemporary International Relations (Cicir) e, in seguito, dell’Institute of International Studies dell’Università Qinghua di Pechino – l’istituzione dove si è formata buona parte dell’élite riformista cinese della terza e quarta generazione, da Zhu Rongji a Hu Jintao, da Xi Jinping a Wu Bangguo. Yan Xuetong è il tipico esempio di quella categoria di “intellettuali pubblici” divenuti popolari e influenti negli anni ’90 perché capaci di animare il dibattito politico-culturale da posizioni non allineate (De Giorgi 2010, 47-48).
Dato il profilo del personaggio, non sorprende di trovarlo fra gli autori di un volume assai controverso uscito nel 1998, il cui titolo suona poco enfatico – “L’ascesa della Cina: una valutazione dell’ambiente internazionale” (Zhongguo jueqi: guoji huanjing pinggu) – ma il cui contenuto in più parti stride con il discorso ufficiale che vede Pechino come forza di pace e stabilità. Si tratta di un’ampia disamina delle implicazioni dell’ascesa cinese, che gli autori affrontano adottando una prospettiva rigorosamente realista e avvalendosi degli strumenti dell’analisi geopolitica e storica (Miller, Liu 2001, 146), per giungere a conclusioni che, nella sostanza, ricalcano la posizione conservatrice americana (Yee, Storey 2002, 6). Il volume, nato in un ambito accademico e probabilmente destinato ad un pubblico di soli specialisti, in realtà ha un impatto mediatico notevole perché prende le mosse da un concetto di restaurazione della potenza cinese che vellica i sentimenti nazionalisti e attira l’attenzione degli organi di comunicazione di massa. Peraltro Yan Xuetong si preoccupa di veicolare i principali risultati delle sue analisi anche in lingua inglese, offrendoli così alla discussione di una più vasta comunità di studiosi (Yan 2001).
Anche il discorso realista è fondato sul presupposto che sia possibile difendere e affermare il ruolo cinese nel mondo contemporaneo usando gli strumenti che il sistema di relazioni post-bipolare mette a disposizione degli Stati: questo significa che è compito della Rpc partecipare attivamente alla vita internazionale, rafforzare gli strumenti di cooperazione bi o multilaterale, aprire maggiormente il Paese ai contatti con l’esterno, ma ogni azione deve essere compiuta calcolandone il ritorno per l’interesse nazionale (35). E l’interesse nazionale primario è che venga finalmente data risposta al problema storico del declino cinese a partire dal XIX secolo, portando a compimento il percorso di “ringiovanimento” (rejuvenation/zhenxing) avviato da Sun Yatsen e proseguito da Mao Zedong, Deng Xiaoping e Jiang Zemin. Le élite cinesi, dalla fine dell’ordinamento imperiale in poi, non hanno mai concepito la rinascita della nazione come pura e semplice espressione di una volontà di potenza, ma come sforzo per ristabilire una forma di giustizia nel sistema internazionale: letta in chiave storicista, infatti, l’ascesa della Rpc non comporta un sovvertimento dell’ordine, semmai una restaurazione dell’ordine, che significa rivendicare lo status di grande potenza di cui il Paese ha goduto, per esempio, in epoca Han (fra il II secolo a.C. e il II secolo d.C.), in epoca Tang (secc. VII-X) e in epoca Qing, almeno fino alle guerre dell’oppio; significa riemergere dalla decadenza causata dall’affermarsi in Asia dell’imperialismo (europeo, giapponese, americano e sovietico); infine implica, in un’ottica di riequilibrio della forze, tarare il percorso di sviluppo cinese rispetto all’obiettivo di raggiungere nel lungo periodo l’attuale superpotenza, gli Stati Uniti – passaggio dove risuona qualche eco del discorso maoista degli anni del Grande balzo in avanti, anche se allora l’obiettivo della rincorsa era la Gran Bretagna. Il tono del discorso si fa conciliante quando Yan Xuetong afferma che l’ascesa della Cina è un processo storico di lunga durata, del quale la leadership in carica non vedrà il compimento e la cui piena realizzazione presuppone una politica estera moderata e una crescita pacifica (34). Tuttavia, dal momento che Pechino non aspira ad espandere il suo territorio o ad esercitare pressioni militari, la retorica della “minaccia cinese” viene percepita come il segnale di un pregiudizio ostile, quando non di una vera e propria cospirazione volta ad impedire agli Han di riprendere il loro posto nella storia. Perfino la politica di engagement viene letta dai realisti in senso negativo per le legittime aspirazioni cinesi, e quindi non come una strategia che mira a cooptare la Rpc fra le grandi potenze, ma come un modo per imbrigliare Pechino e prevenirne l’ascesa, cosicché Washington possa conservare i privilegi derivanti dall’essere l’unica superpotenza (36).
Ora, va da sé che questa idea di restaurazione della potenza cinese implica la revisione di un sistema internazionale fortemente asimmetrico e dominato dagli Stati Uniti, i quali, ormai liberi dai condizionamenti alla loro azione posti dall’antagonismo con l’Unione Sovietica, si dimostrano sempre più insofferenti delle soluzioni diplomatiche e invece sempre più propensi alle soluzioni militari (il riferimento è al bombardamento dell’Iraq nel 1998). L’ascesa cinese viene concepita, allora, come antidoto ai rischi del mondo unipolare e come strumento grazie al quale sarà possibile, a partire dalla regione dell’Asia-Pacifico, ristabilire un equilibrio delle forze (37), che è il cardine di ogni teoria realista, ma che contiene anche un richiamo alla concezione del “mondo multipolare” di Jiang Zemin. Al di là della petizione di principio, che attribuisce alla Rpc la capacità di agire come fattore di stabilizzazione del sistema globale, è difficile sfuggire all’impressione che la pretesa di restaurare la potenza cinese possa comportare, nel migliore dei casi, un dato di tensione nelle relazioni internazionali, nel peggiore determinare la nascita di più o meno pericolose forme di rivalità.
Bibliografia
Acheson Dean
1967 Letter of Transmittal to President Truman, in United States Department of State, The China White Paper, August 1949, reissued and with a new introduction by Lyman P. Van Slyke, Stanford (CA): Stanford University Press, pp. III-XVII.
Al-Rodhan Khalid R.
2007 A Critique of the China Threat Theory: a Systematic Analysis, in “Asian Perspective”, vol. 31, n. 3, pp. 41-66.
Andornino Giovanni B.
2008 Dopo la muraglia. La Cina nella politica internazionale del XXI secolo, Milano, Vita & Pensiero.
Arrighi Giovanni
2008 Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, trad. it. Milano, Feltrinelli.
Bergsten Fred C., Freeman Charles, Lardy Nicholas R., Mitchell Derek J.
2008 China’s Rise: Challenges and Opportunities, Washington D.C., Peterson Institute for International Economics.
Bernstein Richard, Munro Ross H.
1998 The Coming Conflict with China, New York (NY): Vintage Books (1st ed. New York (NY), Alfred A. Knopf, 1997).
Broomfield Emma V.
2003 Perceptions of Danger: the China Threat Theory, in “Journal of Contemporary China”, vol. 12, n. 35, pp. 265-284.
Brown Lester R.
1995 Who will feed China? Wake up call for a small planet, Washington D.C., Worldwatch Institute.
Buzan Barry
2010 China in International Society: Is ‘Peaceful Rise’ Possible?, in “The Chinese Journal of International Politics”, vol. 3, n. 1, pp. 5-36.
Chang Gordon G.
2001 The Coming Collapse of China, New York (NY) – Toronto, Random House.
Chang Maria Hsia
1992 China’s Future: Regionalism, Federation, or Disintegration, in “Studies in Comparative Communism”, vol. 25, n. 3, pp. 211-227.
Chen Jian
2001 Mao’s China and the Cold War, Chapel Hill (NC) and London, The University of North Carolina Press.
Chen Zhimin
2009 International Responsibility and China’s Foreign Policy, in Masafumi, pp. 7-28.
Chin Annping
2008 Confucio. Una vita di pensiero e di politica, trad. it. Roma-Bari: Laterza.
China Reform Forum
http://www.policyinnovations.org/innovators/organizations/data/00916
http://www.crf.org.cn/
China Vitae
Biography of Zheng Bijian
(http://chinavitae.com/biography/Zheng_Bijian/full).
Biography of Hu Jintao
(http://chinavitae.com/biography/Hu_Jintao/full).
Christensen Thomas J.
2003 The Party Transition: Will It Bring a New Maturity in Chinese Security Policy?, in “China Leadership Monitor”, n. 5, pp. 3-19 (http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/clm5_tc.pdf).
Chung Chien-peng
2009 The “Good Neighbour Policy” in the context of China’s foreign relations, in “China: An International Journal”, vol. 7, n. 1, pp. 107-123.
Chung Jae Ho
2003 China’s Reforms at Twenty-Five: Challenges for the New Leadership, in “China: An International Journal”, vol. 1, n. 1, pp. 127-132.
2006 Assessing the Odds against the Mandate of Heaven: Do the Numbers (on Instability) Really Matter?, in Id. (ed.), Charting China’s Future. Political, Social, and International Dimensions, Lanham (MD): Rowman & Littlefield, pp. 107-128.
Collotti Pischel Enrica
2002 La Cina. La politica estera di un paese sovrano, Milano, Franco Angeli.
Conable Barber B. Jr., Lampton David M.
1993 China: the Coming Power, in “Foreign Affairs”, vol. 71, n. 5, pp. 133-149.
Congiu Francesca
2008 Il partito alla ricerca di un compromesso: la “società armoniosa” nella Cina di Hu Jintao, in “Asia Maior”, 2007, L’Asia nel “grande gioco”, a cura di Michelguglielmo Torri, Milano, Guerini & Associati, pp. 311-364.
Cooney Kevin J., Sato Yoichiro (eds.)
2009 The Rise of China and International Security: America and Asia Respond, New York (NY), Routledge.
De Giorgi Laura
2007 La Repubblica popolare cinese: luci e ombre dell’ascesa pacifica, in “Asia Maior”, 2005/2006, L’Asia negli anni del drago e dell’elefante, a cura di Michelguglielmo Torri, Milano, Guerini & Associati, pp. 375-414.
2010 Costruzione del consenso ed espressioni di pluralismo in Cina: il ruolo dei media, in Meneguzzi Rostagni.
Del Pero Mario
2011 Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2011, Roma-Bari, Editori Laterza.
Deng Xiaoping
1980 The present situation and the tasks before us, January 16, 1980, in Selected Works of Deng Xiaoping, vol. II (1975-1982), edited by People’s Daily Online (http://www. people.com.cn/english/dengxp/ home.html).
1984 We must safeguard world peace and ensure domestic development, May 29, 1984, in Selected Works of Deng Xiaoping, vol. III (1982-1992), edited by People’s Daily Online (http://www.people.com.cn/english/ dengxp/home.html)
Deng Yong
2006 Reputation and Security Dilemma. China Reacts to the China Threat Theory, in Johnston, Ross, pp. 186-214.
2008 China’s Struggle for Status. The Realignment of International Relations, New York (NY), Cambridge University Press.
Deng Yong, Wang Fei-ling (eds.)
2005 China Rising: Power and Motivation in Chinese Foreign Policy, Lanham (ML), Rowman & Littlefield.
Department of Defense
2002 Annual Report on the Military Power of the People’s Republic of China (on-line alla pagina web: http://www.defense.gov/news/Jul2002/d20020712china.pdf).
Dreyer June Teufel
2000 The PLA and Kosovo: A Strategy Debate, in “Issues & Studies”, vol. 36, n. 1, pp. 100-119.
Evans Richard
1997 Deng Xiaoping and the Making of Modern China, revised edition, London, Penguin Books.
Ferretti Valdo
2006 La questione della sicurezza nell’evoluzione della politica estera della Repubblica Popolare Cinese, Soveria Mannelli, Rubbettino.
Fewsmith Joseph, Rosen Stanley
2001 The Domestic Context of Chinese Foreign Policy: Does “Public Opinion” Matter?, in Lampton, pp. 151-187.
Foot Rosemary
2001 Chinese Power and the Idea of a Responsible State, in “The China Journal”, n. 45, pp. 1-19.
Friedberg Aaron L.
2006 “Going Out”: China’s Pursuit of Natural Resources and Implications for the PRC’s Grand Strategy, in “NBR Analysis”, vol. 17, n. 3, pp. 5-34 (on-line alla pagina web del National Bureau of Asian Research: http://www.nbr.org).
Garrison Jean A.
2005 Making China Policy. From Nixon to G.W. Bush, Boulder (CO), Lynne Rienner.
Gertz Bill
2000 The China Threat: How the People’s Republic Targets America, Washington D.C., Regnery Publishing.
Gill Bates, Mulvenon James
2002 Chinese Military-Related Think Tanks and Research Institutions, in “The China Quarterly”, n. 171, pp. 617-624.
Glaser Bonnie S., Medeiros Evan S.
2007 The Changing Ecology of Foreign Policy-Making in China: the Ascension and Demise of the Theory of “Peaceful Rise”, in “The China Quarterly”, n. 190, pp. 291-310.
Goldstein Avery
2005 Rising to the Challenge. China’s Grand Strategy and International Security, Stanford (CA), Stanford University Press.
Goldstone Jack A.
1995 The Coming Chinese Collapse, in “Foreign Policy”, n. 99, pp. 35-53.
Greenfield Karl T.
1992 Return of the Yellow Peril, in “The Nation”, may 11.
Guoguang Wu, Lansdowne Helen (eds.)
2008 China Turns to Multilateralism. Foreign Policy and Regional Security, New York (NY), Routledge, pp. 175-197.
Guo Sujian
2006 Challenges and Opportunities for China’s “Peaceful Rise”, in Id. (ed.), China’s “Peaceful Rise” in the 21st Century: Domestic and International Conditions, Aldershot, Ashgate, pp. 1-14.
Guo Sujian, Blanchard Jean-Marc F. (eds.)
2008 “Harmonious World” and China’s New Foreign Policy, Lanham (MD), Lexington Books.
Guo Sujian, Hua Shiping (eds.)
2009 New Dimensions of Chinese Foreign Policy, Lanham (MD), Lexington Books.
Harding Harry
1992 A Fragile Relationship. The United States and China since 1972, Washington D.C., The Brookings Institution.
Hays Gries Peter
2001 Tears of Rage: Chinese Nationalist Reactions to the Belgrade Embassy Bombing, in “China Journal”, n. 46, pp. 25-43.
House of Representatives
1999 Report of the Select Committee on U.S. National Security and Military/Commercial Concerns with the People’s Republic of China, submitted by Mr. Cox of California, Chairman, Washington D.C., U.S. Government Printing Office (on-line alla pagina web: http://www.house.gov/coxreport/).
Hu Jintao
2005 Build Towards a Harmonious World of Lasting Peace and Common Prosperity. Statement by H.E. Hu Jintao, President of the People’s Republic of China, at the United Nations Summit. New York, September 15, 2005 (on-line alla pagina web: http://www.un.org/webcast/summit2005/statements15/china050915eng.pdf).
Huang Yasheng
1995 Why China will not collapse, in “Foreign Policy”, n. 99, pp. 54-68.
Huang Yu, Lee Chin-Chuan
2003 Peddling party ideology for a profit. Media and the rise of Chinese nationalism in the 1990s, in Rawnsley, Rawnsley, pp. 41-61.
Hughes Christopher R.
1997 Globalisation and nationalism: squaring the circle in Chinese international relations theory, in “Millennium: Journal of international studies”, vol. 26, n. 1, pp. 103-124.
2006 Chinese Nationalism in the Global Era, New York (NY), Routledge.
Huntington Samuel P.
1993 The Clash of Civilizations?, in “Foreign Affairs”, vol. 72, n. 3, pp. 22-49.
1996 The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York (NY), Simon & Schuster.
2000 Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano, Garzanti.
Ikenberry John
2008 The Rise of China and the Future of the West, in “Foreign Affairs”, vol. 87, n. 1, pp. 23-37.
International Monetary Fund (IMF)
2010 World Economic Outlook, October 2010. Recovery, Risk, and Rebalancing, Washington D.C., IMF Publication Services (on-line alla pagina web: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/index.htm).
Information Office of the State Council of the People’s Republic of China
1991- White Papers (on-line alla pagina web: http://english.gov.cn/official/2005-08/17/content_24165.htm).
2005 China’s Peaceful Development Road, Beijing, New Star Publishers.
Izraelewicz Erik
2005 La sfida. Se la Cina cambia il mondo, trad. it. Torino, Lindau.
Jeffery Renée
2009 Evaluating the ‘China Threat’: Power Transition Theory, the Successor-State Image and the Dangers of Historical Analogies, in “Australian Journal of International Affairs”, vol. 63, n. 2, pp. 309-324.
Jia Qingguo
2005 Peaceful Development: China’s Policy of Reassurance, in “Australian Journal of International Affairs”, vol. 59, n. 4, pp. 493-507.
Jin Canrong
2001 A Response to Ted Osius: Policy Legacy and Political Context in US Relations with China, in “Asian Affairs”, vol. 28, n. 3, pp. 134-137.
Johnston Alastair I.
2003 Is China a Status Quo Power?, in “International Security”, vol. 27, n. 4, pp. 5-56.
Johnston Alastair I., Ross Robert S. (eds.)
1999 Engaging China. The Management of an Emerging Power, London and New York (NY), Routledge.
2006 New Directions in the Study of China’s Foreign Policy, Palo Alto (CA), Stanford University Press.
Kaplan Robert D.
2005 How We Would Fight China, in “The Atlantic Monthly”, vol. 295, n. 5, pp. 49-64.
2010 The Geography of Chinese Power. How Far Can Beijing Reach on Land and at Sea?, in “Foreign Affairs”, vol. 89, n. 3, pp. 22-41.
Kaiser Robert G., Mufson Steven
2000 The “War Party’s” China Hands. The Blue Team, in “The Washington Post”, february 22.
Khalilzad Zalmay M. et al.
1999 The United States and a Rising China. Strategic and Military Implications, Santa Monica (CA), Rand Corporation.
Krauthammer Charles
1991 The Unipolar Moment, in “Foreign Affairs”, vol. 70, n. 1, pp. 23-33.
Kristof Nicholas D.
1993 Rise of China, in “Foreign Affairs”, vol. 72, n. 5, pp. 59-74.
Kurlantzick Joshua
2007rm Offensive. How China’s Soft Power is Transforming the World, New Haven (CT) and London, Yale University Press.
Lampton David M.
2001 (ed.) The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform, 1978-2000, Stanford (CA), Stanford University Press.
2007 The Faces of Chinese Power, in “Foreign Affairs”, vol. 86, n. 1, pp. 115-127.
Larson Deborah W., Shevchenko Alexei
2010 Status Seekers. Chinese and Russian Responses to U.S. Primacy, in “International Security”, vol. 34, n. 4, pp. 63-95.
Li Hongshan
1997 China talks back: anti-Americanism or nationalism?, in “Journal of Contemporary China”, vol. 6, n. 14, pp. 153-160.
Li Xiguang, Liu Kang et al.
1998 Demonizing China: a critical analysis of the US press, in “Contemporary Chinese Thought”, n. 30, pp. 3-102 (special issue, translated from Chinese).
Lin Cheng-yi
2007 The Rise of China and Taiwan’s Response: the Anti-Secession Law as a Case Study, in “Issues & Studies”, vol. 43, n. 1, pp. 159-188.
Liu Yiyou
2005 L’influenza dell’“ascesa pacifica” dei comunisti cinesi sulle potenze della regione, in “Mondo Cinese”, n. 125, pp. 49-61.
Lobe Jim, Oliveri Adele (cur.)
2003 I nuovi rivoluzionari. Il pensiero dei neoconservatori americani, Milano, Feltrinelli.
Marble Andrew D. (ed.)
2000 The China Threat Debate, in “Issues & Studies”, vol. 36, n. 1 (special issue).
Masafumi Iida (ed.)
2009 China’s Shift. Global Strategy of the Rising Power, Tokyo, The National Institute for Defense Studies.
Mearsheimer John J.
2001 The Tragedy of Great Power Politics, New York (NY), W.W. Norton.
2003 La logica di potenza. L’America, le guerre, il controllo del mondo, Prefazione di Sergio Romano, Milano, Università Bocconi Editore.
Meneguzzi Rostagni Carla (cur.)
2010 La Cina luci e ombre. Evoluzione politica e relazioni esterne dopo Mao, Milano, FrancoAngeli.
Merton Robert K.
1966 Teoria e struttura sociale, trad. it. Bologna, il Mulino.
Miller Lyman H., Liu Xiaohong
2001 The Foreign Policy Outlook of China’s “Third Generation” Elite, in Lampton, pp. 123-150.
Miranda Marina
2007 Mediazione e “visione scientifica”: Hu Jintao al XVII Congresso del Pcc, in “Mondo Cinese”, n. 133, pp. 5-18.
Moore Thomas G., Yang Dixia
2001 Empowered and Restrained: Chinese Foreign Policy in the Age of Economic Interdependence, in Lampton, pp. 191-229.
Munro Ross H.
1992 Awakening Dragon: the Real Danger in Asia is from China, in “Policy Review”, n. 62, pp. 10-17.
Narayanan Raviprasad
2007 The Chinese Discourse on the ‘Rise of China’, in “Strategic Analysis”, vol. 31, n. 4, pp. 645-663.
Navarro Peter
2006 The Coming China Wars. Where They Will Be Fought and How They Can Be Won, Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall/FT Press (revised ed. 2008).
Nayar Baldev Raj, Paul T.V.
2003 India in the World Order. Searching for Major-Power Status, Cambridge, Cambridge University Press.
Onnis Barbara
2011 La Cina nelle relazioni internazionali. Dalle guerre dell’oppio a oggi, Roma, Carocci.
Osius Ted
2001 Discussion of ‘The Rise of China in Chinese Eyes’, in “Journal of Contemporary China”, vol. 10, n. 26, pp. 41-44.
Pan Chengxin
2004 The ‘China Threat’ in American Self-Imagination: the Discursive Construction of Other as Power Politics, in “Alternatives: Global, Local, Political”, vol. 29, n. 3, 305-331.
Pearson Margaret M.
2001 The Case of China’s Accession to GATT/WTO, in Lampton, pp. 337-370.
Ramo Joshua Cooper
2004 The Beijing Consensus, London, The Foreign Policy Center.
Rice Condoleezza,
2000 Promoting the National Interest, in “Foreign Affairs”, vol. 79, n. 1, pp. 45-62.
2008 Rethinking the National Interest. American Realism for a New World, in “Foreign Affairs”, vol. 87, n. 4, pp. 2-26.
Robinson Thomas W., Shambaugh David (eds.)
1994 Chinese Foreign Policy: Theory and Practice, Oxford, The Clarendon Press.
Ross Robert S.
1995 Negotiating Cooperation. The United States and China, 1969-1989, Stanford (CA), Stanford University Press.
1998 The Strategic and Bilateral Context of Policy-Making in China and the United States: Why Domestic Factors Matter, in Ross, 3-39.
1999 Engagement in US China Policy, in Johnston, Ross, pp. 176-206.
Ross Robert S. (ed.)
1998 After the Cold War. Domestic Factors and U.S.-Cina Relations, London-Armonk (NY), M.E. Sharpe.
Rawnsley Gary D., Rawnsley Ming-Yeh T. (eds.)
2003 Political Communications in Greater China. The Construction and Reflection of Identity, London, Routledge-Curzon.
Ross Robert S., Zhu Feng (eds.)
2008 China’s Ascent: Power, Security, and the Future of International Politics, Ithaca (NY), Cornell University Press.
Roy Denny
1996 The ‘China Threat’ Issue: Major Arguments, in “Asian Survey”, vol. 36, n. 8, pp. 758-771.
2002 China and the War on Terrorism, in “Orbis”, vol. 46, n. 6, pp. 511-521.
Samarani Guido
2010 Cina, ventunesimo secolo, Torino, Giulio Einaudi editore.
Schmitt Gary J. (ed.)
2009 The Rise of China: Essays on the Future Competition, New York (NY), Encounter Books.
Scott David
2007 China Stands Up. The PRC and the International System, New York (NY), Routledge.
Segal Gerald
1996 East Asia and the “Constrainment” of China, in “International Security”, vol. 20, n. 4, pp. 107-135.
Shambaugh David
1996 Containment or Engagement of China? Calculating Beijing’s Responses, in “International Security”, vol. 21, n. 2, pp. 180-209.
2002 China’s International Relations Think Tanks: Evolving Structure and Process, in “The China Quarterly”, n. 171, pp. 575-596.
2004 China Engages Asia. Reshaping the Regional Order, in “International Security”, vol. 29, n. 3, pp. 64-99.
Shao Kuo-kang
1996 Zhou Enlai and the Foundations of Chinese Foreign Policy, New York (NY), St. Martin’s Press.
Shirk Susan L.
2007 China: Fragile Superpower. How China’s Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise, New York (NY), Oxford University Press.
Simoni Alberto
2004 G.W. Bush e i falchi della democrazia. Viaggio nel mondo dei neoconservatori, Reggio Calabria, Falzea.
Spaventa Alessandro, Monni Salvatore
2009 Al largo di Okinawa. Petrolio, armi, spie e affari nella sfida tra Cina e Usa, Roma-Bari, Editori Laterza.
Story Jonathan
2010 China in the global business system: wrecker or stakeholder?, in “BICCS Asia Paper”, vol. 5, n. 1 (on-line alla pagina web del Brussels Institute of Contemporary China Studies: http://www.vub.ac.be/biccs).
Suettinger Robert L.
2004 The Rise and Descent of “Peaceful Rise”, in “China Leadership Monitor”, n. 12, pp. 1-10 (http://www. hoover.org/publications/china-leadership-monitor/article/7739).
Sutter Robert G.
1998 Domestic Politics and the U.S.-China-Taiwan Triangle. The 1995-96 Taiwan Strait Conflict and Its Aftermath, in Ross, pp. 70-106.
2005 China’s Rise in Asia: Promises and Perils, Lanham (ML), Rowman & Littlefield.
2010 Chinese Foreign Relations. Power and Policy since the Cold War, 2nd ed., Lanham (MD), Rowman & Littlefield.
Swaine Michael D., Tellis Ashley J.
2000 Interpreting China’s Grand Strategy. Past, Present, and Future, Santa Monica (CA), Rand Corporation.
Teles Steven M.
1998 Public Opinion and Interest Groups in the Making of U.S.-China Policy, in Ross, pp. 40-69.
The White House
2002 The National Security Strategy of the United States of America, Washington D.C. (on-line alla pagina web: http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-020920.pdf).
Timperlake Edward, Triplett William C.
1998 Year of the Rat: How Bill Clinton Compromised US Security for Chinese Cash, Washington D.C., Regency.
1999 Red Dragon Rising. Communist China’s Military Threat to America, Washington D.C., Regency.
Turner Susan
2009 Russia, China and a Multipolar World Order: the Danger in the Undefined, in “Asian Perspective”, vol. 33, n. 1, pp. 159-184.
van Wolferen Karel
1989 The Enigma of Japanese Power, London, Macmillan (trad. it. Nelle mani del Giappone, Milano, Sperling & Kupfer, 1990).
Wang Fei-ling
2009 To Assess the Rise of China, in “Asia Policy”, n. 8, pp. 151-159.
Wang Hongying
2005 National Image Building and Chinese Foreign Policy, in Deng, Wang, pp. 73-102.
Wang Hui
1998 Contemporary Chinese Thought and the Question of Modernity, in “Social Text”, n. 16, pp. 9-44.
Wang Jisi, Zou Sicheng
1996 Civilisations: clash or fusion?, in “Beijing Review”, vol. 39, n. 3, pp. 11-12.
Weber Maria
2006 L’ascesa internazionale della Cina, in “La Comunità internazionale”, n. 1, pp. 43-63.
Wong Yiu-chung
2005 From Deng Xiaoping to Jiang Zemin. Two decades of political reform in the People’s Republic of China, Lanham (MD), University Press of America.
Wu Yu-shan
2004 Taiwanese Nationalism and Its Implications: Testing the Worst-Case Scenario, in “Asian Survey”, vol. 44, n. 4, pp. 614-625.
Wuthnow Joel
2008 The Concept of Soft Power in China’s Strategic Discourse, in “Issues & Studies”, vol. 44, n. 2, pp. 1-28.
Xiang Lanxin
2001 Washington’s Misguided China Policy, in “Survival”, vol. 43, n. 3, pp. 7-24.
2004 China’s Eurasian Experiment, in “Survival”, vol. 46, n. 2, pp. 109-122.
Yahuda Michael
2004 The International Politics of the Asia-Pacific, London, Routledge-Curzon.
Yan Xuetong
2001 The Rise of China in Chinese Eyes, in “Journal of Contemporary China”, vol. 10, n. 26, pp. 33-39.
Yang Jian
2009 The rise of China: Chinese perspectives, in Cooney, Sato, pp. 13-37.
Yee Herbert, Storey Ian (eds.)
2002 The China Threat: Perceptions, Myths and Reality, New York (NY), Routledge-Curzon.
Yi Xiaoxiong
2005 Chinese Foreign Policy in Transition: Understanding China’s ‘Peaceful Development’, in “The Journal of East Asian Affairs”, vol. 19, n. 1, pp. 74-112.
Yue Jianyong
2008 Peaceful Rise of China: Myth or Reality?, in “International Politics”, vol. 45, n. 4, pp. 439-456.
Zheng Bijian
2005a China’s Peaceful Rise. Speeches of Zheng Bijian: 1997-2005, Washington D.C., Brookings Institution Press.
2005b China’s “Peaceful Rise” to Great-Power Status, in “Foreign Affairs”, vol. 84, n. 5, pp. 18-24.
Zheng Bijian, Wolf Charles Jr. (eds.)
2005 Proceedings of the 6th Annual RAND – China Reform Forum Conference, August 28-29, 2003, Santa Monica (CA), Rand Corporation.
Zheng Yongnian
1999 Discovering Chinese Nationalism in China. Modernization, Identity, and International Relations, Cambridge, Cambridge University Press.
Zheng Yongnian, Tok Sow Keat
2008 Intentions on Trial. “Peaceful Rise” and Sino-Asean Relations, in Guoguang, Lansdowne, pp. 175-197.
Zhao Suisheng (ed.)
2004 Chinese Foreign Policy. Pragmatism and Strategic Behaviour, Armonk (NY), M.E. Sharpe.
Zhu Tianbiao
2001 Nationalism and Chinese Foreign Policy, in “The China Review”, vol. 1, n. 1, pp. 1-27.
Zhu Yibing, Yang Dazhi
2005 Compendio degli studi cinesi e stranieri sull’“ascesa” e l’“ascesa pacifica” della Cina, in “Mondo Cinese”, n. 125, pp. 43-49.
Zhu Zhiqun
2010 China’s New Diplomacy. Rationale, Strategies and Significance, Abingdon, Ashgate.
Biografia
Andrea Francioni, PhD, is an associate professor of History of International Relations at the University of Siena. He is the author of two books (Medicina e diplomazia, 1999; Il “banchetto cinese”, 2004) and several articles on the diplomacy of imperialism. He is carrying out a research project dealing with the Italian staff of the Chinese maritime customs (1881-1943). His current research interests include: Chinese foreign policy since 1949 and Western imperialism in late Qing and republican China. He is a member of the Association for Asian Studies, the Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, and the Società italiana di storia internazionale.


