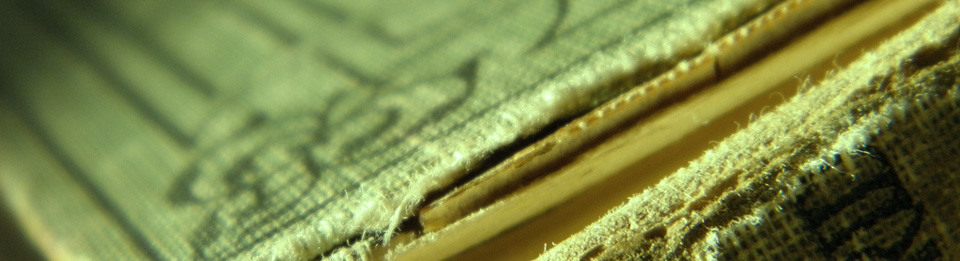
di Tito Menzani
 Accanto a quella privata e a quella cooperativa, l’impresa pubblica è da tempo oggetto di interesse della business history, specialmente nel contesto italiano, visto il ruolo che ha avuto nel Novecento, in particolare tra la crisi del 1929 e la fine della cosiddetta “Prima repubblica”. Mattia Granata, presidente del CentroLumina, collaboratore dell’Università di Milano e studioso abbastanza noto di questi temi, ha voluto dedicare una ricerca alla parabola discendente di questo tragitto, compresa fra il 1972 e il 1992.
Accanto a quella privata e a quella cooperativa, l’impresa pubblica è da tempo oggetto di interesse della business history, specialmente nel contesto italiano, visto il ruolo che ha avuto nel Novecento, in particolare tra la crisi del 1929 e la fine della cosiddetta “Prima repubblica”. Mattia Granata, presidente del CentroLumina, collaboratore dell’Università di Milano e studioso abbastanza noto di questi temi, ha voluto dedicare una ricerca alla parabola discendente di questo tragitto, compresa fra il 1972 e il 1992.
Nei primi anni trenta, la nazionalizzazione delle banche miste a rischio di fallimento, attraverso la creazione dell’Istituto mobiliare italiano (Imi) e dell’Istituto per la ricostruzione industriale (Iri), aveva posto le basi del dirigismo pubblico in economia. Dopo la fine del fascismo e della seconda guerra mondiale, tale assetto non venne smantellato, e le imprese statali continuarono a proliferare negli anni del miracolo italiano.
In questa fase, anzi, vari settori merceologici – come quello chimico, quello meccanico o quello siderurgico – raggiunsero livelli di eccellenza, proprio grazie al sistema delle cosiddette partecipazioni statali. Esauritasi la fase di crescita dell’economia, l’impresa pubblica imboccò una strada di progressivo declino, in linea, del resto, con ciò che stava accadendo negli altri paesi occidentali. Le privatizzazioni e le liberalizzazioni inaugurate dal governo britannico di Margaret Thatcher furono un modello poi imitato da numerosi altri contesti europei, tra i quali l’Italia, che a seguito della crisi economica e politica del 1992 abbandonò gran parte delle precedenti vocazioni di Stato-imprenditore.
I vent’anni considerati da Granata furono densi di dibattiti sull’opportunità di rivedere o ripensare l’impresa pubblica, per risolvere i problemi principali che l’attanagliavano, ad iniziare dall’inefficienza organizzativa, della cultura clientelare, dagli oneri pubblici in termini di ripianamento dei bilanci. Dunque, il libro – edito grazie al sostegno della Fondazione Ivano Barberini – ripercorre un tragitto di declino sulla base della documentazione, spasso inedita, delle tante commissioni parlamentari, ministeriali e tecniche che si sono occupate di questi problemi nel corso degli anni settanta ed ottanta.
Ne emerge – questa la tesi di fondo di Mattia Granata – l’incapacità della classe politica di fare i conti con lo Stato-imprenditore, per ammodernarne le strutture e ridare fiato a quanto di positivo aveva espresso negli anni precedenti. Quindi, la cancrena dell’inefficienza finì con l’avere la meglio su tutto il sistema delle partecipazioni statali, repentinamente privatizzate nei primi anni novanta, in parallelo al collasso della Prima repubblica e dei partiti che l’avevano animata.
Nell’introduzione al volume, Salvatore Bragantini – collaboratore del Corriere della sera ma soprattutto forte di una lunga esperienza nel private equity – utilizza toni ancor più netti, affermando che le partecipazioni statali sono sprofondate in un “abisso di chiacchiere inutili […], con il loro carico di esperienze e competenze solo in parte riutilizzato dall’economia italiana”. Il riferimento è all’insieme di sterili dibattiti – chiamato efficacemente da Granata “un coro tragico” – che hanno accompagnato la fine dell’industria di Stato senza modificarne in alcun modo le sorti.
Si tratta di un volume che affronta di petto una questione forse scomoda – la fine delle partecipazioni statali è letta alla luce di gravi responsabilità della classe politica – che come tale è destinato a sollecitare una nuova attenzione storiografica su questi aspetti, se non addirittura a suscitare una qualche reazione verbale da parte di coloro che vissero quella fase da protagonisti, o meglio – nell’interpretazione di Granata – da spettatori passivi.


