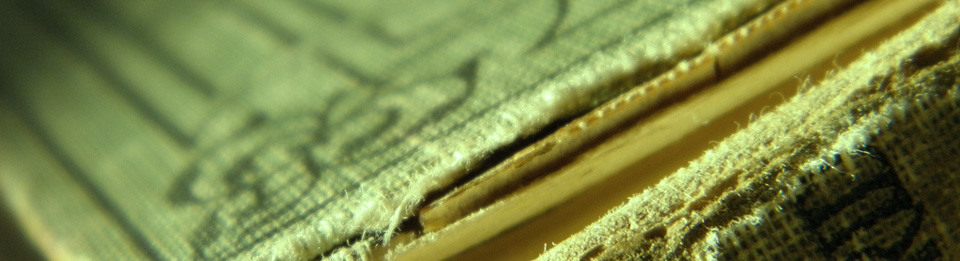
Andrea Girometti
 Il testo di Ugo Mattei e Laura Nader è innanzitutto un dispositivo teorico potente e non convenzionale. Un’elaborazione critica, una pars destruens – come precisa Mattei nell’introduzione all’edizione italiana –, che si muove su più dimensioni nel tentativo, apertamente dichiarato, di correlare “pratiche” apparentemente contrastanti: rule of law e “saccheggio”. Cosa potrebbe esserci di più inappropriato del tentativo di accomunare la dimensione del diritto, nelle forme in cui si è affermato nella costellazione Occidente, ed una prassi che evoca modalità d’azione “barbare” che parrebbero consustanziali all’assenza di norme o alla loro violazione? Tanto più se la critica viene mossa dall’interno del diritto, da un giurista e da un’antropologa del diritto. Eppure Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali è un “esperimento”che ruota attorno a questo binomio, inscindibile secondo gli autori, che legge le trasformazioni socio-economiche, giuridiche e politiche mondiali, dalla “scoperta” delle Americhe alle enclosures, sino all’odierna, precaria, globalizzazione neoliberista, alla luce dell’affermazione del rule of law, cogliendo in quest’ultimo una condizione essenziale per la privatizzazione delle risorse comuni e la conseguente “costruzione” di rapporti sociali “naturalmente” asimmetrici, gerarchici. Ecco, un indicatore attestante l’originalità di questo studio (pubblicato, con non poche difficoltà, in inglese nel 2008 ed ora in uscita in diverse lingue) è deducibile dalla riformulazione estensiva del lessico utilizzato: una parola-chiave come “saccheggio” assume un significato tutt’altro che limitato ad una azione precisa come ad esempio “la sistematica appropriazione delle cose trovate nel territorio nemico propria della soldataglia”, sino ad inquadrarsi “come iniqua ripartizione di risorse comuni garantita dal diritto a favore dei forti e a danno dei deboli, come nel caso di un agricoltore che non ha più alcun diritto “legale” ad usare le sementi utilizzate per secoli dai suoi antenati” (pp. 2-3). Se è questo il nuovo significato di “saccheggio” una storia del regime di legalità, come momento di scissione tra diritto e politica, in cui subentra il governo delle leggi al governo (arbitrario) degli uomini, impone necessariamente una lettura inedita dei processi di trasformazione globali. Mattei e Nader, nel ripercorrerne la genealogia, procedono ad una prima demarcazione tra rule of law e “democrazia”. Il primo nasce per sottrazione – il richiamo nel testo è a Sir Edward Coke, tra i principali giudici di common law ed il primo ad usare il concetto di regime di legalità per escludere la partecipazione regale dalle decisioni dei tribunali di common law –, ed ha come effetto la produzione di un ambito “autonomo”, retto da figure specifiche (i giuristi). Tuttavia si tratta di un processo storico non “neutrale”: la rivendicazione di un’autonomia giurisdizionale dei tribunali di common law troverà i propri alleati nella nobiltà rappresentata in Parlamento e in questi ultimi una reazione ai tentativi di modernizzazione avviati dalla monarchia inglese a partire da Enrico VIII. È dunque fuorviante pensare ad un legame originario tra regime di legalità e democrazia, a meno che non si voglia dipingere come democratico il Parlamento inglese dell’epoca, come ci dicono gli autori (p. 4) e, quand’anche si trattasse di un organo elettivo come il Congresso americano, le tesi di James Madison a sostegno di un equilibrio dei poteri sono subordinate al mantenimento di una distribuzione diseguale delle risorse, nient’altro che un argine contro la potenziale tirannide della maggioranza. È assai più plausibile rimarcare la connotazione classista del regime di legalità, la matrice proprietaria che lo informa. La “democrazia” in questi termini non sarebbe altro che un regime a variabilità limitata in cui le stesse politiche di redistribuzione delle risorse (le esperienze socialdemocratiche più avanzate, per tacere dei socialismi “ir-reali”) rappresenterebbero degli “accidenti” congiunturali, passibili di essere continuamente revocati. Una condizione, quella attuale, che Alain Badiou definirebbe capital-parlamentarismo e negazione della verità della politica, per sua natura slegata da ogni formazione statuale; e Jacques Rancière, non meno criticamente, inquadrerebbe come a dominante oligarchica, con un gruppo ristretto che regna legalmente in nome del popolo, in contrapposizione alla prassi democratica, irriducibile ad ogni forma di governo, in quanto “fondamento egualitario e tendenzialmente anarchico su cui si fonda ogni vera politica” in continua tensione con gli ordinamenti esistenti (Rancière 2007).
Il testo di Ugo Mattei e Laura Nader è innanzitutto un dispositivo teorico potente e non convenzionale. Un’elaborazione critica, una pars destruens – come precisa Mattei nell’introduzione all’edizione italiana –, che si muove su più dimensioni nel tentativo, apertamente dichiarato, di correlare “pratiche” apparentemente contrastanti: rule of law e “saccheggio”. Cosa potrebbe esserci di più inappropriato del tentativo di accomunare la dimensione del diritto, nelle forme in cui si è affermato nella costellazione Occidente, ed una prassi che evoca modalità d’azione “barbare” che parrebbero consustanziali all’assenza di norme o alla loro violazione? Tanto più se la critica viene mossa dall’interno del diritto, da un giurista e da un’antropologa del diritto. Eppure Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali è un “esperimento”che ruota attorno a questo binomio, inscindibile secondo gli autori, che legge le trasformazioni socio-economiche, giuridiche e politiche mondiali, dalla “scoperta” delle Americhe alle enclosures, sino all’odierna, precaria, globalizzazione neoliberista, alla luce dell’affermazione del rule of law, cogliendo in quest’ultimo una condizione essenziale per la privatizzazione delle risorse comuni e la conseguente “costruzione” di rapporti sociali “naturalmente” asimmetrici, gerarchici. Ecco, un indicatore attestante l’originalità di questo studio (pubblicato, con non poche difficoltà, in inglese nel 2008 ed ora in uscita in diverse lingue) è deducibile dalla riformulazione estensiva del lessico utilizzato: una parola-chiave come “saccheggio” assume un significato tutt’altro che limitato ad una azione precisa come ad esempio “la sistematica appropriazione delle cose trovate nel territorio nemico propria della soldataglia”, sino ad inquadrarsi “come iniqua ripartizione di risorse comuni garantita dal diritto a favore dei forti e a danno dei deboli, come nel caso di un agricoltore che non ha più alcun diritto “legale” ad usare le sementi utilizzate per secoli dai suoi antenati” (pp. 2-3). Se è questo il nuovo significato di “saccheggio” una storia del regime di legalità, come momento di scissione tra diritto e politica, in cui subentra il governo delle leggi al governo (arbitrario) degli uomini, impone necessariamente una lettura inedita dei processi di trasformazione globali. Mattei e Nader, nel ripercorrerne la genealogia, procedono ad una prima demarcazione tra rule of law e “democrazia”. Il primo nasce per sottrazione – il richiamo nel testo è a Sir Edward Coke, tra i principali giudici di common law ed il primo ad usare il concetto di regime di legalità per escludere la partecipazione regale dalle decisioni dei tribunali di common law –, ed ha come effetto la produzione di un ambito “autonomo”, retto da figure specifiche (i giuristi). Tuttavia si tratta di un processo storico non “neutrale”: la rivendicazione di un’autonomia giurisdizionale dei tribunali di common law troverà i propri alleati nella nobiltà rappresentata in Parlamento e in questi ultimi una reazione ai tentativi di modernizzazione avviati dalla monarchia inglese a partire da Enrico VIII. È dunque fuorviante pensare ad un legame originario tra regime di legalità e democrazia, a meno che non si voglia dipingere come democratico il Parlamento inglese dell’epoca, come ci dicono gli autori (p. 4) e, quand’anche si trattasse di un organo elettivo come il Congresso americano, le tesi di James Madison a sostegno di un equilibrio dei poteri sono subordinate al mantenimento di una distribuzione diseguale delle risorse, nient’altro che un argine contro la potenziale tirannide della maggioranza. È assai più plausibile rimarcare la connotazione classista del regime di legalità, la matrice proprietaria che lo informa. La “democrazia” in questi termini non sarebbe altro che un regime a variabilità limitata in cui le stesse politiche di redistribuzione delle risorse (le esperienze socialdemocratiche più avanzate, per tacere dei socialismi “ir-reali”) rappresenterebbero degli “accidenti” congiunturali, passibili di essere continuamente revocati. Una condizione, quella attuale, che Alain Badiou definirebbe capital-parlamentarismo e negazione della verità della politica, per sua natura slegata da ogni formazione statuale; e Jacques Rancière, non meno criticamente, inquadrerebbe come a dominante oligarchica, con un gruppo ristretto che regna legalmente in nome del popolo, in contrapposizione alla prassi democratica, irriducibile ad ogni forma di governo, in quanto “fondamento egualitario e tendenzialmente anarchico su cui si fonda ogni vera politica” in continua tensione con gli ordinamenti esistenti (Rancière 2007).
Per Mattei e Nader gli assunti di fondo del regime di legalità sono dunque gli stessi di un’economia di mercato, sintetizzabili nella tutela degli obblighi contrattuali e dei diritti di proprietà dall’intervento statale. Diritti negativi a cui corrisponde la necessità di vincolare chi governa, in quanto l’umanità è “corruttibile” (nel senso in cui lo intendeva la scuola di pensiero sviluppata dai giuristi gesuiti a Salamanca nel XV e XVI secolo) e solo il potere delle leggi (astratte, impersonali e dunque giuste) può porvi rimedio. Il regime di legalità diventa “un fattore che conferisce legittimità allo Stato” (p. 7) e, nel contempo, è rappresentato anche oggi come un tratto distintivo dell’“Occidente”.
In tal senso, si chiedono gli autori, quali relazioni si imporranno con l’altro da sé se non di tipo escludente? Quanto si è effettivamente disposti a conoscere degli altri assetti sociali senza rapportarli automaticamente alla propria, indiscussa, scala valoriale? E quale incontro è possibile considerando che nel passaggio da un approccio formalistico ad uno realistico del diritto, equivalente ad una perdita di “autonomia” e ad uno schiacciamento sulle performance di governo, e dalla sussunzione del diritto nel paradigma economicistico-efficientistico si è perso ogni suo “ruolo normativo e assiologico” […] che non sia una filosofia di governance minimale e reattiva” (p. 108)? La de-politicizzazione del diritto, trasformato in “tecnologia universale” implementabile da specifici addetti, in particolare i grandi studi legali “usati” dalle corporation come agenzie di sviluppo in base ad una concezione imperiale del diritto internazionale, promuove un ulteriore strabismo nel rapporto con gli Stati extraoccidentali (gli autori si riferiscono in particolar modo all’eterogeneo Medio Oriente islamico e alla Cina). Questi sono oggetto di un’interessata e caricaturale “valutazione”, non lontana, ad esempio, dalla lettura che Max Weber dava del qadi (il giudice islamico) che si affiderebbe a giudizi informali nell’amministrazione della giustizia. Il risultato è una forma di “orientalismo giuridico”, a cui tuttavia occorre sottrarre una prospettiva di relativismo assoluto.
Gli altri assetti sociali risulterebbero dunque privi di un vero sistema giuridico, bisognosi di un intervento di civilizzazione, che dovrebbe concretizzarsi nell’esportazione (legittimando guerre, genocidi, saccheggi… di cui Afghanistan e Iraq sono solo l’ultimo esempio) del modello giuridico e politico occidentale, dimenticando, tra l’altro, che ogni formazione sociale ha una sua specificità storica (e non storicistica), presentandosi come un “tutto strutturato” da cui non è lecito tagliare delle parti (ritenute inefficienti o anti-moderne secondo la suddetta scala valoriale) e sperare di innestarne delle nuove senza generare conflitti incontrollabili. Potremmo dire che non si dà alcuna coupe d’essance – per riprendere una tesi cara a Louis Althusser – capace di orientare un sviluppo progressivo della storia. Ciò implicherebbe una concezione contestualmente vuota ed omogenea del tempo storico – costellata di ritardi da colmare “per chi è rimasto indietro” – riesumando, di fatto, un approccio integralmente neocolonialista che un autore postcolonial come Dipesh Chakrabarty ha letto nei termini di un conflitto tra tempo del “lavoro vivo” e tempo del “lavoro astratto” (Chakrabarty 2004).
L’intento degli autori consiste dunque nel decostruire il rapporto alienato tra regime di legalità e democrazia – concatenando il primo con il dominio politico perpetrato dall’Occidente –, e nel far emergere la parzialità del rule of law egemone (equivalente all’ordine unipolare incentrato sugli Usa), la funzione legittimante che ha svolto, e tutt’ora ricopre, nel determinare il saccheggio dalla fase coloniale a quella post-coloniale. In effetti la decolonizzazione non ha modificato i rapporti asimmetrici tra “centro” e “periferia”: il prestigio di cui gode il sistema giuridico euro-americano, imitato ed introdotto consensualmente dai paesi “recettori” e, soprattutto, le politiche “condizionali” di aggiustamento strutturale, beffardamente ribattezzate di “sviluppo partecipato”, cioè la richiesta di apertura unilaterale dei loro territori al mercato e il contestuale ridimensionamento di un ruolo attivo dello Stato in ambito economico, sono i principali dispositivi che rendono nominale la condizione post-coloniale e “vuota” la sovranità che vi si esercita. Come affermano gli autori, in particolar modo dopo la “rivincita” neoliberista, vero motore economico dell’attuale saccheggio (paradigmaticamente riassunta nel “collasso” argentino), che ha svuotato il welfare state saldamente circoscritto ai confini europei (e in parte americani), “un potere morbido è molto più efficiente” di un’occupazione militare o della semplice azione di propaganda e ciò spiega il formale anticolonialismo americano e la contestuale strategia di “prossimità”, di efficace penetrazione nei mercati dei paesi “non occidentali” grazie alla “messa in atto di apparati ideologici” persuasivi (non ultimo la proprietà intellettuale, il suo carattere individualistico che “affetta” ambiti potenzialmente comunitari come Internet), capaci di rendere credibili “le promesse di civilizzazione, ricchezza, sviluppo e liberazione” (p. 90). Non c’è dominio senza la seduzione del medesimo e persino la volontà di rimanerne sedotti, soprattutto se una parte minoritaria dei dominati – le élite politiche e intellettuali autoctone – diventa complice o appendice dei dominatori, traendone cospicui vantaggi, ed interpretando un ruolo essenziale nella nuova governance sovranazionale incentrata sulle istituzioni di Bretton Woods (Fmi e Banca Mondiale) ed attuata da soggetti come Wto e G8, politicamente irresponsabili.
Eppure, come ci spiegano gli autori, il regime di legalità non è ad una dimensione. In esso, la legittimazione, storicamente preponderante, del saccheggio, ha avuto momenti di resistenza, generando un potenziale contro-egemonico ad opera dei popoli colonizzati. Per cui, ad esempio, l’istituzione di tribunali in ambito coloniale ha permesso la rivendicazione in contraddittorio dei propri diritti. In particolare le donne hanno potuto svincolarsi, almeno in parte, da un regime patriarcale. Tuttavia si tratta di eventi inattesi, indesiderati ed osteggiati da chi ha implementato un regime di legalità. La duplicità e contraddittorietà del rule of law rimane un dato strutturale: capace di produrre contropoteri a cui i “colonizzatori” rispondono con un’attenuazione del ricorso in contraddittorio attraverso dispositivi come l’Alternative dispute resolution (Adr) e l’appello alla costruzione di una società più armoniosa. In particolare, secondo gli autori, nella successione dal colonialismo europeo all’affermazione dell’egemonia americana sono state prodotte strategie di dominio diversificate e complesse con finalità precise: dalla dottrina Monroe che ha sottomesso l’America Latina agli Usa (sino a produrre il sostegno diretto alle dittature fasciste), all’azione del movimento law and development che ha alimentato il “bisogno” di un regime di legalità da esportare – enfatizzando la diffusione e specializzazione di professionisti del diritto intesi come ingegneri sociali operanti in un sistema, quello americano, decentralizzato e organizzato per proteggere i diritti di proprietà –, il risultato si è sempre condensato principalmente in pratiche di saccheggio corrispondenti all’apertura di mercati e alla produzione di profitti per le grandi corporation. Un ruolo dirimente è stato giocato dall’identificazione di economia (capitalistica) e diritto liberale tramite la nozione (pseudo)oggettiva di efficienza che li congiungerebbe.
In questo quadro la “frattura” prodotta dall’11 Settembre 2001, il processo di smantellamento, non privo di consensi, del rule of law statunitense, e il contestuale uso legittimante della “guerra al terrorismo” per compensare l’elezione, legalmente a dir poco discutibile, del presidente George W. Bush, ha estremizzato una tendenza profonda degli ordinamenti statuali ritenuti “più evoluti”: il consolidamento di uno statalismo autoritario, i cui tratti distintivi si evincono nel rafforzamento degli esecutivi, nella personalizzazione della politica, nella produzione di ideologie securitarie (e razziste) e nell’antistatalismo liberista. Un’interpretazione, quest’ultima, desunta dagli ultimi scritti degli anni Settanta, mai così attuali, di Nicos Poulantzas recentemente pubblicati a cura di Enrico Melchionda (2009).
Tuttavia, si chiedono gli autori, è possibile superare la configurazione attuale del regime di legalità? Vi è in esso un’eccedenza teorica e pratica da rielaborare, un mutamento di segno operabile, considerando il carattere anche contro-egemonico che lo ha contraddistinto? Inoltre, non è forse vero, almeno a partire dal XIX secolo, che il diritto è stato pensato come antagonista della “forza bruta” (p. 219)? Essi concludono che ad un regime di legalità imperiale (e di fatto illegale) occorre contrapporre un regime di legalità popolare. Un assetto che decostruendo la presunta apoliticità del diritto vi ponga alla base un criterio di giustizia sociale, che si fondi “sui bisogni delle popolazioni” e che sia “capace di resistere al “professionalismo” chiuso sui propri interessi, all’imperialismo e alla depoliticizzazione”, sostenendo “i beni comuni nell’interesse comune” (p. 220), universalizzando diritti come la scolarizzazione, la sanità, un’abitazione dignitosa, l’acqua pulita.
Dove rintracciare esperienze embrionali di questo tipo se non nelle “democrazie locali”, ad ogni latitudine, in cui le popolazioni sono impegnate nella difesa e ri-appropriazione delle risorse comuni (lungo direttrici che superano la semplice dicotomia pubblico-privato) e dunque nella trasformazione attiva dei sistemi giuridici locali, tutt’altro che immobili, in permanente tensione con il diritto statale e internazionale? Che si tratti dei contadini messicani della Sierra Madre impegnati contro lo sfruttamento delle proprie miniere o dei movimenti della Val di Susa che si oppongono alla costruzione di un tunnel attraverso le Alpi, per non parlare delle municipalità autonome zapatiste, ciò che diventa centrale nelle pratiche partecipative che vengono attivate è la conoscenza e la sua socializzazione (anche grazie ad un uso alternativo di Internet), così come la qualità del processo decisionale che, secondo gli autori, tende a produrre scelte fondate sul senso di equità, incentivando la costruzione di reti comunitarie “mobili” che trasformano e rimodulano i sistemi giuridici locali. Su questo aspetto la dialettica tra democrazia rappresentativa e partecipativa andrebbe perlomeno rivisitata criticamente, come proposto da alcuni studi recenti (in particolare Sintomer 2009).
È evidente, ammettono Mattei e Nader, che senza una discontinuità culturale e politica diffusa e strutturata non si potrà porre fine al “saccheggio”, né vi è possibilità di successo senza riconsiderare criticamente il fantasmagorico “regno dell’individuo”, accecato, nelle esigue porzioni di mondo “privilegiate”, dall’insostenibile circolo consumistico, in fuga dall’alterità e dalle condizioni “naturali” della sua esistenza. In tal senso una rilettura di Spinoza nella misura in cui nell’Ethica ha pensato una “strategia di affermazione amorosa della moltitudine” asserendo che “la soggettività è data nella misura in cui si scopre funzione di una rete complessa di legami che ci fa vivere nell’ottica dell’interdipendenza, nella consapevolezza del limite e nella potenzialità di un’esistenza condivisa” (Di Benedetto 2009), equivale alla riscoperta di una “risorsa occidentale” oltremodo rimossa, la cui potenza ci pare che sia ancora tutta da dispiegare.
Bibliografia
Chakrabarty D.
2004 Provincializzare l’Europa, Roma, Meltemi.
Di Benedetto G.
2009 L’ecologia della mente nell’Etica di Spinoza. Amore della natura e coscienza globale sulla via della complessità, Mimesis, Milano-Udine.
Poulantzas N.
2009 Il declino della democrazia, a cura di E. Melchionda, Mimesis, Milano-Udine.
Rancière J.
2007 L’odio per la democrazia, Napoli, Cronopio.
Sintomer Y.
2009 Il potere al popolo. Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa, Bari, Dedalo.


